In quel meraviglioso libro che è “La lingua salvata” di Elias Canetti, c’è un lontano ricordo d’infanzia. In quella città sul Danubio in cui “in un solo giorno si potevano sentire sette od otto lingue”, un vicino di casa si avvicina al piccolo Elias e gli dice: mostrami la lingua che te la taglio. Il bambino apre la bocca. Il vicino sorride, non procede al supplizio.
Quando, più di venti anni fa, sono venuto a vivere a Parigi, ho avuto, per un po’ di tempo, paura di perdere la mia lingua, di allontanarmene. Difficile parlarne con qualcuno. I pragmatici-efficientisti sorridevano: parli già bene il francese, non sarà certo un ostacolo! (Ma non era quello il punto: sostituire una lingua a un’altra, significa forse guadagnare un mondo, ma anche perderne un altro. Il proprio). I casi più acuti di cretinismo modernista sentenziavano: ma l’italiano è una lingua provinciale, a cosa ti serve? Semmai è l’inglese, la lingua globale. Qualcuno invece sorrideva e non parlava: segno di silente comprensione. Lawrence d’Arabia diceva: chi parla più lingue, perde la sua anima.
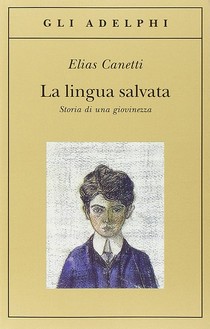 Un giorno quel temuto colpo di forbice si materializzò in un barattolo. Lo guardavo, e nella mia mente quella verdura sott’aceto corrispondeva a una parola: cornichons. Ma in italiano? Come cavolo si dice? Secondi di panico. Poi la parola riemerse. Cetrioli, o cetriolini. Che felicità, riafferrare il cetriolo! (Astenersi spiritosoni e perditempo). C’era un senso, in quella storia apparentemente insensata: il taglio della lingua di cui parla Canetti è, come è ovvio, una castrazione. Il cetriolo è assimilabile a un (modesto) simbolo fallico. Il lapsus e il successivo recupero (lingua perduta, lingua salvata) non potevano quindi materializzarsi che davanti a una cosa di quel genere.
Un giorno quel temuto colpo di forbice si materializzò in un barattolo. Lo guardavo, e nella mia mente quella verdura sott’aceto corrispondeva a una parola: cornichons. Ma in italiano? Come cavolo si dice? Secondi di panico. Poi la parola riemerse. Cetrioli, o cetriolini. Che felicità, riafferrare il cetriolo! (Astenersi spiritosoni e perditempo). C’era un senso, in quella storia apparentemente insensata: il taglio della lingua di cui parla Canetti è, come è ovvio, una castrazione. Il cetriolo è assimilabile a un (modesto) simbolo fallico. Il lapsus e il successivo recupero (lingua perduta, lingua salvata) non potevano quindi materializzarsi che davanti a una cosa di quel genere.
Quelle due lingue sorelle, francese e italiano, per un breve tempo rivali, in competizione sullo stesso spazio, hanno poi imparato a convivere. Per me il francese è divenuto un confortevole rifugio, anche grazie alla sua caratteristica onirica di mormorio in cui alle labbra, per parlare, è richiesto di socchiudersi così poco. La lingua italiana ha invece acquisito una maggiore acutezza, come se una distanza dal loro uso quotidiano desse alle parole un nitore particolare, in cui ogni cosa è illuminata dalle vocali e dal fluttuare degli accenti, da quell’alternanza tra parole piane, sdrucciole, e tronche che suscita nei francesi, quando ascoltano l’italiano, l’impressione del canto. In quel senso anche io, come Elias Canetti bambino, sono sfuggito alle forbici a cui avevo spalancato la bocca. Ma in questi vent’anni ho avuto l’impressione che il linguaggio, sia in Italia sia in Francia (immagino anche altrove) si sia fortemente impoverito. Il vocabolario Zanichelli contrassegna, con un piccolo fiore, tremila parole che stanno scomparendo per mancanza d’uso. Parole desuete (ecco, appunto, uno di quei termini).
Se dite a qualcuno di non adombrarsi, è probabile che non capisca e si incupisca. Se rimproverate qualcuno per la sua spocchia, probabilmente non servirà aiutarsi con i sinonimi albagia, alterigia, altezzosità, boria; passerete per un presuntuoso. Ho usato con qualcuno (in Italia) la parola contumelie. Mi ha guardato come se avessi pronunciato un’ingiuria. Inutile chiedere ai vostri interlocutori se sono avvezzi; a certe parole non sono più abituati. E se usate il termine icastico vi diranno di parlare in modo più incisivo ed efficace. Senza parlare dell’incredibile, insopportabile provincialismo italiano che porta a usare parole inglesi, per darsi delle arie, e spesso a sproposito, al posto dei termini italiani.

Quanto al francese, la caduta della ricchezza lessicale è almeno altrettanto vertiginosa. Molte conversazioni sono fatte quasi esclusivamente di “en fait” e “du coup”. Espressioni che hanno quasi perduto il loro significato originale (“in realtà”, e “di conseguenza”) per diventare tic linguistici. Secondo il giornale Le Figaro, “du coup” ha sostituito nella lingua orale “puisque», «étant donné que», «en raison de», «dans la mesure où», «en revanche», «cependant», «néanmoins», «d’autre part», «bien que», «en admettant que», «à condition que», «dans le but de», «afin de», «en vue de”, e l’elenco potrebbe continuare. Per non parlare della terrificante trinità “truc-bidule-machin” (cosa-aggeggio-marchingegno), adesso forse leggermente in declino (per grazia del Signore), che per anni ha sostituito la maggior parte dei termini (come fu in Italia con la parola “coso”, a volte usata anche per le persone: “ho parlato con coso”…).
La lingua (ogni lingua) è un mondo. E quando le parole si riducono, e il nostro parlare diventa ripetizione di poche frasi fatte, è il mondo a ridursi a poca cosa o niente. Umberto Galimberti dice che i ragazzi italiani oggi conoscono e usano circa 300 parole. Un ragazzo delle scuole medie negli anni Settanta, secondo il linguista Tullio de Mauro, ne conosceva circa 1600. La mia lingua forse si è salvata, come quella (quelle) di Elias Canetti. Ma forse le nostre lingue, nel frattempo, si sono perdute: siamo rimasti (letteralmente) senza parole.
Maurizio Puppo







































Molto interessante l’articolo di Maurizio Puppo, in difesa delle nostre lingue, l’italiano e il francese che nel tempo hanno imparato a convivere ma, contemporaneamente, si sono impoverite e siamo rimasti « senza parole ».
Sollecitante « La lingua salvata » di Elias Canetti che mi propongo di leggere.
Grazie all’autore di questa riflessione e ad Altritaliani, augurando a tutti Buone Vacanze!
Cordiali saluti
Rosella Centanni
Grazie Rosella
UNA LINGUA E UN’IDENTITÀ ALLA DERIVA
Secondo me, l’approdo in un mondo estraneo alla propria cultura d’origine può costituire uno sprone ad intraprendere studi linguistici e culturali comparati, ed accresce in genere le capacità comunicative dell’individuo; il quale si trova confrontato alla cultura maggioritaria della società e alle tante culture degli immigrati come lui, provenienti da altri paesi.
Il raffronto tra la lingua italiana e le due lingue ufficiali del Canada mette in evidenza l’incertezza cui spesso siamo confrontati quando parliamo o scriviamo nella nostra lingua madre. E ciò perché la ricchezza dell’italiano è data soprattutto da una ridondanza di varianti di forma dello stesso termine o sintagma: familiare-famigliare; sino a-fino a; dinnanzi-dinanzi-innanzi; in seguito a-a seguito di; sotto il tavolo-sotto al tavolo; insieme-assieme; devo-debbo; musulmano-mussulmano; perso-perduto; anglismi-anglicismi-inglesismi; rinunciare-rinunziare, ecc. L’importazione frenetica di doppioni inglesi non fa che aggiungere ridondanza a ridondanza. “What a pity!” diranno gli anglofoni. E altrettanto efficacemente noi diremo ma in italiano, finché ci sarà permesso, “è un vero peccato!”
L’italiano è una lingua obesa a causa di questo accumulo di parole interscambiabili. Tale ricchezza di varianti gonfia i nostri dizionari, che appaiono invece un po’ miseri quanto all’assenza degli equivalenti di certi termini che rendono il francese o l’inglese una lingua, in genere, più ricca e precisa. In italiano, ad esempio, vi è un unico vocabolo “polvere » mentre il francese ha poudre e poussière, e l’inglese ha dust e powder. Il francese ha entre e parmi, e l’inglese among e between, mentre la nostra lingua ha semplicemente tra e fra, interscambiabili. L’italiano ha solo carne, mentre il francese ha chair e viande, e l’inglese meat e flesh. Per gli animali, l’inglese ha talvolta due termini distinti a seconda che si designi la bestia « da macello » divenuta cibo per noi, o invece l’animale di per sé. Ad esempio, la parola beef designa carne di “cow, bull, or ox, used as food”.
Aprendo un dizionario della lingua italiana troviamo, alla parola “nipote”, più o meno la seguente spiegazione: « Figlio del figlio o della figlia, oppure del fratello o della sorella. (Lo stesso nome esprime quindi due relazioni di parentela molto diverse, nel primo caso l’ascendente è il nonno o la nonna, nel secondo caso l’ascendente è uno zio o una zia)”.
Incredibile ma vero: nella gloriosa lingua di Dante e di Manzoni c’è un solo termine, un solo singenionimo (“nome che esprime un rapporto di parentela”), per identificare due « entità » umane ben distinte: il figlio del figlio, e il figlio del fratello, ossia il “nipote di nonno” e il “nipote di zio”.
Per una elementare necessità di chiarezza, al contrario dell’italiano le altre lingue hanno due termini distinti. In lingua spagnola: “sobrino” e “nieto”. In francese, “neveu” (“nièce”) e « petit-fils » (“petite-fille”), (« petit-enfant »). In inglese, “nephew” (“niece”) e « grandchild » (« grandson »), (granddaughter).
Il termine unico “nipote” crea confusione. Ma ciò non sembra inquietare gli italiani, amanti innanzitutto del “suona bene”. Nipote non solo “suona bene”, ma grazie a questo vocabolo unico le parole “nipote” e “nipoti” risuonano un po’ più spesso nelle bocche degli appartenenti a un popolo che ha quasi il record mondiale della denatalità. Tutto fa brodo, insomma
Angolo in francese può essere reso con angle e con coin. In inglese abbiamo angle e corner. In italiano abbiamo angolo, unico termine.
« Older » dicono gli anglofoni, « plus âgé » dicono i francofoni. E noi italofoni come diciamo? Diciamo « più grande ». Ma grande è un termine ambiguo che non dà immediatamente l’idea del “più anziano, più vecchio” termini quest’ultimi che mal si adattano ad indicare una differenza di età tra due bambini.
Tanto in francese quanto in inglese, non c’è alcun pudore a usare il pronome personale di prima persona singolare: “je”, “I”, mentre in italiano solo ai superuomini e ai megalomani è permesso, nelle frasi scritte, un frequente uso esplicito di “io”. I pronomi personali di terza persona, maschile e femminile, non si sa esattamente quali siano: egli, lui, esso, essa, ella, lei, essi, esse, loro? Dipende dallo stile, dal « suona bene », e da tanti altri motivi che né il francese né l’inglese conoscono. E che dire dello spagnolesco Lei, al posto del tanto più logico e autoctono Voi? Meglio non dire nulla perché altrimenti si rischia di essere accusati di fascismo.
All’Accademia della Crusca è stato rivolto il quesito: come rendere in italiano il termine inglese “to scan”? La risposta della Crusca: « massima libertà di scelta circa l’uso di scandire, scannare, scannerizzare, e anche eseguire una scansione e scansionare ». Quelli della Crusca ci dicono in sostanza: fate come volete. Io vorrei invece che questa istituzione avesse un ruolo meno passivo e contemplativo. Mi piacerebbe che svolgesse un ruolo alla francese, insomma. Ma so bene che forse non c’è una sola persona nella penisola che non si faccia regolarmente beffe del cosiddetto sciovinismo della « Académie Française » e degli altri organismi dell’Esagono preposti alla difesa della lingua nazionale. Funzione che io considero invece ammirevole.
Il qualunquismo della Crusca dà un contributo dannoso a un certo stato confusionale della lingua italiana, la quale vanta pagine di dizionari strapiene di varianti di forma di questo o quel termine, come ad esempio obbediente-ubbediente-ubbidiente considerati uguali-eguali, mentre è una lingua che presenta tante lacune. Molte delle quali sono dovute anche alla rimozione di termini che “non suonano bene”, come certe forme verbali eliminate dall’uso per la loro presunta cacofonia.
Il crescente uso di termini inglesi riduce ancor di più la ricchezza e la varietà della nostra lingua, nella quale sempre più di frequente termini validissimi vengono rimpiazzati da parolette americane, comicamente pronunciate. L’ossessione del « Suona bene? Suona male? » tiranneggia gli italiani, pieni di idiosincrasie in fatto di pronunce e di accenti, ma dalle cui strozze fuoriescono, purtuttavia, gli sgangherati suoni dei termini inglesi (anglismi/anglicismi/inglesismi) esproprianti gli autarchici termini del nostro vocabolario. « Killer » ha eliminato d’un sol colpo i nostri quattro validissimi “uccisore, assassino, omicida, sicario”. Per noi, nostalgici del bagnasciuga, non è facile accettare il luttuoso evento che ha visto il vecchio assassino, alias omicida, del codice Rocco tirare le cuoia e tramutarsi a guisa di zombie in killer. Che a sua volta ha figliato un ributtante killeraggio. Flop ha rimpiazzato fiasco; jackpot è usato al posto di montepremi; supporter ha preso il posto di tifoso; il cartellino da timbrare al lavoro è divenuto un badge; il restyling è termine che non fa parte del gergo di parrucchieri sdilinquiti e con l’erre moscia, ma di vigorosi asfaltatori di strade con il volto bruciato dal sole. “Napoli. Piazza Carlo III, via al restyling. I residenti: restituiteci aiuole e giardini”. “Al via il restyling delle strade cittadine”.
Occorrerebbe un po’ di restyling anche per la lingua italiana, affinché si riduca questa inutile obesità di forme e se ne protegga la ricchezza, riesumando certi termini molto precisi di un tempo, finiti purtroppo nel dimenticatoio, e soprattutto riducendo il flusso ininterrotto di anglicismi e pseudo anglicismi usati al posto di valide parole italiane.
Tutto da rifare! Esclamerebbe Bartali. Che fiasco! direbbe Coppi. Ma pochi italiani oggi capirebbero il significato di fiasco al posto di quel flop di cui l’Italia intera va così fiera.