Dossier tematico “Leonardo Sciascia 30 anni dopo”. Un contributo di Lise Bossi (Università Paris-Sorbona).

Nella prefazione aggiunta undici anni dopo (1967) a Le parrocchie di Regalpetra del 1956, Sciascia scrive: «Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno: un libro sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del presente». Un’affermazione che prende una tutt’altra dimensione se avvicinata a quella fatta a Marcelle Padovani nel 1979: «La Sicilia offre la rappresentazione di tanti problemi, di tante contraddizioni, non solo italiani, ma anche europei, al punto da poter costituire la metafora del mondo odierno»[1].
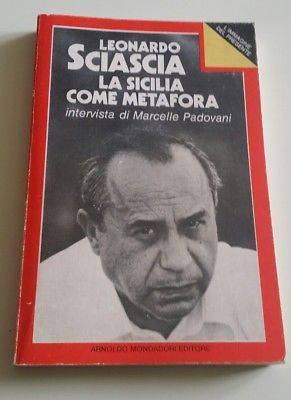 Per Sciascia scrivere significa quindi leggere il mondo attraverso il prisma della Sicilia e riconoscere nell’andamento del mondo i segni precursori della generalizzazione della condizione siciliana, cioè di un caos esistenziale, morale e politico che assurge a sistema di vita e di governo su sfondo di doppie verità e sdoppiamenti pirandelliani.
Per Sciascia scrivere significa quindi leggere il mondo attraverso il prisma della Sicilia e riconoscere nell’andamento del mondo i segni precursori della generalizzazione della condizione siciliana, cioè di un caos esistenziale, morale e politico che assurge a sistema di vita e di governo su sfondo di doppie verità e sdoppiamenti pirandelliani.
Come sempre, dice Sciascia nel prologo de L’affaire Moro, questi segni precursori si sono visti prima nella lingua: quella lingua del non-dire propria della retorica del potere, nata nel momento della pasoliniana scomparsa delle lucciole[2], e destinata a preservare quello che le BR, usando e abusando dell’opposta e non meno vuota retorica pseudo-marxista, chiamavano il SIM, lo Stato imperialista delle multinazionali.
Se il potere inventa questa nuova retorica proprio allora, è per nascondere la sua definitiva e totale conversione a quel sistema di performatività economica e comunicazionale proprio della condizione postmoderna quale viene definita da Jean-François Lyotard nel 1979[3].
Per Sciascia scrittore, una tale conversione ha una doppia conseguenza : grazie a questo sistema, il potere può prendere il controllo delle Storie o Grandi Narrazioni consensuali dell’agonizzante cultura moderna finendo di delegittimarle con assiomi e sillogismi, cioè jeux de langage appunto[4]; la seconda, che dalla prima deriva, è che il nuovo linguaggio performativo sostituisce il linguaggio usato fino allora per la grande narrazione razionale e totalizzante dell’età moderna, il che permette al potere di contaminare con le sue menzogne e manipolazioni perfino i tentativi di elaborare delle contro-storie suscettibili di ripristinare verità e giustizia, sia «nello spazio quotidiano» che in letteratura.
L’esame anche solo superficiale dell’evoluzione della produzione letteraria di Sciascia permette di confermare che lo scrittore era pienamente consapevole delle poste in gioco e ha reagito cambiando, in maniera via via più radicale, il suo modo di scrivere la realtà e di indagarla grazie a una reinvenzione paradossale della cultura classica[5] e all’uso à contre-emploi degli strumenti propri della post-modernità.
Se schematizziamo e guardiamo alla sola narrativa, lasciando da parte la saggistica, gli esordi letterari di Sciascia si fanno infatti sotto il segno della cultura classica e dei canoni tradizionali con Le favole della dittatura (1950) e la raccolta poetica La Sicilia, il suo cuore (1952) nonché del (neo-) realismo con Le parrocchie di Regalpetra (1956) e Gli zii di Sicilia (1958). Ma negli anni del miracolo economico, con l’avvento della società dei consumi e la delusione delle speranze di cambiamenti socio-politici destate dalla lotta partigiana, cominciano a manifestarsi in Italia i primi segni delle distorsioni performative del linguaggio già presenti in paesi più sviluppati dagli inizi del Novecento. Tale evoluzione spinge Sciascia a sfruttare per oltre un decennio le potenzialità di un genere poco raccomandabile: il giallo. A guisa di giustificazione, dichiara che «Nella sua forma più originale e autonoma, il romanzo poliziesco presuppone una metafisica»[6] cioè offre un garante di Verità e Giustizia che, con la Ragione, diventano i pilastri della resistenza sciasciana alla nuova lingua – neolingua? – del potere; una lingua basata sull’omertà, sul suo corollario la logorrea, e sulla menzogna.

L’evoluzione del giallo sciasciano, concepito come strumento insieme di denuncia e di restaurazione dello Stato di diritto, segna le tappe delle deviazioni successive del potere : Il giorno della civetta (1961) mostra un investigatore, ex-partigiano e « illuminista », vinto dalle collusioni politico-mafiose che un falso verbale ha incrinate solo temporaneamente[7]; l’investigatore dilettante di A ciascuno il suo (1966) muore per scoprire una verità da tutti conosciuta; l’ispettore Rogas de Il contesto (1971) è ucciso da un potere – uno Stato – ormai passato maestro nell’uso del doppio linguaggio e della confusione ideologica. In quanto al narratore di Todo modo (1974), egli decide di « passare dall’altra parte » uccidendo Don Gaetano, il burattinaio che ha saputo travestire e unificare le due grandi narrazioni moderne, quella storico-politica e quella « transumana » della Chiesa, in una specie di «storicismo assoluto»[8] per metterlo al servizio di quelli che «detengono» lo Stato[9].
Come si vede Sciascia ha sovvertito tutti i canoni del genere poliziesco, dalla figura dell’investigatore, all’intreccio e al finale, che non vede quindi mai trionfare verità e giustizia e mette addirittura a repentaglio la ragione stessa, a significare che la nuova lingua che ha permesso quell’operazione di travestimento mina ormai ogni tipo di comunicazione che ricorra a una concatenazione razionale a carattere ipotetico-deduttivo.
Eppure Sciascia non sbagliava nelle sue denunce, come ben dimostrò, a distanza di pochi anni, il caso Moro e gli restò solo da constatare che «Nel vuoto di riflessione, di critica e perfino di buon senso in cui la vita politica italiana si è svolta, le sintesi non potevano apparire che anticipazioni, che profezie; se non addirittura istigazioni. Lasciata, insomma alla letteratura la verità, la verità – quando dura e tragica apparve nello spazio quotidiano e non fu più possibile ignorarla o travisarla – sembrò generata dalla letteratura»[10]. E L’affaire Moro si configura quindi come una specie di spartiacque ad quem e a quo realtà e finzione cambiano segno.
Siccome l’idra del potere rinasce con altre teste e la nuova lingua non finisce mai di ramificarsi al ritmo della complessificazione comunicazionale, Sciascia ricorre allora a un’altra formula, il cui «prototipo, altissimo, resta La storia della Colonna infame», rivisitata sul modello delle « »Inquisiciones » di Borges e [delle] inquisizioni filologiche e critiche di Salvatore Battaglia»[11]. Usandola a modo suo, lo scrittore non si limita a sostituire l’inchiesta poliziesca con quella filologica: attacca la performatività del linguaggio del potere, nato dai dubbi propri della condizione postmoderna, con le armi stesse della postmodernità cioè, tra l’altro, la pluralità dei linguaggi, la moltiplicazione dei punti di vista, la frammentazione dell’informazione e l’organizzazione reticolare del discorso.
Sciascia aveva già sperimentato la formula manzoniana con Morte dell’inquisitore del 1964 riunendo documenti e incrociando fonti per ricostituire la vicenda dell’eretico fra Diego, assassino del proprio inquisitore, e, con impegno diverso ma con identico metodo, egli aveva rinnovato l’esercizio con Atti relativi alla morte di Raymond Roussel del ’71, in cui fin dal titolo relativizza la relazione della vicenda dello stravagante scrittore francese morto a Palermo in circostanze che sembrano ancora più oscure dopo la sua meticolosa indagine. Alla stregua della vicenda del fisico Majorana, la cui scomparsa è oggetto di un’inchiesta dello stesso tipo nel ’75.
Ma il momento in cui lo scrittore adotta il modello manzoniano sovvertendolo con tecniche investigative consapevolmente postmoderne è, per ovvie ragioni, quello in cui scrive L’affaire Moro: per esorcizzare la confusione delle lingue messa in opera dal potere in quel periodo di compromissioni e di compromessi, Sciascia organizza infatti una rete complessa di protezione in cui intesse le riflessioni di Pasolini sulla lingua del non-dire del potere con le dichiarazioni di Moro prima del rapimento e con le sue lettere dopo, i commenti nei giornali degli « amici » del capo della D.C. con i comunicati delle B.R., le voci del vocabolario del Tommaseo con le telefonate dei brigatisti, in un gigantesco cruciverba (questo sarà d’altronde il titolo di una sua raccolta di saggistica del 1983) nel quale il lettore entra convinto che sono le B.R. ad avere ucciso Moro e da cui esce non meno convinto che sono stati gli « amici » del «grande statista» ad averlo condannato a morte.
Per chi ha capito che Sciascia ha cambiato strategia ma ha sempre gli stessi obiettivi, è evidente inoltre che monsignor Ficarra[12] e la sua storia sono l’immagine speculare e rovesciata del don Gaetano di Todo modo, come, paradossalmente, Il contesto e Todo modo sono stati la parodia anticipatrice della vera vicenda di Moro.
La circolazione intratestuale così stabilita attraverso le varie opere dello scrittore non basta ancora: per frammentare il discorso in unità sempre più molecolari[13] e ricostruirlo in modo talmente reticolare da renderlo irrecuperabile da parte del potere, Sciascia crea altre corrispondenze, intertestuali questa volta, tra i suoi libri e quelli degli autori della sua borgesiana biblioteca ideale.
Così avviene ad esempio per la sentenza memorabile (1982), in cui la storia diventata celeberrima del ritorno di Martin Guerre è ricostruita partendo da documenti tratti dagli archivi dell’epoca e da una pagina degli Essais di Montaigne, ovviamente ricollegati con il caso Bruneri-Canella esplorato ne Il teatro della memoria dell’anno prima e, per finire, con il Tom Castro, l’impostore inverosimile di Borges che sembra una parodia insieme del caso Bruneri-Canella e del caso Guerre.
Il guaio è che, per scampare al pericolo del ricupero, Sciascia è incappato in un altro e forse più grave pericolo che è quello dell’incomprensione da parte di un lettorato sempre più efficacemente formattato da tutti i discorsi performativi del potere. Lo scrittore dimostra di esserne consapevole nel suo ultimo romanzo Una storia semplice del 1989 in cui egli, in punto di morte, torna alla forma poliziesca per «Ancora una volta […] scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia»[14] denunciando, sotto il segno di Dürrenmatt e con un’intatta facoltà di anticipazione, uno Stato capace di creare una di quelle che oggi chiamiamo fake news[15], per salvare, ancora una volta, quel sistema politico che solo la fine della Guerra fredda e Mani pulite riusciranno a buttare giù. Solo temporaneamente come dimostrano appunto le innumerevoli fake news che l’iperpotere comunicazionale postmoderno ci somministra con un’efficacia degna delle peggiori distopie orwelliane.
Quanto alle opere di Sciascia, che ancora negli anni novanta riempivano interi scaffali nelle librerie italiane e, forse ancora più significativamente, in quelle francesi, sono quasi scomparse dimostrando che ai «Fatti diversi di storia letteraria e civile» i lettori della società contemporanea hanno imparato a preferire i semplici fatti di cronaca che sono l’unica Storia, sconclusionata, che sia ormai loro raccontata. A confermare che «El sueño de la razon produce monstruos».
Lise Bossi (Università Paris-Sorbona)
[1] Leonardo Sciascia, La Sicilia come metafora [1979], Bestsellers saggi, Milano, Mondadori, 1989, p. 78.
[2] Vedi Pier Paolo Pasolini, « Il vuoto del potere in Italia » ovvero « l’articolo delle lucciole » in « Corriere della Sera », 1 febbraio 1975.
[3] Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Les Editions de Minuit, Paris, 1979, pp. 76-77.
[4] Vedi, ad esempio, quelli usati da Moro per difendere l’onorevole Gui in L. S., L’affaire Moro, Palermo, Sellerio, 1978, p. 103
[5] Vedi F. Moliterni, La nera scrittura, Bari, B. A. Graphis, 2007, p. 49, n. 62.
[6] L.S., Cruciverba, Torino, Einaudi, 1983, p. 218. Vedi anche 1912+1, Milano, Adelphi, 1986, p. 86.
[7] La tentazione di inventare un falso per ristabilire verità e giustizia si troverà infatti anche nell’antiromanzo storico successivo, Il Consiglio d’Egitto del 1963.
[8] L.S., Todo modo, Torino, Einaudi, 1974, p. 48.
[9] Vedi, Id., Il contesto, Torino, Einaudi, 1971, pp. 82-83.
[10] Id., L’affaire Moro, op.cit., p. 28.
[11] Id., La sentenza memorabile, Palermo, Sellerio, 1982, 2a di copertina.
[12] Vedi Id., Dalle parti degli infedeli, Palermo, Sellerio, 1979.
[13] Vedi, Id., L’affaire Moro, op.cit., p. 30.
[14] Id., Una storia semplice, Milano, Adelphi, 1989, p. 7.
[15] Vedi anche la storia dei « figli dell’ottantanove » in Id., Il cavaliere e la morte, Milano, Adelphi, 1988.








































