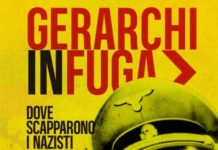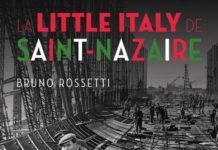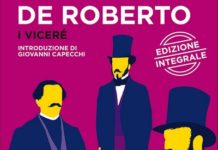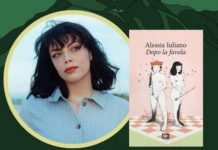Gli articoli di giugno di Missione Poesia si aprono con la proposta del libro di Edoardo Callegari, Liturgie di un magnifico: un titolo che fa pensare a un percorso di ricerca e di affermazione di una visione che contiene religiosità, mistica e spiritualità. E forse è proprio questo il cuore pulsante del libro: la ricerca di una rinnovata spiritualità che possa esprimersi attraverso la parola della poesia.
********

Edoardo Callegari, nato a Piacenza e laureato in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore della stessa città, è un economista che collabora con Fondi di Investimento attivi nel mondo dell’arte. Drammaturgo e poeta, ha seguito i corsi di Littératures modernes de l’Europe néolatine presso il Collège de France di Parigi nel periodo 2011-2019. Attualmente, oltre a svolgere la professione, partecipa al corso “Leadership e Management” presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Nel corso del 2021 e 2022 si è classificato fra i primi al Premio Montano Poesia Inedita, Premio Milano International, Premio Internazionale Dostoevskji, Premio Federiciano. Nel 2022 ha rappresentato l’Italia al festival Europa in versi. Nell’autunno del 2022 è andata in scena una sua opera teatrale dal titolo Umbra Luminis – Teresa Miss Avila. È membro del Direttivo del Piccolo Museo della Poesia – Chiesa di San Cristoforo a Piacenza. Il libro di poesia Liturgie di un Magnifico è stato pubblicato da Puntoacapo nel 2022.
Conosco Edoardo Callegari da alcuni anni, ovvero da quando frequento il Piccolo Museo della Poesia di Piacenza. L’ho ascoltato varie volte sia come critico che come poeta e ho sempre apprezzato i suoi interventi, molto colti e argomentati, e i suoi modi gentili e educati. La poesia che scrive riflette la sua personalità, la sua indole, e la sua continua ricerca di una spiritualità profonda che richiede di essere raggiunta attraverso la parola. Sarà ospite a Bologna, nel mese di giugno, nella rassegna Un thè con la poesia.
Liturgie di un magnifico

Liturgie di un magnifico: un titolo impegnativo, altisonante, che fa venire in mente da subito un percorso intorno a qualcosa di molto profondo, qualcosa che si esplica con la ricerca e l’affermazione di una visione che contiene religiosità, mistica e, soprattutto, spiritualità. E forse è proprio questo il cuore pulsante del libro: la ricerca di una rinnovata spiritualità che possa esprimersi attraverso la parola, la parola della poesia: non è così facile da immaginare, ancora meno da realizzare. Eppure Edoardo Callegari ci prova e affronta questa ricerca affidandosi alla tradizione, a partire dal titolo dove i lemmi liturgia e magnifico sono presi in prestito da una semantica di stampo biblico-evangelico, e proseguendo con un continuo e costante confronto con una lingua di tradizione dichiaratamente spirituale, una lingua che sfiora necessariamente le visioni mistiche, l’ascetismo, la religione sviluppando poi, a latere, un’attenzione che impedisca il soffocamento dell’esperienza del lettore. Che esperienza può fare dunque il lettore che si immerge nella lettura di questi testi di Callegari ? Perché è necessario salvaguardare quell’esperienza ? Credo si tratti di un’esperienza davvero spirituale, molto poco frequente nella poesia contemporanea, e per questo, preziosa: aldilà di quelli che sono i concetti espressi, qui non si tratta di una poesia che parla di Dio, della sua presenza o della sua assenza, qui si incontra una spiritualità forte che tenta un approccio diretto proprio attraverso la lettura che si trasforma in contemplazione. È come se l’autore ci facesse partecipare a un percorso contemplativo nel quale è immerso, è come se ci invitasse a sedersi con lui, gambe incrociate, sguardo rivolto in alto, respiro lento (forse è una visione un po’ stereotipata dell’atto di contemplazione, ma rende l’idea) e in questa posa plastica ci chiedesse di provare a vivere con lui questa esperienza così profonda. Ci sono ovviamente alcune poesie che possiamo prendere ad esempio per rendere l’idea di questa ricerca avviata da Callegari e, senza dubbio, anche la parte propedeutica alle poesie, la parte prosastica che afferisce alla figura di San Colombano sostiene sicuramente la struttura del libro e del pensiero stesso dell’autore. La regola colombana, diventata poi benedettina nella sua forma più edulcorata, quella moralità di vita e fede, sin troppo rigida per certi versi – penso alla mortificazione della carne, ai digiuni, agli eremitaggi – ci introduce tuttavia in una dimensione di estrema purezza, ma anche di vulnerabilità se vogliamo, che nella visione più alta della fede unisce anima e corpo, elude alla dualità a cui siamo abituati e ci riporta alla melodia interiore e profonda del Cantico dei Cantici, in una geografia di luce e spazi che alimenta il rapporto con quell’aurea retorica e classica della poesia con cui Callegari intende relazionarsi.
Ora, uno dei testi che è stato preso più a riferimento per un’analisi di questo libro è senz’altro La spoglia fertilità che già nell’ossimoro del titolo ci racconta di come l’autore intende l’ascesi verso la luce, verso l’Assoluto: siamo ormai nati, cresciuti, siamo giunti all’apice, vicini a quella soglia del liminare dove le fioriture non sono più necessarie, dove solo ci attende un secondo raccolto, quello più fertile. Abbiamo raggiunto le tre fasi principali della nostra vita: la Fede che sarà accontentata dalla visione; la Speranza che sarà confermata dal suo realizzarsi; la Carità che resta come unica via possibile per sublimare anche il corpo… La spoglia fertilità/di ciò che è giunto all’apice, rimesso/dal rigoglio, non ha fioriture/ nuove da attendere ormai della che quelle/ luce che riviene sull’origine […] Da qui ci possiamo avviare alla lettura del testo Il cammino nella valle di un Lethe dove sarà appunto la Carità, l’unico gesto, l’unica parola che darà il via al nuovo inizio, all’unico confronto possibile con una luce, altrimenti inaccessibile: […] non sarà il congedo dalla luce/nell’estremo del fulgore ad avere/l’ultima parola, ma la carità/come sola “parola dell’inizio”.
Ma anche la poesia Nel sepolcro di pane apre a possibilità di confronti: la figura di una natura da contemplare che si riassume in un’aurora invernale non nasconde un’ulteriore necessità di relazione con l’Assoluto che ritorna con ombreggiamenti dorati, con comete che riposano, con mani tese che accompagnano: […] la mia pura natività/in ascolto della luce mietuta/ad altezza delle autore invernali/pre ombreggiate di oro invisibile,/ti riconduce per mano a me. […]
E abbiamo già accennato al fatto che la dimensione contemplativa è proprio una delle caratteristiche fondanti della cifra stilistica di Callegari: poesie che sono contemplazioni più che testi meramente meditativi. Poesie che, proprio nella contemplazione, cercano la verità: ma cos’è la verità? É un cammino su piedi malfermi, un cammino verso ciò che è difficile da dimenticare perché ci appartiene, fatto di ricordi, di storie, di ciò che ha un valore per noi e ci rende quello che siamo, ma anche un cammino per capire la nostra destinazione, il luogo, il tempo, lo spazio verso il quale stiamo andando. Ebbene, srotolare il papiro dei segni, delle tracce, dei graffiti di Callegari è un po’ come cercare di capire la genesi di questo libro e del suo pensiero. Libro più di confronti che di memorie, più di ricerca – abbiamo detto – che di ritorni d’immagini d’infanzia piuttosto che di adolescenza, libro di lode verso ciò che è Donazione, verso una resurrezione che ha il valore dell’amore, che fa sentire amati. E libro che cerca, in fondo, una relazione con l’Assoluto: lo fa attraverso la solitudine della meditazione? Forse. Lo fa attraverso la solitudine della contemplazione? Anche. Ma, soprattutto, lo fa immaginando questa relazione come parte di un insieme che si immerge nel silenzio, si concretizza nella Carità e si dirige verso la visione di quella resurrezione del sentirsi amato che tutto contiene, anima e corpo, amore e poesia, svuotamento e luce per una poetica che si trasforma in Liturgie di un magnifico.
Alcuni testi da: Liturgie di un magnifico
VERSO GLI OLIVI, A UN COSÌ CALMO ALTROVE
Laniakea
A mio padre
In Omero
le parole per descrivere l’uomo
sono le stesse usate per definire
la luce. E in questo c’è una luce
fermata dall’emulsione di tutto
lo spazio presente e che verrà.
Ed è nella contemplazione estiva,
senza i preparativi necessari
del clima, prima del contemplabile
autunnale più presto pacificato.
Penso al tuo autunno che cade all’unisono
ritraendosi alla luce
per contemplare se stesso
mentre un vacuum ha inizio
dove l’anima cristallina
suddivide la luce nelle idee
di miseria che occupano l’anima,
e un Giordano vivente entra per nutrire
la speranza dove tutto è invito,
qualsiasi fosse la direzione
del ritorno presa dai risanati;
dove un albero della vita cresce
grande quanto un Paradiso Incommensurabile,
tutto divenuto reale nel punto
in cui è mantenuta una promessa;
in un tempo dove l’origine
del tempo sta nelle configurazioni
della incompletezza di una descrizione.
E chiedere più di questo:
che l’aria in serbo per la mattina
non disincarni la sua stessa summa
di cristallo. I nostri giorni avranno
nascite come un addio fedele
è addio alla bianchezza dalla dominanza
del bianco, antecedenti l’una all’altra,
e una tale reticenza
éclaire d’insignifiance
sarà la sola presenza del nostro
mero essere donato
e una risposta, satura di donazione.
***
Nel senso del solco
Nel senso del solco, ad altezza
del seme, incielata,
è nella parola fatta luce
di nessun excelsior che il predicato
verginale di luce all’aperto,
liberando un cielo, satura il mondo
di una donazione, una casa aperta.
E tu dormi nella mia notte, nata
dal tuo mare sussurrando a occidente,
come un arcipelago
per me di vita nuova.
Tu scolpita di stella
forte, avrai dove posare il capo?
***
La luce è il luogo in cui l’acqua
La luce
è il luogo in cui l’acqua, nel respiro fresco
delle pietre, può immergere sé stessa
solo apparendo.
Lucem
demonstrat umbra. Sia così.
Ma anche l’ombra è mattutina.
E questo ancora può coglierci
sotto un cielo: tenendo il calice
che sta per riempirsi, qualcuno
portando il vischio alla tavola
apparecchiata, farne affluente.
E olio di nozze, che unisce il libro
al cuore d’olivo della casa.
Leggerezza di carità
nel corpo-di-parola
di questa terra, come da un costato.
Acqua benedetta alle mani
e al costato, la giornata intera
a rischiarare l’angelo mentre
ci fa vivere l’abitata,
non la casa. E costellare il libro.
***
VITANOVAMALASPINA
The Prodigal Pilgrim’s Progress
“Allora rientrò in sé stesso e disse:
quanti salariati in casa di mio padre
hanno pane in abbondanza (…)”
(Lc, 15,17)
Ora lascia, Titiro,
che quanto era protetto dal canto
e dava protezione nell’eccellenza
di quiete, diventi un ovunque di esilio,
che compone se stesso come estuario
d’aria, come le scaturenti origini
dell’aria un miserere che colma
la luce ed effonde spogliazione
nella crescita lenta alla brezza
della luce sepolta nei roseti.
Chiedi perché di altri cònsoli saranno
Pascoli di fiori del citiso
e il salice amaro, i giovenchi
che adagiano il fianco candido
sui teneri giacinti,
sotto la freschezza ombreggiante
di un leccio, a ruminare le erbe
pallide, mentre per te è scritto
che hai fatto irrompere tra i fiori, l’Austro
e i cinghiali nelle acque
limpide … Tutto diventi alto mare,
anche nell’eccellenza di erbe morbide
più del sonno. Omnia vel medium fiat
mare, dunque, dove dire
che l’eccellenza dell’onda si rifrange
a riva, significa interromperne
il vero corso. E ora continua,
come se il nome del figlio
della parabola fosse
quello di un efebo in Virgilio
ed il perdono del padre non risuonasse
tanto avanti alle sue parole:
– Devi aver avuto in serbo a lungo
per un racconto estivo, custodita,
una parola che impegnasse, esprimendole,
alla speranza e umiltà, che ora dovremo
riporre da soli e dissigillare;
ora, tornare al centro del proprio clima
senza la parola di festa,
sarà un intorbidire la luce.
Ma in questa nuova solitudine,
il nostro agire più ampio
potrà forse essere la raccolta
nel calice della mente-qoèlet
del desiderio di un infermo,
ad essere quella poca deviazione,
quel clinamen di miseria […]
***
Fiori di citiso, salice amaro,
teneri giacinti, frescura del leccio,
erbe pallide … sembrano ombre
fertili che la terra ha sulla luce.
La fillotassi con ciascuna foglia
spostata rispetto a quella sottostante
con un angolo più o meno costante
di centotrentasette
virgola cinque gradi
lungo una spirale sul tessuto
vegetale chiamato meristema,
perché ogni nuovo primordio
di germoglio appare periodicamente
sul confine dell’apice
in una posizione corrispondente
al più grande spazio lasciato
dalla primordia precedente.
Oppure in motivo fogliare distico
con foglie successive ai lati opposti
del fusto, con una foglia
quasi completamente avvolta attorno
al fusto, o ancora in piccoli grappoli
di foglie – due o più, detti vortici –
a intervalli regolari lungo
lo stelo con ciascuna spirale
sfalsata, in modo che si trovi sopra
gli spazi vuoti della spirale
sottostante, con foglie giustapposte
a centottanta gradi l’uno all’altro,
sfalsate di novanta gradi rispetto
alle due sottostanti; decussate,
come la prima scoperta
della menta un’estate in giardino
o l’ortica delle cadute infantili.
L’esatto tipo di andamento a spirale
della fillotassi è determinato
dalla velocità dell’intervallo
di germogliamento dei primordi
successivi, rispetto al tasso
di estensione del fusto
ed al loro respingersi a causa
della inibizione a lungo raggio.
Il canto della terra è un proteggere
la bellezza, tagliando primizie
da portare al tempio. Questo significa
che per proteggere la bellezza
è necessario rischiare il taglio
tra la potatura e il canto nuovo.
L’amato chiede all’amata del Cantico
questo rischio, ed è ciò che lui stesso fa:
il rischio di Dio è quello di essere
tagliato in parola. Ho vissuto
allargato dentro il respiro di tutto questo.
Bologna, maggio 2024
Cinzia Demi
P.S.:
 “MISSIONE POESIE” è una rubrica culturale di poesia italiana contemporanea, curata da Cinzia Demi, per il nostro sito Altritaliani di Parigi : https://altritaliani.net/category/libri-e-letteratura/missione-poesia/
“MISSIONE POESIE” è una rubrica culturale di poesia italiana contemporanea, curata da Cinzia Demi, per il nostro sito Altritaliani di Parigi : https://altritaliani.net/category/libri-e-letteratura/missione-poesia/