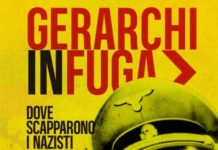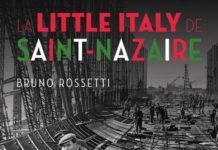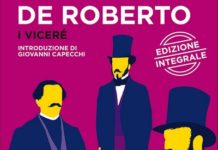Il termine “tolleranza” deriva dal latino tolerantia, da tolerare, che significa sostenere, sopportare, a sua volta derivato di tollĕre che significa sollevare, reggere. Tollerare qualcosa, quindi, è, letteralmente, reggere, consentire o sopportare qualche cosa che in sé sia o potrebbe essere spiacevole, dannosa, mal sopportata. Le parole non mentono e le loro radici sono rivelatrici non solo del punto di partenza ma anche del punto d’arrivo, talvolta inconsapevole, degli stessi parlanti.
Il concetto di tolleranza, soprattutto con riguardo ai giudizi di valore, è collegato alla disapprovazione e avversione verso qualcosa che si considera sbagliato, dato che è incoerente parlare di tolleranza nei confronti di ciò che si approva. Il concetto, insomma, implica, puramente e semplicemente, l’idea di indulgenza paternalistica, di sopportazione, talvolta di indifferenza.
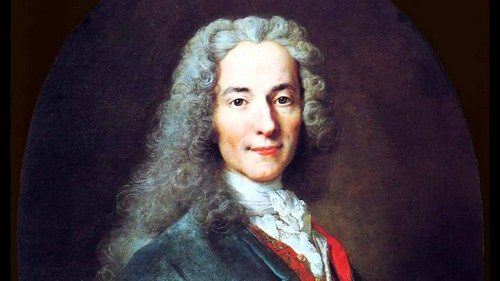
Tutt’altra cosa dal significato di accettazione e rispetto verso idee, opinioni, religioni diverse dalle proprie: il concetto di tolleranza è, insomma, completamente diverso da quello di riconoscimento della pari dignità delle persone e delle idee. Perciò, oggi non si dovrebbe più usare il termine “tolleranza” bensì il termine “rispetto”, altrimenti si attenta alla dignità morale della persona.
Anche a voler ammettere uno slittamento semantico prodotto dall’evolversi della cultura – in termini di rispetto, di accettazione – bisogna comunque considerare l’ambiguità del termine, in quanto la tolleranza è costantemente riferita, ancora oggi, anche ad altri aspetti della vita sociale – come, ad esempio, i comportamenti molesti, il turpiloquio ecc. – con un’accezione “negativa” e non certo “positiva” in termini di rispetto.
Invero, sotto il profilo della storicità delle categorie sociologiche, la vicenda del principio di tolleranza è simmetrica a quella del principio di eguaglianza. Sì che, per comprendere il senso e il valore attuali dei concetti di eguaglianza e di tolleranza, è necessario storicizzare il discorso e reintrodurre i concetti in questione nell’ambito del processo storico che li ha generati.
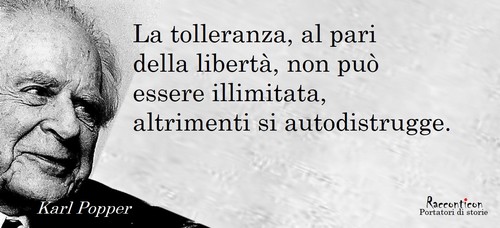
Iniziamo dall’eguaglianza. Nel secolo XIX, la borghesia, uscita vittoriosa dalla grande rivoluzione, è la nuova classe dirigente, portatrice di una tavola di valori in cui tutta la società è chiamata a riconoscersi. Il valore fondamentale – e, per così dire, originario – è rappresentato dall’individuo, concepito come persona libera, cioè, personalmente autonoma e indipendente, in quanto non più soggetta a vincoli di personale asservimento(come, ad esempio, gli schiavi o i servi della gleba), e formalmente uguale, cioè, parificata giuridicamente in forza del principio secondo cui «la legge è uguale per tutti» e «tutti sono uguali davanti alla legge». La parificazione di tutti gli uomini, peraltro, si realizza soltanto sul piano formale e astratto (cioè, di uguaglianza davanti alla legge); sul piano materiale, invece, sussiste una situazione di disuguaglianza sostanziale, nel senso che i membri della «società civile» sono profondamente disuguali quanto a condizioni economiche, sociali, culturali, ecc. La parificazione giuridica di tutti i soggetti dell’ordinamento presupponeva la netta separazione tra società civile (l’insieme dei soggetti, che interagiscono nella società, instaurando rapporti economico-sociali) e società politica (lo Stato e i suoi apparati): l’autonomia dell’economia dalla politica era stato il grande disegno rivoluzionario della cultura borghese del XVII e XVIII secolo (si pensi all’opera dei filosofi illuministi, da Rousseau a Montesquieu, da Voltaire a Diderot) e aveva fornito le basi per l’affermazione della teoria fisiocratica, per cui la società doveva evolversi in maniera autonoma e spontanea, informandosi alla legge della natura, dove prevale il più abile, il più forte, il più audace, il più scaltro.
A ben vedere, la parificazione giuridica di tutti gli uomini era funzionale alle esigenze di conquista e di consolidamento del potere da parte della borghesia: i privilegi che essa combatteva erano i privilegi della nobiltà e del clero, i privilegi cioè delle classi allora al potere; l’uguaglianza che essa predicava era solo formalmente tale: era una uguaglianza che, di fatto, collocava in posizione dominante la borghesia, permettendole di esercitare, grazie all’uguaglianza formale, il peso determinante della sua maggiore ricchezza. Invero, l’astratta libertà individuale, se per chi disponeva di beni in proprietà aveva un significato concreto, per gli altri (che erano la stragrande maggioranza) non significava altro se non possibilità di scegliere tra la fame e un salario appena sufficiente a soddisfare i bisogni elementari.
Per comprendere i limiti del principio di eguaglianza formale e per superarne le implicazioni, occorre attendere – in Italia, come in gran parte d’Europa – circa un secolo, e precisamente – per quanto ci riguarda – il 1948, anno in cui entrò in vigore la nostra Costituzione. La Carta Costituzionale, infatti, se da un lato conserva il patrimonio ottocentesco dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 e 3, primo comma), si avvale dall’altro dell’influenza di ideologie, la cattolica e la socialista, che, assenti nel processo storico del risorgimento, avevano svolto, nel corso della resistenza antifascista, un ruolo di primissimo piano: cosí, accanto ai tradizionali diritti di libertà (di pensiero, di religione, di associazione, ecc.), introduce il riconoscimento dei «diritti di solidarietà sociale», legati a una diversa concezione dell’uomo e, conseguentemente, a una differente visione dei rapporti economico-sociali. Fondamentale, al riguardo, è la norma contenuta nell’art. 3 Cost.: tale articolo se da un lato ribadisce al primo comma il principio di eguaglianza formale, ereditato dalla rivoluzione francese, secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti a davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”; dall’altro sancisce, al secondo comma, il principio di eguaglianza sostanziale, in forza del quale “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Ciò significa che l’eguaglianza davanti alla legge dev’essere considerata un punto di partenza e non già un approdo definitivo che impedisca di guardare alle reali diseguaglianze nelle quali trovano le loro radici le disparità sociali ed economiche: queste non sono, come per il passato, giuridicamente irrilevanti, ma sono prese in considerazione dal diritto, il quale esprime nei loro confronti un giudizio negativo, in termini di “rimozione”, in quanto le considera veri e propri “ostacoli” alla formazione e allo sviluppo della personalità umana, all’effettiva libertà ed eguaglianza dei cittadini, e dunque alla dignità della persona. Si assiste all’affermazione di una nuova logica del soggetto: non più l’individuo astratto e indifferenziato, ma il soggetto concreto, con tutte le sue connotazioni storico-reali. Ciò ha comportato la necessaria affermazione di un nuovo particolarismo giuridico, governato dal criterio di ragionevolezza, secondo cui è contrario al principio di eguaglianza sostanziale – e, dunque, irragionevole – trattare in maniera uguale situazioni diseguali e, viceversa, trattare in maniera diseguale situazioni uguali.

Punto di partenza, invece, per la vicenda storica della tolleranza è l’Europa del XVI secolo, sconvolta dalle divisioni religiose provocate dalla Riforma protestante (non a caso, tolleranza è da sempre classicamente abbinata all’aggettivo religiosa). Prima di allora, la tolleranza, nel senso socio-politico che qui interessa, non esisteva. In epoca medievale, ad esempio, la chiesa cristiana – portatrice di una religione rivelata per cui l’errore di fede era peccato oltre che crimine – represse duramente l’eterodossia, soffocando con la forza i ‘movimenti ereticali’ senza remora alcuna. Potendo estirpare, non c’era bisogno di tollerare.
Con la Riforma protestante cambia tutto, perché essa gode di appoggi politici: non si tratta più di gruppi isolati e inermi, facilmente perseguitabili. È allora che nasce la tolleranza, come necessità di sopportare – perché è impossibile, problematico o controproducente impedirlo – ciò che si esecra e aborre; come concessione, sempre revocabile, da parte di chi detiene il potere. Per gli intellettuali cinquecenteschi, infatti, la tolleranza è instrumentum regni, strumento di governo, strategia dettata da ragioni di opportunità, per salvaguardare lo Stato.
Tutto cambia, almeno in apparenza, nel Seicento, quando si affaccia il principio liberale della laicità dello Stato. John Locke sostiene con forza che il potere politico non deve occuparsi della salvezza delle anime, e che viceversa quello spirituale non deve ingerirsi nelle faccende politiche. La fede è un fatto individuale e insindacabile: ogni Chiesa ha il diritto di scomunicare i suoi membri, ma non quello di usare la forza per punire i dissenzienti. Con Voltaire e l’Illuminismo, finalmente, si proclama la rinuncia alle verità assolute, si affermano il relativismo e il razionalismo scettico. È così che “la tolleranza” si trasforma via via in accettazione, libertà di opinione, società aperta, e quindi non è più “semplice” tolleranza: questa, infatti, quando si evolve fino a trasformarsi in rispetto e pari dignità di persone, di idee, di opinioni, di religioni diverse dalle proprie, diventa altro e scompare.
Non basta più “tollerare”, ma bisogna soprattutto “includere”

Oggi, che si è raggiunto nella nostra società un diffuso consenso intorno all’idea dell’assoluta preminenza e centralità della persona umana nella gerarchia dei valori riconosciuti nelle Costituzioni del mondo occidentale, è venuto il momento di affrontare un problema che non è più eludibile, sicuramente uno dei più difficili e complessi che si stanno imponendo all’attenzione generale e che lasciano intravedere, ovunque, un cambiamento d’epoca: quello del riconoscimento delle identità diverse, fondamento del diritto all’identità e alla differenza, in una società nella quale sempre più s’intrecciano etnie, culture, religioni, valori che chiedono di essere rispettati nella loro specificità. Insomma, non basta più “tollerare”, ma bisogna soprattutto “includere”. Il riconoscimento è un atteggiamento attivo, che spinge verso la valorizzazione della differenza. Proprio quest’ultima è diventata il punto di forza di quei movimenti contro le discriminazioni che caratterizzano le società pluralistiche e multiculturali del nostro tempo. Dall’incontro e dallo scambio, dal confronto e dall’interazione tra culture diverse non può venire che bene: la storia dell’umanità e delle sue civiltà è stata essenzialmente il portato di un arricchimento reciproco.
Oggi, le domande della “politica del riconoscimento” e delle “pratiche di rispetto” oltre la semplice tolleranza sono all’origine della crisi dell’idea stessa di tolleranza a cui siamo impegnati quali eredi di Voltaire. La tolleranza liberale è inadeguata a far fronte alle sfide del multiculturalismo, a domande a lei rivolte da entità collettive di genere o di cultura o di etnia. Essa è, anzi, una modalità dell’oppressione e quindi si risolve in una forma più o meno sottile d’intolleranza. Essa è l’omaggio rituale che istituzioni e maggioranze consolidate offrono ai “diversi” condannati nel cono d’ombra della scomunica, dell’umiliazione, della discriminazione e dell’esclusione.
Affermava con grande lungimiranza, nel 1718, James Stanhope parlando alla Camera dei Lord: «vi fu un tempo in cui i dissenzienti (…) invocavano la tolleranza come una grazia, oggi la chiedono come un diritto, ma verrà un giorno in cui la sdegneranno come un insulto».
Bruno Troisi