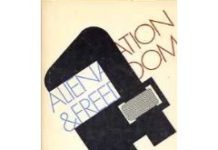La natura non conosce “confini” e tanto meno “frontiere”, non esistono né barriere né recinzioni. Tuttavia nella nostra quotidianità siamo profondamente convinti di vivere tra frontiere e recinzioni, tra luoghi accessibili e altri invalicabili, tra spazi che ci appartengono e territori stranieri. Una riflessione di David Bellatalla legata al tema del nostro dossier mensile.
****
I nomadi hanno cercato di confrontarsi con l’idea e con il concetto di frontiera in modo del tutto peculiare e, per molti versi, lontano dai nostri luoghi comuni e dai nostri modelli.
“Usciamo fuori della gheer per sgranchire le gambe: due interminabili giornate di neve e vento gelido ci hanno costretto al forzato riparo dentro le loro gheer, la tenda nomade buriate; ancora una volta siamo sorpresi dall’inconsueta luce che illumina l’orizzonte lontano. E’ proprio vero, commenta Bt, qui il cielo non si può raccontare. Bator, capo clan del gruppo con il quale viviamo la nostra esperienza è fermo, a circa cinquanta metri dal campo, immobile su una piccola altura; scruta l’orizzonte lontano. Sembra quasi assorbito, incantato da quella luce perlacea dell’orizzonte. Uno stormo di uccelli percorre ampi circoli proprio sopra di lui, in volo ordinato, poi scompare veloce verso oriente. Bator si volta verso il campo e a passi decisi si dirige verso di noi. Ci supera ed entra nella propria gheer. Lo seguiamo.
All’interno troviamo la famiglia di Dondog al completo e Bolot che al solito sta sgranocchiando carne essiccata e bevendo Su-tè-zae, te e latte e sale. Bator è seduto e parla per oltre un quarto d’ora alternando ad ampi gesti pause per sorseggiare l’immancabile tazza di te e latte. Alla fine tutti si alzano ed iniziano una frenetica attività di preparazione delle masserizie per muovere il campo. Chiediamo a Bolot di tradurci in parole ciò che stiamo vedendo. Bolot ingoia l’ultimo boccone, si alza e dice: « Il cielo e gli uccelli hanno detto a Bator che è tempo di andare verso nord; bisogna muovere il campo…ora »…“
I cani iniziano ad abbaiare all’unisono, volgono lo sguardo e si dirigono verso le piccole alture proprio dietro il campo. Gantuya comincia a mungere le mucche, non è per nulla sorpresa o incuriosita. Noi rimaniamo immobili e con lo sguardo cerchiamo lontano la ragione dell’abbaiare dei cani. Non passa molto tempo ed ecco apparire tra una nuvola di polvere una carovana che si dirige verso il campo. Nessuno qui sembra minimamente interessato a ciò che sta accadendo. Quando il piccolo convoglio è nei pressi del campo, Mei e Tzetzeghee allontanano i cani con la solita tecnica delle sassate.
La carovana è composta da un uomo e da una donna a cavallo, quest’ultima con un piccolo legato dietro a mò di fagotto, da due cammelli con il pesante fardello della gheer e delle masserizie, da un carro trainato da un imponente cammello e poco lontano un gregge di 50/60 capi tra mucche e pecore. Un giovane a cavallo, con la sua immancabile urga (attrezzo del nomade, costituito da una lunga asta di circa cinque sei metri, alla cui cima è fissato un cappio in corda, per afferrare gli animali), chiude la carovana. Sceso da cavallo l’uomo a capo della carovana si dirige verso la gheer di Bator (come se già sapesse in quale delle cinque gheer vive il capo clan) mentre la donna, legati i cavalli, allatta il suo piccolo. Gantuya osserva poco interessata continuando a mungere, Mei e Tzetzeghee hanno ripreso a giocare-lavorare con le mucche, noi siamo troppo curiosi e decidiamo di entrare nella gheer di Bator per vedere cosa sta accadendo. C’è una bella atmosfera. Bolot ci dice che il nuovo arrivato è un amico di Bator e che con la sua famiglia si fermerà qui con il nostro gruppo (…) Sistemata la gheer Gantuya ed il ragazzo iniziano a radunare le pecore.
Mi chiedo come sia possibile riconoscere in seguito i capi di bestiame appartenenti a ciascun gruppo,ora che i quattro gruppi hanno riunito assieme le loro mandrie (raramente gli animali vengono marchiati o comunque « segnati »). Nassan li raggiunge portando i secchi, ed insieme cominciano a mungere l’intero gregge. Di volta in volta il latte viene portato nelle gheer senza distinzione alcuna riguardo alla proprietà. Tutto appare come il prodotto di un’unica famiglia dove padre, madre, fratello e sorella hanno stessi diritti di soddisfazione sul cibo comune.”
Tratto da “Sciamanesimo e Sacro tra i Buriati della Mongolia” 1996
***
I due brani, tratti dai diari delle spedizioni condotte in Mongolia negli anni novanta assieme al documentarista Dino De Toffol, ci lasciano intravedere un modello culturale e un approccio all’idea di confine, limite e frontiera, diverso da quello al quale siamo abituati. Un modello culturale nel quale si evidenziano particolari tipologie di approccio all’idea del limite-frontiera-territorio fisico e mentale, che possono offrirci spunti per riflessioni e valutazioni speculative sul nostro modello.
La prima osservazione che potremmo fare su queste brevi tracce dei diari, è sicuramente quella di un immediato riconoscimento di una sensibile elasticità, una dinamicità mentale che caratterizza lo stile di vita dei nomadi delle steppe. “Più sono rigidi i tuoi confini, più saranno dure le tue battaglie. Più sarai attaccato al piacere, più avrai terrore del dolore. Più cercherai il successo, più sarai ossessionato dalla sconfitta”. Le parole di Bator, annotate nei miei taccuini, mi sono spesso sembrate risposte fuorvianti alle mie continue domande e alle ossessive ricerche di spiegazioni sull’idea di proprietà privata, di spazi condivisi, diritti sul territorio e di dinamiche sociali tra i clan dei Buriati.
Rileggendo i miei appunti, mi sono accorto che i nomadi hanno cercato di confrontarsi con l’idea e con il concetto di frontiera in modo del tutto peculiare e, per molti versi, lontano dai nostri luoghi comuni e dai nostri modelli.
Siamo ormai certi che ad ogni latitudine l’idea che la natura, il territorio, lo spazio siano indissolubilmente legati all’essere umano, alla sua storia e alla sua evoluzione, sia una consapevolezza acquisita .
Ciò nonostante l’approccio all’ambiente è profondamente diverso se analizziamo e confrontiamo, anche solo superficialmente, il modello sedentario con quello nomade.
Mentre nel primo caso lo sfruttamento del territorio per il mantenimento della vita è subordinato ad un adattamento, una trasformazione dell’ambiente (antropizzazione dello spazio) per esigenze alimentari e abitative (includendo infrastrutture e vie di comunicazione), nel mondo nomade l’utilizzazione del territorio avviene sempre in modo indiretto, tramite i loro armenti.
Le conseguenze sono macroscopicamente evidenti. Nel mondo sedentario, il paesaggio viene trasformato, adattato, sezionato e delimitato, mentre nel modello nomade lo spazio territoriale utilizzato anche da un gruppo considerevole di clan, non presenta traccia alcuna della loro permanenza e del loro passaggio, già a poche settimane dalla loro dipartita.
Se nel primo caso Eugenio Turri nei sui scritti ci faceva notare come la lettura del paesaggio potesse fornirci elementi ed evidenze sui gruppi umani che avevano vissuto in quegli spazi, attraverso la lettura delle trasformazioni operate sul territorio (abitazioni, infrastrutture, colture, canalizzazioni ecc), descrivendoci e illustrandoci la loro identità culturale, in ambito nomade tutto ciò è assolutamente impossibile.
Una differenza sostanziale che inevitabilmente si riafferma nelle pieghe della storia e dell’evoluzione della cultura nomade verso l’ambiente.
La natura non conosce “confini” e tanto meno “frontiere”, non esistono né barriere né recinzioni. Tuttavia nella nostra quotidianità siamo profondamente convinti di vivere tra frontiere e recinzioni, tra luoghi accessibili e altri invalicabili, tra spazi che ci appartengono e territori stranieri.
Eppure, l’essere umano (con ben poche eccezioni) si riconosce come parte di una grande unità, di un universo, visibile e invisibile, che va ben oltre l’immagine che può darci il solo raziocinio.
Perché allora questa esigenza di riconoscere e stabilire dei confini e delle frontiere? Si tratta di una sorta di difesa e di salvaguardia della propria identità personale e comunitaria, oppure è una necessità per ordinare, comunicare, redigere e controllare l’esistenza e la coesistenza tra gli altri esseri umani?
I confini e le frontiere sono di fatto mere illusioni, prodotti non della realtà bensì del nostro modo di redigere una mappa della realtà. Se da un lato il tracciare confini è assolutamente necessario per rappresentare un territorio (inteso sia come spazio fisico che mentale) è profondamente sbagliato confondere la realtà con la sua rappresentazione. La realtà del non-confine della non-frontiera ci è palesemente testimoniata dalla storia della fisica moderna.
Keplero, Galileo e Cartesio, eredi di Adamo che attribuiva nomi e delineava confini, resero sempre più “connaturale” per l’essere umano la necessità di tracciare limiti e frontiere con le dovute e inevitabili classificazioni che questo comporta. Con essi l’uomo scoprì di vivere in due universi paralleli: quello concreto opposto a quello dell’astratto. L’ideale opposto al reale, l’universale opposto al particolare. Ne emerse una grande disputa tra intelletto e istinto, tra la mente e la materia, l’ordine contro il caos.
Si arrivò più tardi a riconoscere i confini non come prodotto della realtà, bensì come il risultato di una interpretazione formale della realtà.
Il fisico Eddington disse: “Abbiamo scoperto che là dove le scienze hanno conseguito i maggiori progressi, la mente ha solo riacquistato dalla natura ciò che aveva in precedenza messo nella natura. Abbiamo scoperto una strana orma sulle rive dell’ignoto. Infine siamo riusciti a ricostruire la creatura che lasciò l’orma. Ecco, è la nostra”.
Mi piace pensare che in fondo ci possa apparire più semplice capire che il mondo reale non sia un mero prodotto della nostra immaginazione e che solo le nostre frontiere lo siano.
Whitehead definì il mondo, il territorio e lo spazio come “una veste senza cuciture dell’universo” dove per qualche misterioso motivo, ogni cosa, ogni evento del mondo sembrava essere interconnesso, privo di confini o frontiere.
Garma Chang ci ha lasciato la sua spiegazione “Nell’infinito Dharmadhatu, tutte le cose comprendono simultaneamente tutte le altre in una completezza perfetta, senza la minima mancanza od omissione. Vedere un oggetto significa, quindi, vedere tutti gli oggetti, e viceversa. Una minuscola particella in un atomo, contiene realmente gli oggetti e i principi infiniti dell’universo del futuro e del passato remoto in perfetta completezza, senza omissioni”.
Il limite delle nostre frontiere è solo quello che siamo in grado di riconoscere, lo sforzo necessario ad abbatterle è il compito al quale tutti siamo chiamati in questo nuovo millennio, per il bene del singolo e dell’intera umanità.
David Bellatalla