Sangue impetuoso fluisce dalla penna. Sporca, macchia, si allunga sulle pagine bianche. Angeli cristiani appesi alla coscienza, immobili, inerti, impietriti mentre i demoni estendono la macchia alla vita, contaminandone ogni aspetto, ogni mossa, ogni grazia, ogni ossessione. In questa posa purpurea, Parise scrisse del suo sangue. Quello stesso sangue che il suo cuore cominciò con difficoltà a pompare a partire dal 1979, anno in cui lo scrittore ebbe un infarto. Il romanzo fu scritto qualche mese dopo l’accaduto, di getto, quasi come se Parise avesse voluto perpetuare all’esterno quel sangue che in lui, e quindi dentro, nel suo corpo, cominciava a mancare, con quella stessa frenesia e al contempo lucida rassegnazione di chi è consapevole che la fine si avvicina. Un romanzo necessario, un tentativo dell’autore di riappropriarsi della vita di fronte all’incombente sguardo della morte, attraverso l’analisi profonda e minuziosa perseguita con precisione chirurgica che egli fa di se stesso e di sua moglie.
 Sangue è vita, e vita è desiderio, pulsione animale, istintiva, atavica, selvaggia. “Sospirò, essendo un uomo di mondo e assai pratico di cose del genere, disse: Eros, e non ci fu e non c’è bisogno d’altro.” Eppure c’è dell’altro. Qualcosa di più oscuro e demoniaco che sottende il pensiero e l’agire. Una dominante interna, inestricabilmente legata alla pulsione di vita, all’Eros dunque: Thanatos o pulsione di morte. Fondamento del romanzo e del suo disincantato e cruento, raccontare la vita. Di coppia se si vuole, una coppia sulla cinquantina che non può bastare a sé stessa nell’amore “romantico, idealista e forse perfino nazista”, né sa sussistere in un dualismo civilizzato, borghese, cattolico. Allora fugge, e si ritrova tra le braccia di un’altra, “la ragazza” o di un altro, “il ragazzo”. Corre all’indietro, verso un “altrove” già passato nel tentativo di recuperare un sole al tramonto, rilanciarlo in cielo e farlo splendere nell’azzurro: la giovinezza ovvero l’odore del sangue.
Sangue è vita, e vita è desiderio, pulsione animale, istintiva, atavica, selvaggia. “Sospirò, essendo un uomo di mondo e assai pratico di cose del genere, disse: Eros, e non ci fu e non c’è bisogno d’altro.” Eppure c’è dell’altro. Qualcosa di più oscuro e demoniaco che sottende il pensiero e l’agire. Una dominante interna, inestricabilmente legata alla pulsione di vita, all’Eros dunque: Thanatos o pulsione di morte. Fondamento del romanzo e del suo disincantato e cruento, raccontare la vita. Di coppia se si vuole, una coppia sulla cinquantina che non può bastare a sé stessa nell’amore “romantico, idealista e forse perfino nazista”, né sa sussistere in un dualismo civilizzato, borghese, cattolico. Allora fugge, e si ritrova tra le braccia di un’altra, “la ragazza” o di un altro, “il ragazzo”. Corre all’indietro, verso un “altrove” già passato nel tentativo di recuperare un sole al tramonto, rilanciarlo in cielo e farlo splendere nell’azzurro: la giovinezza ovvero l’odore del sangue.
La voce narrante è unica: quella del marito infedele, analista di mestiere, che osserva se stesso tradire senza mai sentire la necessità di spostare lo sguardo verso sua moglie se non nel momento in cui anch’essa, sfinita dalla sofferenza, comincia a tradirlo : “Ho guardato, anzi visto Silvia per la prima volta quando ho avuto la sensazione che mi tradisse”. Qui comincia il romanzo: dalla gelosia o “curiosità” come la chiama Parise. Dall’atto terribile e spietato della castrazione. Visione notturna e mostruosa, il sesso di lui, del “ragazzo” “scuro ed enorme, tremendamente rigido” che assoggetta sua moglie, emancipatasi dal dominio della civiltà eppure soggiogata dal potere del “fallo”. Un sogno divinatorio che sarà la stessa Silvia a confermare. È questa la verità che l’autore cerca di lenire con il potere della ragione, ma che non sarà in grado di placare mai. Se non con la morte.
“Non capivo come mai l’erotismo, che è il segno della vita, si accoppiava sempre più ad immagini di morte. Forse anch’io avrei dovuto psicanalizzarmi e ricercare proprio in quest’associazione, erotismo morte, forse il segno di un’educazione, di un moralismo cattolico che così decretava. E invece mi pareva di trovare il disegno sempre imperscrutabile di un destino, che a me era stato dato di prevedere ma non di prevenire”.
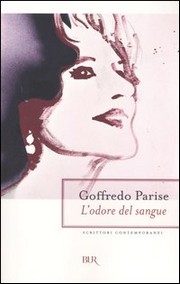 Se è lecito parlare di risoluzione del romanzo col fine di sottrarlo al suo carattere tragico, essa è da ricercare per l’appunto in questa brillante osservazione. Ma Parise in qualche modo la intuì soltanto senza mai possederla e superarla. Questo perché egli pur capendo fin dal principio il decorso degli avvenimenti, non si pose mai il problema dell’“accettazione” del destino, di quell’amor fati di cui parlava Nietzsche. Egli infatti restò figlio di quella tradizione greca, secondo cui la tragedia si genera proprio dallo scontro tra la libertà dell’uomo e l’ineluttabilità del suo destino. Il narratore ribellandosi dunque a ciò che aveva intuito essere il suo destino, non fa altro che sancire la sua fine. O meglio, la fine di un amore che egli volontariamente “uccide”. A trionfare non sarà la morte, né tanto meno l’amore come potremmo pensare in seguito all’epilogo del romanzo. Ma il moralismo cattolico e quell’insieme di norme sociali delle quali Parise non fui mai in grado di liberarsi. “Non si seppe chi aveva ucciso Silvia e io sapevo però che il vero mandante ero io stesso”.
Se è lecito parlare di risoluzione del romanzo col fine di sottrarlo al suo carattere tragico, essa è da ricercare per l’appunto in questa brillante osservazione. Ma Parise in qualche modo la intuì soltanto senza mai possederla e superarla. Questo perché egli pur capendo fin dal principio il decorso degli avvenimenti, non si pose mai il problema dell’“accettazione” del destino, di quell’amor fati di cui parlava Nietzsche. Egli infatti restò figlio di quella tradizione greca, secondo cui la tragedia si genera proprio dallo scontro tra la libertà dell’uomo e l’ineluttabilità del suo destino. Il narratore ribellandosi dunque a ciò che aveva intuito essere il suo destino, non fa altro che sancire la sua fine. O meglio, la fine di un amore che egli volontariamente “uccide”. A trionfare non sarà la morte, né tanto meno l’amore come potremmo pensare in seguito all’epilogo del romanzo. Ma il moralismo cattolico e quell’insieme di norme sociali delle quali Parise non fui mai in grado di liberarsi. “Non si seppe chi aveva ucciso Silvia e io sapevo però che il vero mandante ero io stesso”.
Il suo sguardo resta quello dello psicanalista freudiano (dissociazione, sublimazione, senso di colpa) fatto d’iridi platonico-cristiane e di ragione socratica.
“Lo sguardo stanco e pessimista, la sfiducia davanti all’enigma della vita, il gelido no della nausea alla vita – non sono questi i segni delle età più « malvagie » del genere umano: anzi esse, da quelle piante palustri che sono, emergono alla luce del giorno soltanto quando c’è la palude di cui fanno parte – intendo qui il rammollimento morboso e la demoralizzazione, per cui la bestia «uomo» impara, alla fine, a vergognarsi di tutti i suoi istinti. Sulla strada verso l’«angelo» (per non usare qui una parola più dura) l’uomo si è procurato quello stomaco malato e quella lingua impastata che gli hanno reso disgustosa non solo la gioia e l’innocenza dell’animale, ma che gli fanno ritenere insipida anche la vita – tanto che talvolta sta di fronte a se stesso tappandosi il naso e con papa Innocenzo Terzo compila il catalogo di tutto ciò che gli ripugna («concepimento peccaminoso, nauseante nutrizione nel corpo materno, miseria della materia da cui l’uomo si è sviluppato, puzza atroce, secrezione di saliva, urina e feci»)[[Genealogia della morale, Friedrich Nietzsche, parte 7]].
Flora BOTTA
N.d.r. : film tratto dall’omonimo romanzo “L’Odore del Sangue” di Mario Martone





































