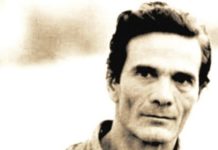Proponiamo qui, con la gentile autorizzazione dell’autore, Giovanni Capecchi, docente di letteratura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia, un significativo stralcio di un saggio su Lampedusa e il Gattopardo (« Mezzo secolo dal Gattopardo ». Studi e interpretazioni, Le Cariti Editore, 2010), che resta – con buona pace di Camilleri – il romanzo italiano più letto e proficuamente « attuale », per capire l’Italia di oggi, insieme ai « Promessi Sposi ».
1. Un romanzo anti-risorgimentale
Fin dai primi anni Trenta, Tomasi di Lampedusa aveva intenzione di scrivere un romanzo che raccontasse lo sbarco di Garibaldi in Sicilia visto attraverso gli occhi del suo bisnonno
[[ Cfr. A. Vitello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Palermo, Sellerio, 2008 (nuova edizione riveduta e aggiornata), p. 317 e D. Gilmour, L’ultimo Gattopardo. Vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Milano, Feltrinelli, 1989, 2003, pp. 142 e segg.]].
Questa storia (che, secondo il progetto iniziale, avrebbe dovuto ambientarsi in un’unica giornata, sotto la suggestione dell’Ulisse di Joyce che Tomasi, rabdomante capace di percepire le più interessanti novità letterarie europee pur dalla estrema provincia siciliana, aveva apprezzato, poco dopo la sua pubblicazione) venne scritta da Tomasi negli ultimi trenta mesi della propria vita e venne pubblicata solo dopo la sua morte, decretando per il suo autore uno strano destino: quello di diventare qualcuno (e un qualcuno noto in tutto il mondo, visto il successo del romanzo in Italia e all’estero e, pochi anni dopo, del film di Luchino Visconti) solo dopo essere scomparso dalla faccia della terra, quello di essere nato solo dopo la morte
[[La vicenda editoriale del Gattopardo – oltre che nelle due biografie di Tomasi citate nella nota precedente – è stata ricostruita in tutti i saggi dedicati al romanzo, con la frequente aggiunta di una rassegna degli interventi critici che accompagnarono l’edizione del romanzo. Si vedano tra gli altri: G.P. Samonà, Il Gattopardo. I racconti. Tomasi, Firenze, La Nuova Italia, M. Bertone, Tomasi di Lampedusa, Palermo, Palombo, 1995, G. Masi, Come leggere “Il Gattopardo”, Milano, Mursia, 1996 e G.C. Ferretti, La lunga corda del Gattopardo, Torino, Aragno, 2008.]].

Tra il 1954 e il 1957, riprendendo dunque un vecchio progetto, Tomasi scrive un romanzo ambientato in un ben preciso periodo storico, sottolineato dalle date scritte in calce a ciascuna delle otto parti. Il Gattopardo racconta vicende avvenute tra il 1860 (anno dello sbarco di Garibaldi in Sicilia e dell’avvio del processo di unificazione nazionale) e il 1910 (cinquantesimo anniversario dello sbarco). Ma il 1860 resta comunque l’anno centrale nelle vicende narrate: le prime quattro parti (che, come numero di pagine, corrispondono ai due terzi del romanzo) si svolgono nel corso del 1860; e se a queste aggiungiamo la quinta e la sesta parte (ambientate nel 1861 e nel 1862), ci accorgiamo come, almeno dal punto di vista delle pagine, l’attenzione sia concentrata sugli anni che vedono la nascita del Regno d’Italia. La settima e l’ottava parte del romanzo – i due epiloghi della vicenda, come afferma Giuseppe Paolo Samonà nella prima approfondita monografia dedicata all’opera di Tomasi – [[ G.P. Samonà, Il Gattopardo. I racconti. Tomasi, cit]]
compiono un salto in avanti nel tempo: al 1883 la prima (dedicata alla morte del Principe) e al 1910, come detto, l’ultima, che non solo ha lo scopo di far sapere al lettore ciò che succede dopo la morte di don Fabrizio e di rappresentare – come recita il sommario – la “Fine di tutto”, emblematizzata nella carcassa imbalsamata del cane Bendicò gettata dalla finestra e ridotta ad un «mucchietto di polvere livida»
[[Per comodità, indichiamo nel testo tra le citazioni tratte dalla più recente edizione del romanzo: Milano, Feltrinelli, 2007 (nuova edizione riveduta a cura di G. Lanza Tomasi).]],
ma che serve anche e soprattutto per dimostrare come l’attenzione di Tomasi sia rivolta, più che al Principe (perché se così fosse il romanzo sarebbe terminato con la morte del protagonista), alla storia e all’esistenza umana che proseguono il loro corso, indipendente dalla sorte di un individuo.
Il Gattopardo è dunque un romanzo sul Risorgimento, ed è un romanzo che esprime una posizione polemica nei confronti degli esiti del processo di unificazione nazionale. Nell’ormai ampia bibliografia critica riguardante il romanzo di Tomasi, dalle prime presentazioni (si pensi a quella di Giorgio Bassani che accompagnava l’edizione del romanzo nel 1958) e dalle primissime recensioni fino ai più recenti studi, vengono stabilite, dibattute e confutate somiglianze e diversità tra Tomasi e illustri scrittori siciliani che lo hanno preceduto, da Giovanni Verga a Federico De Roberto e a Luigi Pirandello. Senza voler entrare nel merito dei possibili paragoni tra testi e autori che restano comunque assai diversi tra loro (Tomasi, come ha definitivamente dimostrato Francesco Orlando, è uno scrittore che sembra non appartenere alla tradizione letteraria italiana)
[[F. Orlando, L’intimità e la storia. Lettura del «Gattopardo», Torino, Einaudi, 1998, p. 10.]],
è innegabile che, a partire dalla nascita dell’Italia unita, vengano dal Sud e, in particolar modo, dalla Sicilia, testi narrativi che denunciano i limiti del processo di unificazione, che esprimono la delusione meridionale di fronte al nuovo Stato incapace di risolvere i problemi del Mezzogiorno, che si concentrano a descrivere un processo politico di trasformazione solo apparente. Sono gli scrittori del Sud, come ha scritto Luigi Baldacci, gli antirisorgimentali, mentre quelli del Nord, alle prese con sperimentazioni linguistiche e con rivoluzioni grammaticali, rappresentano gli intellettuali inseriti nel tessuto dell’Italia unita
[[ L. Baldacci, Nord e Sud, in Novecento passato remoto. Pagine di critica militante, Milano, Rizzoli, 2000, pp. 27-31.]].

Anche Verga, che potrebbe sembrare il più lontano da implicazioni storico-politiche, racconta la distanza che separa i suoi “vinti” dal nuovo Stato unitario, l’estraneità di questa nuova entità che fa avvertire la sua presenza solamente attraverso l’imposizione di nuove tasse (si pensi alla “rivoluzione delle mogli” per la nuova gabella sul sale raccontata nei Malavoglia) e attraverso l’introduzione della leva obbligatoria (quella leva che porta lontano dal suo scoglio il giovane ‘Ntoni, destinato a perdersi, o che fa morire a Lissa nel 1866 Luca Malavoglia). Verga, del resto, oltre ad essere lo scrittore della distanza che separa lo Stato unitario dai problemi della povera gente (una distanza raccontata anche nella novella Cos’è il Re), ha descritto in Mastro-don Gesualdo la capacità del suo protagonista (e di una intera classe sociale) di passare indenne, grazie ad alleanze strategiche, sia i moti del 1820-1821 sia quelli del 1848, ha emblematizzato l’impossibilità di un cambiamento in quell’«ideale dell’ostrica» che affonda le sue radici in un ben preciso periodo storico (anche per questo «l’esistenza di uno scrittore come Verga è di per sé un fatto “risorgimentale”»)
[[ L. Sciascia, Verga e il Risorgimento, in Opere. 1984-1989, a cura di C. Amboise, Milano, Bompiani, 1990, 2002, p. 1146.]]
e ha poi rappresentato in Libertà le aspettative deluse dei contadini del Sud di fronte allo sbarco di Garibaldi, che non porta terra e libertà ma ancora oppressione e miseria.
Antirisorgimentali e spiccatamente politici sono sicuramente I Vicerè di De Roberto e I vecchi e i giovani di Pirandello. Il romanzo I Vicerè rappresenta il grande affresco di una classe sociale, quella aristocratica, che riesce a mantenere i propri privilegi e il potere anche nel passaggio dai Borboni ai Savoia. È il romanzo della storia che si ripete, che non conosce reali e profonde trasformazioni: Consalvo Uzeda, cercando di spiegare all’orgogliosa zia Ferdinanda che l’unico modo per mantenere i propri privilegi è quello di abbassarsi alle regole democratiche della nuova situazione politica, sintetizza nelle ultime pagine del libro l’essenza e il messaggio dell’intero romanzo: «Un tempo la potenza della nostra famiglia veniva dal Re; ora viene dal popolo… La differenza è più di nome che di fatto […] il mutamento è più apparente che reale […]. La storia è una monotona ripetizione»
[[F. De Roberto, I Vicerè, in Romanzi, novelle e saggi, a cura di C.A. Madrignani, Milano, Mondadori, 1998, pp. 1099-1100.]].
Pirandello, al termine del “decennio giolittiano” che, stando alla storia ufficiale, apre con prestigio e credibilità il nuovo secolo, torna indietro di qualche anno e racconta cosa è avvenuto intorno al 1894 tra la Sicilia e Roma: nell’isola la rivolta dei “Fasci”, che nasceva da una miserabile condizione economica e sociale, è stata repressa nel sangue dall’esercito italiano; a Roma, lo scandalo della Banca Romana ha infangato la credibilità dell’Italia e di una intera classe dirigente, seppellendo sotto un diluvio di fango le idealità risorgimentali. Difficile replicare a donna Ippolita Laurentano, moglie e madre di due valorosi garibaldini, quando denuncia, senza più illusioni, che la storia dello Stato unitario si è caratterizzata per «trenta e più anni di malgoverno»
[[ L. Pirandello, I vecchi e i giovani, in Tutti i romanzi, a cura di G. Macchia, con la collaborazione di M. Costanzo, Vol. II, Milano, Mondadori, 1973, 1994, p. 89.]].
 Sulla strada della denuncia degli esiti del Risorgimento nel meridione (una strada che è stata perscorsa, in anni più recenti, anche da Andrea Camilleri, che ha raccontato la storia di un impossibile cambiamento nel romanzo Un filo di fumo del 1980), con straordinaria coincidenza di date, si collocano anche gli esordi narrativi di Leonardo Sciascia e un romanzo come Il Gattopardo. Sciascia pubblica nel 1957 su rivista e l’anno successivo in volume il racconto Il quarantotto, che narra la storia del barone Garziano passato indenne dalla rivoluzione del ’48 e da quella garibaldina. Quando il protagonista aristocratico afferma: «Se rivoluzione dobbiamo fare la facciamo tutti, non vi pare?»
Sulla strada della denuncia degli esiti del Risorgimento nel meridione (una strada che è stata perscorsa, in anni più recenti, anche da Andrea Camilleri, che ha raccontato la storia di un impossibile cambiamento nel romanzo Un filo di fumo del 1980), con straordinaria coincidenza di date, si collocano anche gli esordi narrativi di Leonardo Sciascia e un romanzo come Il Gattopardo. Sciascia pubblica nel 1957 su rivista e l’anno successivo in volume il racconto Il quarantotto, che narra la storia del barone Garziano passato indenne dalla rivoluzione del ’48 e da quella garibaldina. Quando il protagonista aristocratico afferma: «Se rivoluzione dobbiamo fare la facciamo tutti, non vi pare?»
[[L. Sciascia, Il quarantotto, in Opere 1956-1971, a cura di C. Amboise, Milano, Bompiani, 1987, 2000, p. 285.]]
è difficile non pensare alla frase che Tancredi pronuncia nel dialogo con lo zio e che, spesso citata a sproposito e con errori di attribuzione, è divenuta l’emblema del Gattopardo. Quella del ’48, più che una vera trasformazione, è «un modo di sostituire l’organista senza cambiare né strumento né musica»
[[ Ivi, p. 294.]],
proprio come quella del 1860, nella quale, con un gesto che viene ripetuto anche dal Principe di Salina nel romanzo di Tomasi, basta mutare i quadri appesi alle pareti delle case aristocratiche, togliendo i ritratti dei re borbonici, per mettersi dalla parte del vincitore di turno ed accogliere Garibaldi (o i suoi ufficiali) nelle auguste dimore siciliane. La storia dei rapporti di Sciascia con Tomasi meriterebbe una ampia trattazione: ma qui ci limitiamo ad evidenziare – oltre alla sintonia tematica tra due testi scritti in contemporanea – il progressivo avvicinamento dell’autore del Giorno della civetta all’ideologia del Gattopardo. Dopo la lettura distante – e per molti aspetti pregiudiziale, viziata da una lontananza sociale e politica – del 1959, Sciascia, per tappe progressive, si è avvicinato al pessimismo di Tomasi, fino a rendergli omaggio, pur senza citarlo esplicitamente, in Porte aperte del 1987, utilizzando l’aggettivo più importante e significativo del Gattopardo e definendo Palermo una città «irredimibile»
[[ L. Sciascia, Porte aperte, in Opere. 1984-1989, a cura di C. Amboise, Milano, Bompiani, 1990, 2002, p. 380. E si potrebbe aggiungere che nell’ultimo testo di Sciascia, Una storia semplice, arrivato in libreria pochi giorni dopo la morte del suo autore, la frase «Ad un certo punto della vita non è la speranza l’ultima a morire, ma il morire l’ultima speranza» (ivi, p. 754) ricorda, nel suo essenziale pessimismo senza vie d’uscita, le parole del Principe Fabrizio nel Gattopardo: «Finché c’è morte c’è speranza».]].
È sul terreno dell’antirisorgimento e della disillusione politica che Sciascia entra in sintonia con Il Gattopardo.
Tutte le parti in causa nell’ambito del processo di unificazione nazionale vengono presentate sotto una luce negativa nelle pagine di Tomasi. Sui mazziniani grava il giudizio politico aristocratico che condanna coloro che vorrebbero sostituire la monarchia (una monarchia che, agli occhi del Principe, garantirebbe la continuità politica tra il vecchio regno borbonico e il nuovo Stato unitario)
[[ «[…] andava chiedendosi chi fosse destinato a succedere a questa monarchia che avesse i segni della morte sul volto. Il Piemontese, il cosiddetto Galantuomo che faceva tanto chiasso nella sua piccola capitale fuor di mano? Non sarebbe stato lo stesso? Dialetto torinese invece che napoletano; e basta».]]
con la repubblica (che trasformerebbe Fabrizio Corbera Principe di Salina nel semplice signor Corbera). I garibaldini vengono a più riprese presentati come «fanatici», «mafiosi e imbroglioni» (dal Principe), come «gentaglia», «uomini da colpi di mano, buoni a sparacchiare, e basta!» (da Cavriaghi, collega di Tancredi nell’esercito del Re di Sardegna, prossimo Re d’Italia), come «scamiciati, con facce di fanatici incurabili alcuni, altri con la grinta dei rivoltosi di mestiere» (dal colonnello Pallavicino che ha fermato Garibaldi sul Volturno e che riserva la sua stima al solo Generale, «la sola persona per bene che si trovasse da quella parte»). I liberali, rappresentati da don Ciccio Ferrara, il contabile di Donnafugata, e da Russo, il soprastante (oltre che da don Calogero Sedàra), sono «rapaci» e disonesti, legati alla mafia e pronti a utilizzare metodi mafiosi e violenti per raggiungere i propri fini; la loro conversione al liberalismo viene presentata come esclusivamente utilitaristica, lontana da autentici convincimenti politici, ispirata dalla convinzione di poter portare avanti con più facilità i propri traffici nel nuovo Stato unitario (il giudizio che il Principe dà dei liberali appare, da questo punto di vista, impietoso: «[…] questi liberalucoli di campagna volevano soltanto avere il modo di approfittare più facilmente. Punto e basta»). Ma se risultano negativi i giudizi riguardanti coloro che, pur animati da ideali diversi, svolgevano il ruolo di artefici del Risorgimento, non vengono certo presentati in modo positivo coloro che all’unificazione nazionale si opponevano e che tentavano di mantenere quello status quo che anche al Principe avrebbe potuto far comodo. Basterebbe pensare, da questo punto di vista, a come viene presentata l’agonizzante monarchia borbonica: il Principe ha spesso reso omaggio a Re Ferdinando – ora defunto e sostituito da un sovrano che «non era che un seminarista vestito da generale. E davvero non valeva molto» – e, di fronte ai nuovi avvenimenti storici, ripensa a quelle udienze: «si percorrevano – scrive Tomasi riferendo al lettore i pensieri di Fabrizio – interminabili sale di architettura magnifica e di mobilio stomachevole (proprio come la monarchia borbonica)» (e, molte pagine dopo, viene tra l’altro rammentata la «vessatoria censura borbonica»). Anche alla Chiesa non vengono risparmiate note polemiche: nei conventi che il Principe osserva durante l’incursione notturna a Palermo vivono uomini molto simili ai ribelli che appiccano fuochi intorno alla città: «fanatici come essi, chiusi come essi, come essi avidi di potere». E pure l’aristocrazia, la classe sociale alla quale appartiene il Principe, viene presentata con un fondamentale disprezzo, che riguarda coloro – come il cognato Màlvica – che non hanno capito la vanità della rivoluzione risorgimentale e che scappano impauriti dalla Sicilia, coloro che si inchinano e rendono omaggio al nuovo vincitore e coloro che, dopo l’avvenuta unificazione, festeggiano con grandi ricevimenti e balli la sopravvivenza della propria classe sociale, senza accorgersi che l’odore di morte ha ormai invaso tutte le dimore aristocratiche.
 Perché Il Gattopardo venga letto anche come un romanzo politico, al pari dei testi di Verga, De Roberto, Pirandello e Sciascia, basterebbe prendere in considerazione le pagine dedicate al giorno del Plebiscito. L’Italia, scrive Tomasi, è nata nel peggiore dei modi, in mezzo alla corruzione e ai brogli elettorali. Il Principe, durante una battuta di caccia in compagnia di don Ciccio Tumeo, ripensa a quella giornata che ha segnato una svolta nella storia della Sicilia: durante la votazione è successo qualcosa che non lo ha convinto ma che ancora non è riuscito a comprendere. È don Ciccio Tumeo ad aiutarlo a fare chiarezza: lui ha votato “no” all’unificazione della Sicilia con il Regno d’Italia, ma la sua opinione – come quella di altri uomini rimasti fedeli ai Borboni – è stata annullata nell’esito ufficiale dello scrutinio, unanimemente favorevole al processo di unificazione. Tutto diventa chiaro, tragicamente chiaro, agli occhi del Principe: il broglio elettorale ha accompagnato la nascita della nuova creatura politica, la sopraffazione – più melliflua, meno violenta rispetto a quelle tante volte provate nel passato
Perché Il Gattopardo venga letto anche come un romanzo politico, al pari dei testi di Verga, De Roberto, Pirandello e Sciascia, basterebbe prendere in considerazione le pagine dedicate al giorno del Plebiscito. L’Italia, scrive Tomasi, è nata nel peggiore dei modi, in mezzo alla corruzione e ai brogli elettorali. Il Principe, durante una battuta di caccia in compagnia di don Ciccio Tumeo, ripensa a quella giornata che ha segnato una svolta nella storia della Sicilia: durante la votazione è successo qualcosa che non lo ha convinto ma che ancora non è riuscito a comprendere. È don Ciccio Tumeo ad aiutarlo a fare chiarezza: lui ha votato “no” all’unificazione della Sicilia con il Regno d’Italia, ma la sua opinione – come quella di altri uomini rimasti fedeli ai Borboni – è stata annullata nell’esito ufficiale dello scrutinio, unanimemente favorevole al processo di unificazione. Tutto diventa chiaro, tragicamente chiaro, agli occhi del Principe: il broglio elettorale ha accompagnato la nascita della nuova creatura politica, la sopraffazione – più melliflua, meno violenta rispetto a quelle tante volte provate nel passato
[[«Sei mesi fa si udiva la voce dispotica che diceva: “fai come dico io, o saranno botte”. Adesso si aveva di già l’impressione che la minaccia venisse sostituita dalle parole molli dell’usuraio: “Ma se hai firmato tu stesso? Non lo vedi? È tanto chiaro! Devi fare come diciamo noi, perché, guarda la cambiale! La tua volontà è uguale alla nostra».]] –
ha prevalso, la democraticità della scelta è stata soltanto apparente. Quello che poteva apparire «un enigma piccolino» da sciogliere, è diventato «un enigma storico» e la sua soluzione non avrà più un significato privato, importante solo per il Principe che vuole cercare di capire, ma assumerà un senso storico, determinando un giudizio severissimo nei confronti del Risorgimento in Sicilia e influendo – come vedremo – sul giudizio complessivo riguardante la storia. Tanto più che l’arroganza del potere, l’annullamento della volontà dei cittadini che – sia pure in numero minoritario – avevano dichiarato la loro contrarietà all’unificazione, avrà conseguenze nei tempi a venire, conseguenze che Tomasi, in questo romanzo in cui non mancano gli «sprofondamenti in avanti»
[[Cfr. G. Raboni, Un romanzo del Novecento, in AA.VV., Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Cento anni dalla nascita, quaranta dal “Gattopardo”, Atti del Convegno – Palermo 12-14 dicembre 1996, a cura di F. Orlando, Palermo, Città di Palermo-Assessorato alla Cultura, 1999, p. 231.]],
non esita ad evidenziare: «Don Fabrizio non poteva saperlo allora, ma una parte della neghittosità, dell’acquiescenza per la quale durante i decenni seguenti si doveva vituperare la gente del Mezzogiorno, ebbe la propria origine nello stupido annullamento della prima espressione di libertà che a questo popolo si era mai presentata».
Il paesaggio, come altre volte nel Gattopardo, si carica di significati ideologici, si fa portatore di una visione politica, come nel pirandelliano I vecchi e i giovani la pioggia di fango che cade su Roma e imbratta la città, non già capitale degli ideali risorgimentali, ma centro della corruzione. Il vento che soffia incessantemente nel giorno del plebiscito – quel «ventaccio», quel «vento impuro» che diventerà, dopo la rivelazione di don Ciccio Tumeo, un «vento lercio» – muove l’aria imputridita ma porta con sé anche tante schifezze:
Verso le quattro del pomeriggio il Principe si era recato a votare […]; accigliato e pelli chiaro procedeva cauto verso il Municipio e spesso con le mani si proteggeva gli occhi per impedire che quel ventaccio, carico di tutte le schifezze raccolte per via, gli cagionasse quella congiuntivite cui era soggetto; e andava dicendo a Padre Pirrone che senza vento l’aria sarebbe stata come uno stagno putrido ma che, anche, le ventate risanatrici trascinavano con sé molte porcherie.
2. Il Gattopardo e la storia
Il Gattopardo è dunque, prima di tutto, un romanzo sul Risorgimento, ma non è solo un romanzo su un ben preciso periodo storico. È anche un testo che riflette sulla storia in generale. Scegliendo di ambientare la vicende narrate negli anni dell’unificazione nazionale, Tomasi di Lampedusa ha deciso di mettere al centro dell’attenzione un evento che ha rappresentato, nella secolare storia siciliana, l’ultimo sbarco di stranieri accompagnato dalle vane promesse di un miglioramento della situazione socio-economica. Ma, appunto, il 1860 diventa un anno emblematico per parlare di tanti altri periodi storici, più antichi e più recenti. Non a caso, scrivendo all’amico Enrico Merlo il 30 maggio 1957, Tomasi annotava tra l’altro: «Mi sembra che presenti un certo interesse perché mostra un nobile siciliano in un momento di crisi (che non è detto sia soltanto quella del 1860»); e, poco dopo, ribadiva nella stessa lettera: «La Sicilia è quella che è; del 1860, di prima e di sempre»
[[G. Lanza Tomasi, Premessa, in G. Tomasi di Lampedusa, Opere, Introduzione e premesse di G. Lanza Tomasi, I racconti, Letteratura inglese, Letteratura francese, a cura di N. Polo, Milano, Mondadori, 2004 (quinta edizione accresciuta e aggiornata), p. 18.]].

Occorre osservare, da questo punto di vista, che Il Gattopardo è incentrato su un periodo storico ben preciso, rivisitato però attraverso le esperienze più recenti vissute da Tomasi di Lampedusa. Nel romanzo, e soprattutto nel corso del colloquio con Chevalley, il Principe insiste nel ricordare che la Sicilia è stata da sempre terra di conquista e di sbarchi. Il Gattopardo ruota attorno al fondamentale biennio 1860-1861, ma questo momento storico conferma ciò che è avvenuto nel passato e viene a sua volta confermato da ciò che sarebbe avvenuto nel futuro, fuori dai limiti cronologici del testo ma all’interno dell’arco biografico di Tomasi. Per il passato, anche remoto, soccorrono gli studi storici e i ricordi di testimoni oculari: e il passato parla, per la Sicilia, di sbarchi che si sono ripetuti nel tempo, di dominatori che si sono succeduti nei secoli, di promesse di miglioramento mai mantenute. Ma se per il Principe Fabrizio l’ultimo sbarco “straniero” (e l’aggettivo, sia pure virgolettato, non appare improprio: quello di Arcetri, per il Principe astronomo, è un «osservatorio estero») è stato quello di Garibaldi e della sue camicie rosse, Tomasi, che scrive all’altezza della metà degli anni Cinquanta del ‘900, può raccontare la storia di una terra anche con la consapevolezza di chi ha assistito ad un ulteriore sbarco, quello delle truppe alleate nel 1943. Uno sbarco, quest’ultimo, per certi aspetti traumatico (la casa palermitana di Tomasi, la dimora da lui più amata come racconta nei Ricordi d’infanzia, è stata bombardata e distrutta: e non sarà un caso che alla distruzione di un palazzo nobiliare – quello dei Ponteleone – avvenuto nel 1943 ad opera di «una bomba fabbricata a Pittsburgh, Penn», si faccia riferimento nel romanzo) e che, come quello dei Mille, non ha portato in Sicilia i cambiamenti desiderati ed anzi è stato accompagnato dal trasformismo di molti, ex fascisti convertiti in fretta alla democrazia e pronti ad occupare i nuovi posti di potere.
La storia recente sembra restituire vita e valore a quella più lontana nel tempo. Le esperienze vissute rinnovano eventi storici del passato più remoto. A questo proposito, ci sembra di un qualche interesse una digressione sul tema della guerra presente nel Gattopardo. Lo scrittore che parla di guerra e che descrive le battaglie risorgimentali, è un uomo che ha conosciuto direttamente la prima e la seconda guerra mondiale, due eventi centrali in un percorso biografici più ricco dal punto di vista interiore e intellettuale che da un punto di vista esteriore. Tomasi ha combattuto al fronte tra il settembre del 1917 e il novembre dello stesso anno, mese in cui, fatto prigioniero, è stato deportato nel campo ungherese di Szombathely. Ha conosciuto, anche se per tre mesi, la guerra di trincea e, anche se di sfuggita, ha ricordato l’importanza dell’esperienza della Grande Guerra nella sua vita: ne fa cenno in una lettera inviata al cugino Casimiro Piccolo da Parigi il 27 luglio 1925
[[G. Tomasi di Lampedusa, Viaggio in Europa. Epistolario 1925-1930, a cura di G. Lanza Tomasi e S.S. Nigro, Milano, Mondadori, 2006, pp. 37-38.]]
e in una missiva destinata al compagno di sventura Bruno Revel (al quale, all’altezza del 1929, Tomasi racconta di essere rimasto colpito dalla lettura di un testo della memorialistica tedesca, Il soldato Suhrer di Georg von der Vring)
[[A. Vitello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cit., p. 148. Sull’esperienza di Tomasi nella prima guerra mondiale cfr. anche D. Gilmour, L’ultimo Gattopardo. Vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cit., pp. 46-50.]];
utilizza pagine critiche per svolgere alcune considerazioni sul conflitto e sul dopoguerra
[[Si vedano per esempio le prime due pagine del saggio dedicato a Paul Morand, apparso su «Le opere e i giorni» il 1° maggio 1926 (cfr. G. Tomasi di Lampedusa, Opere, cit., pp. 551-552).]];
rammenta l’esperienza del fronte – che lo ha visto anche nei panni del soldato che uccide – nelle pagine dei Ricordi d’infanzia
[[G. Tomasi di Lampedusa, Ricordi d’infanzia, in Opere, cit., p. 462]].
E, dopo gli anni della trincea e della prigionia, ha vissuto il dramma della seconda guerra e il terrore dei bombardamenti aerei, raccontato anche in alcune lettere inviate alla moglie, tra le quali una datata 2 marzo 1943, scritta dopo aver passato a Palermo dello ore terribili: «Sono state le più brutte della mia vita; neanche al fronte ho mai sofferto niente di simile […]. Lo stato della città e della popolazione era tale che era impossibile trasportare i bagagli alla stazione. Così ho lasciato le due valigie grandi in deposito all’hôtel e sono andato a piedi passando da via Roma, disseminata di tramway sventrati, di auto in fiamme e di viscere umane ed equine»
[[A. Vitello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cit., p. 210.]].
«Quando si vede quello che è successo – scrive poi il 9-10 maggio, dopo che è stato bombardato anche il palazzo Lampedusa – si ha voglia di sputare sul proprio passaporto di uomo»
[[Ivi, p. 216. In Ricordi d’infanzia, torna a ricordare il «giorno in cui le bombe trascinate da oltre Atlantico la cercarono [la casa] e la distrussero» (cfr. G. Tomasi di Lampedusa, Opere, cit., . 438).]].

I riferimenti alla guerra contenuti nel Gattopardo sono sicuramente il frutto di una diretta esperienza. La guerra resta «quel caos estremamente concreto e sudicio» nonostante le tranquillizzanti parole del Principe alla figlia Concetta, preoccupata per il destino dell’amato Tancredi sulle barricate palermitane. La descrizione del cadavere del giovane soldato che incontriamo nelle prime pagine, non è frutto di letture o di fantasia, ma è la realistica rappresentazione eseguita da chi ha visto con i propri occhi scene simili: «Lo avevano trovato bocconi nel fitto trifoglio, il viso affondato nel sangue e nel vomito, le unghie confitte nella terra, coperto dai formicoli; e di sotto le bandoliere gl’intestini violacei avevano formato pozzanghera. Era stato Russo, il soprastante, a rinvenire quella cosa spezzata, a rivoltarla, a nascondere il volto col suo fazzoletto rosso, a ricacciare con un rametto le viscere dentro lo squarcio del ventre, a coprire poi la ferita con le falde verdi del cappottane; sputando continuamente per lo schifo […]».
E in questa prospettiva – che ci pare sia stata fino ad ora ignorata – anche il giudizio limitativo sulle battaglie risorgimentali («[…] tutto sarebbe stato una commedia, una rumorosa, romantica commedia con qualche macchia di sangue sulla veste buffonesca»), oltre a rappresentare un ulteriore tassello della polemica nei confronti del Risorgimento (confermato poi dal ferimento subito da Tancredi, leggero ma sufficiente per portare in alto la sua fama di combattente) potrebbe acquistare un ulteriore significato se considerato anche come giudizio di chi ha conosciuto le guerre successive. Dopo la guerra di talpe sul fronte carsico e i bombardamenti del 1943, le battaglie risorgimentali (secondo un tema tipico di tanta letteratura e memorialistica bellica), fatte di dispiegamenti di truppe più o meno organizzate, combattute alla luce del sole e con strumenti di morte assai meno sofisticati di quelli adoperati nella prima guerra tecnologica del 1915-1918 e nel conflitto terminato con l’esplosione di due bombe atomiche, perdono gran parte della loro tragicità.
Nel suo rapporto con la storia, Il Gattopardo risulta un testo più complesso di quanto possa sembrare ad una lettura superficiale, sia per la sua plurivocità (i diversi personaggi hanno un differente modo di rapportarsi con la storia), sia perché il Principe, che meglio di ogni altro rappresenta la visione propria di Tomasi di Lampedusa, nel corso del romanzo conosce una trasformazione non solo fisica e biologica (dal cinquantenne delle prime pagine all’uomo che sul letto di morte traccia un bilancio completamente deficitario della propria esistenza), ma anche ideologica.
 Tancredi, il nipote prediletto, fin dalla prima parte del libro condensa la sua visione della storia nella frase più celebre del romanzo: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Il giovane aristocratico, che mantiene il titolo nobiliare ma ha perso le ricchezze, è l’uomo che sa adattarsi ai nuovi tempi, che si immerge nel corso della storia per non venirne travolto, che sceglie di partecipare ai moti garibaldini per orientarli verso una soluzione moderata (monarchica e non repubblicana), che crede nella possibilità di una trasformazione apparente e di un persistere reale, che si fa paladino dell’unione tra aristocrazia e borghesia emergente sposando Angelica Sedàra, «una così bella anfora colma di monete». Dal suo punto di vista, Tancredi non ha torto: la sua adattabilità, il suo trasformismo, gli consentono di diventare deputato e di mantenere, come il Consalvo Uzeda nei Vicerè, quel potere e quel prestigio che, altrimenti, gli sarebbero sfuggiti di mano. Abbracciando Angelica, è convinto di riprendere possesso della Sicilia, «della terra bella e infida sulla quale i Falconieri avevano per secoli spadroneggiato e che adesso, dopo una vana rivolta si arrendeva di nuovo a lui, come ai suoi da sempre, fatta di delizie carnali e di raccolti dorati».
Tancredi, il nipote prediletto, fin dalla prima parte del libro condensa la sua visione della storia nella frase più celebre del romanzo: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Il giovane aristocratico, che mantiene il titolo nobiliare ma ha perso le ricchezze, è l’uomo che sa adattarsi ai nuovi tempi, che si immerge nel corso della storia per non venirne travolto, che sceglie di partecipare ai moti garibaldini per orientarli verso una soluzione moderata (monarchica e non repubblicana), che crede nella possibilità di una trasformazione apparente e di un persistere reale, che si fa paladino dell’unione tra aristocrazia e borghesia emergente sposando Angelica Sedàra, «una così bella anfora colma di monete». Dal suo punto di vista, Tancredi non ha torto: la sua adattabilità, il suo trasformismo, gli consentono di diventare deputato e di mantenere, come il Consalvo Uzeda nei Vicerè, quel potere e quel prestigio che, altrimenti, gli sarebbero sfuggiti di mano. Abbracciando Angelica, è convinto di riprendere possesso della Sicilia, «della terra bella e infida sulla quale i Falconieri avevano per secoli spadroneggiato e che adesso, dopo una vana rivolta si arrendeva di nuovo a lui, come ai suoi da sempre, fatta di delizie carnali e di raccolti dorati».
La frase che condensa la sua ideologia influisce in maniera determinate sulla visione del Principe nella prima parte del romanzo. Il Principe Fabrizio è inizialmente convinto che il nipote abbia ragione: tutto resterà come prima. E non solo ripete in varie circostanze lo stesso concetto (replicando al liberale don Ciccio Ferrara, convinto di un prossimo miglioramento della situazione, afferma: «Tutto sarà lo stesso mentre tutto sarà cambiato»; guarda a quelle risorgimentali come a «battaglie combattute affinché tutto rimanga come è»; al figlio Paolo che chiede come si deve comportare con Tancredi in camicia rossa risponde rabbioso: «Cosa è cambiato?»), ma tutto ciò che avviene intorno rappresenta per il Prinicipe una conferma della teoria espressa da Tancredi: nonostante l’arrivo di Garibaldi, la fine del dominio borbonico e la nascita del Regno d’Italia, tutto resta immutato. I Piemontesi rendono omaggio al Principe di Salina chiamandolo “Eccellenza” e violando così le direttive di Garibaldi; grazie ad una raccomandazione, il gesuita padre Pirrone non viene espulso – come prevederebbe un decreto del Generale in camicia rossa – ma può continuare ad officiare presso la famiglia nobiliare; la rivoluzione non impedisce al Principe e alla famiglia di andare in villeggiatura a Donnafugata e quando le carrozze entrano in paese vengono accolte come se niente di nuovo fosse avvenuto:
Al di là del breve ponte le autorità stavano ad attendere, circondate da qualche diecina di contadini. Appena le carrozze entrarono sul ponte la banda municipale attaccò con foga frenetica “Noi siamo zingarelle” primo strambo e caro saluto che da qualche anno Donnafugata porgeva al suo Principe; e subito dopo le campane della Chiesa Madre e del convento di Spirito Santo, avvertite da qualche monello in vedetta, riempirono l’aria di baccano festoso. “Grazie a Dio, mi sembra che tutto sia come al solito” pensò il Principe scendendo dalla carrozza.

Il paese di Donnafugata si presenta «immutato» agli occhi del Principe, mentre le scritte che inneggiano a Garibaldi e inveiscono contro i Borboni sbiadiscono sui muri, simbolo di una rivoluzione recentissima ed effimera. Ma quando il Principe viene a sapere che Calogero Sedàra è divenuto ricco come lui e, poco dopo, lo vede salire in frack le scale del palazzo Salina, è costretto a rivedere la sua opinione. Il Sindaco rapace di Donnafugata, che è riuscito a sfruttare i moti liberali non tanto per fare l’Italia ma per fare gli affari suoi, ricchissimo e potente, rozzo ma sicuro di sé, senza titoli nobiliari ma con la forza del denaro dalla sua parte, dimostra che qualcosa è cambiato. Ascoltando la storia dei suoi recenti successi, il Principe pensa: «[…] non era vero che nulla era mutato; don Calogero ricco quanto lui! Ma queste cose, in fondo, erano previste, erano il prezzo da pagare». Don Calogero che sale le scale del palazzo nobiliare diventa il simbolo di una nuova classe sociale che scala i gradini della società e la dimostrazione – tangibile, immediatamente visibile, assai più eloquente dello sbarco di Garibaldi a Marsala, che era stato «un avvenimento previsto, non solo, ma anche lontano e invisibile» – che una Rivoluzione è avvenuta: «Adesso, sensibile com’egli era, ai presagi e ai simboli, contemplava la Rivoluzione stessa in quel cravattino bianco e in quelle due code nere che salivano le scale di casa sua». Non è vero che tutto resta come era. La storia non è immobile. E di lì a poco, dopo aver ricevuto la lettera con la quale Tancredi lo prega di chiedere da parte sua la mano di Angelica, capisce di trovarsi di fronte ad una «stupefacente accelerazione della storia». La storia cambia ma cambia in peggio: è quanto pensa al termine del colloquio con il cavaliere Aimone di Chevalley, un colloquio che mette di fronte l’ottimismo progressivo del piemontese – destinato a diventare pessimista dopo un più lungo soggiorno in Sicilia
[[ In uno dei frammenti che ruotano attorno al Gattopardo ma che non sono entrati a far parte del romanzo, indicato con il titolo Il canzoniere di casa Salina, accennando ad avvenimenti che avvengono intorno al 1863, Tomasi offriva un aggiornamento anche a proposito di Chevalley che, dopo aver trascorso tre anni in Sicilia (uno a Girgenti e due a Trapani) tornava in continente e, prima della partenza, andava a salutare il Principe «e ad esprimergli il proprio riconoscimento della sua sagacia».]] –
e il pessimismo senza vie di uscita del nobile siciliano («“Tutto questo” pensava “non dovrebbe poter durare; però durerà, sempre, il sempre umano, beninteso, un secolo, due secoli…; e dopo sarà diverso, ma peggiore»). E proprio al termine dei suoi giorni terreni, mentre si avvicina finalmente quella bella fanciulla il cui volto ha tante volte contemplato osservando le stelle, il Principe riconosce che qualcosa, a partire dal 1860, era cambiato: «Lui stesso aveva detto che i Salina sarebbero sempre rimasti i Salina. Aveva avuto torto. L’ultimo era lui. Quel Garibaldi, quel barbuto Vulcano aveva dopo tutto vinto».
3. Dalla storia all’eternità
Qualcosa è cambiato nella storia, ma non è cambiata l’essenza dell’uomo, che resta rapace, egoista, desideroso di dominare sugli altri, attaccato alla roba, valore supremo per il ceto aristocratico, per la borghesia emergente (basterebbe pensare a Calogero Sedàra e alla bella Angelica dalle «mani rapaci») e anche per il popolo (come dimostrano le vicende alle quali il lettore assiste grazie al soggiorno di padre Pirrone a San Cono). Per questo la storia dell’uomo resta una storia di sopraffazioni, di violenze, di corruzione. Nel giorno del Plebiscito, don Calogero mostra al Principe una lettera con la quale viene annunciato ai cittadini di Donnafugata un contributo di duemila lire per la fognatura, e nel comunicare questa grande notizia il Sindaco del paese inciampa in un lapsus profetico, che preannuncia opere pubbliche finanziate e mai concluse: «Venne mostrata a Don Fabrizio una lettera delle autorità di Girgenti che annunziava ai laboriosi cittadini di Donnafugata la concessione di un contributo di duemila lire per la fognatura, opera che sarebbe stata completata entro il 1961, come assicurò il Sindaco, inciampando in uno di quei lapsus dei qual Freud doveva spiegare il meccanismo molti decenni dopo». Da questo punto di vista, niente cambia prima e dopo lo sbarco di Garibaldi in Sicilia: e se cambia, cambia in peggio (se le cose si guardano dal punto di vista dell’onestà e della moralità), in meglio (se la prospettiva è quella dei disonesti, si chiamino Calogero Sedàra o Gaspare Ibba, protagonista del racconto I gattini ciechi, capitolo iniziale di quello che avrebbe dovuto essere il secondo romanzo di Tomasi )
[[«Tutto era meglio di prima»: è questo il pensiero di Gaspare Ibba, perseguitato dall’autorità giudiziaria borbonica che «aveva avuto il capriccio d’indagare circa uno dei soliti cadaveri trovati in campagna» e di nuovo al sicuro dopo lo sbarco di Garibaldi: «Poi vennero i Mille, tutto andò a soqquadro, gli incartamenti indiscreti scomparvero dalle cancellerie, e Gaspare Ibba tornò ufficialmente a casa sua» (cfr. G. Tomasi di Lampedusa, I gattini ciechi, in Opere, cit., p. 530).]].
Nella storia continueranno a succedersi rivoluzioni e ritorni all’ordine, conflitti aperti e tregue armate. E alle camicie rosse del presente succederanno altre camicie, di altro colore, come leggiamo in un passo del Gattopardo in cui si fa esplicito riferimento alla storia d’Italia successiva ai termini cronologici del romanzo. E non sarà un caso se l’accenno alle “camicie nere” è fatto dal colonnello Pallavicino, che ha fermato Garibaldi sul Volturno e che, manifestando tutta la sua amarezza, presenta al Principe un quadro desolato del nuovo stato unitario:
“Lei non è stato sul continente dopo la fondazione del Regno? Fortunato lei. Non è un bello spettacolo. Mai siamo stati tanto divisi come da quando siamo uniti. Torino non vuole cessare di essere capitale, Milano trova la nostra amministrazione inferiore a quella austriaca, Firenze ha paura che le portino via le opere d’arte, Napoli piange per le industrie che perde, e qui, qui in Sicilia sta covando qualche grosso, irrazionale guaio… Per il momento, per merito anche del vostro umile servo, delle camicie rosse non si parla più, ma se ne riparlerà. Quando saranno scomparse queste ne verranno altre di diverso colore; e poi di nuovo rosse […]”. Forse un po’ brillo, profetava. Don Fabrizio dinanzi alle prospettive inquietanti sentiva stringersi il cuore.
L’essenza dell’uomo resta la stessa, secolo dopo secolo, e immutato resta il destino umano. Nel Gattopardo, le riflessioni sul tempo storico lasciano uno spazio crescente alle riflessioni sulla atemporalità fuori dalla storia. C’è, nel romanzo, il tempo della storia e c’è anche l’eternità senza tempo.
Il Principe ha i piedi nella storia. Si misura con gli avvenimenti circostanti, alternando distacco e indifferenza (nella prima parte, per esempio, si addormenta mentre padre Pirrone lo aggiorna sull’arrivo dei garibaldini, tracciando un quadro della situazione assai poco tranquillizzante), curiosità (cerca di risolvere i dubbi, di approdare a qualche certezza, di acquietare le ansie della indecifrabilità del reale nella calma della comprensione) e disgusto (prova un «acuto ribrezzo verso la congiuntura sociale nella quale era incappato»). Accetta, non senza voltastomaco, di ingoiare i rospi che i cambiamenti lo costringono ad ingoiare, anche perché non crede nella possibilità di opporre resistenza al flusso degli eventi: per questo vota “sì” in occasione del Plebiscito e sostiene Tancredi che vuole unire, con il suo matrimonio, l’aristocrazia al tramonto con la sorgente borghesia. Anche il Principe si cala così nel tanto disprezzato «lento fiume pragmatistico siciliano», perché comunque si trova a vivere in un tempo storicamente determinato.
Ma il Principe, che ha i piedi nella storia, ha la testa nell’eternità. Sa che oltre alla vita terrena esiste l’infinito “prima” e l’altrettanto infinito “dopo”. Il Principe sa che esiste la morte, fa i conti con questa, la corteggia, la contempla quotidianamente osservando il cielo stellato
[[David Gilmour svolge alcune considerazioni che possono ulteriormente supportare il nostro ragionamento. Il biografo di Tomasi, infatti, mette di fronte due componenti del carattere del Principe, la sua sensualità e l’interesse per l’astronomia, corrispondenti rispettivamente a ciò che è corrotto e morente e a ciò che è immortale e incorruttibile. La sensualità appartiene alla dimensione temporale, le stelle a quelle dell’eternità: «Il Principe oscilla tra piaceri sibaritici e la contemplazione dell’eternità […]» (cfr. D. Gilmour, L’ultimo Gattopardo. Vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, p. 180).]].


Il Gattopardo è anche – e forse si potrebbe dire soprattutto – un romanzo sulla morte, un testo listato a lutto e a lutto incorniciato (si apre con le parole del rosario “Nunc et in hora nostrae mortis. Amen” e si conclude con la carcassa imbalsamata di Bendicò che viene scaraventata giù dalla finestra trovando pace «in un mucchietto di polvere livida»). La morte è un ammonimento per i vivi (il Viatico incrociato andando al fastoso ballo di palazzo Ponteleone è «un ammonimento salutare» per le persone sedute in carrozza). La sua presenza fa osservare gli avvenimenti circostanti da una prospettiva diversa, stravolge gli ordini di grandezza: ciò che appare fondamentale se osservato da una dimensione che tiene presente solamente il tempo, diventa irrilevante di fronte all’eternità. Se teniamo presente tutto questo, comprendiamo meglio la distanza che separa Tancredi dallo zio e la visione – solo apparentemente ambigua – che della storia ha il Principe. Il giovane rampollo di casa Salina appartiene alla schiera di coloro che sono dominati dalla «cecità», sia pure «passeggera» (prima o dopo, infatti, dovranno fare i conti con la morte) e in questa cecità considera solamente il tempo nel quale vive e quindi si adopera per mantenere ciò che, in questi angusti limiti, appare importante: il prestigio, il potere, la ricchezza, il successo. Tancredi è legato al tempo storico: «segue i tempi […] in politica come nella vita privata»; è «astuto e tempista». Per lui la conoscenza della morte è qualcosa di puramente intellettuale: può guardare, insieme ad Angelica, il quadro che rappresenta la “Morte del Giusto” di Greuze «con noncuranza assoluta», perché «la morte, sì, esisteva, senza dubbio, ma era roba ad uso degli altri». Il Principe sa che ciò che interessa a Tancredi è importante se la vita viene osservata da una prospettiva temporale, e anche per lui, quando prevale questa prospettiva, restano da salvaguardare il prestigio e la sopravvivenza dell’aristocrazia. Ma il Principe non è dominato dalla cecità: sa che oltre al tempo esiste l’eternità, si prepara al viaggio nelle tenebre, considera la vita sulla terra un breve raggio preceduto e seguito dal buio eterno. Un buio che non è rischiarato da una fede che assicura esistenze ultraterrene. Il «paesaggio irredimibile» sulla cui visione si conclude la visita di Chevalley a Donnafugata, è senz’altro il paesaggio siciliano, la terra natale del Principe e di Tomasi di Lampedusa che da venticinque secoli passa da un dominatore all’altro e che non vedrà risolti i suoi problemi neppure con lo sbarco di Garibaldi e con la nascita del nuovo Stato unitario; ma è soprattutto la metafora del destino dell’uomo che non conosce possibilità di redenzione. Tancredi, ha scritto Francesco Orlando, è l’alter ego del Principe, perché a lui è riservato il campo dell’azione mentre lo zio-intellettuale occupa la sfera della contemplazione
[[F. Orlando, L’intimità e la storia. Lettura del «Gattopardo», cit.: si vedano, in particolare, le osservazioni alle pp. 28-42, 79, 131-132.]]:
l’azione – aggiungiamo – appartiene al tempo, la contemplazione ha a che fare con l’eternità.
Ciò che avviene per il tempo, avviene anche per lo spazio. Il Gattopardo è un romanzo su un determinato periodo storico ma anche sulla storia in generale e sull’eternità; allo stesso modo, Il Gattopardo è un romanzo su una ben precisa regione italiana, la Sicilia (con l’omertà, i delitti mafiosi, gli uomini d’onore, la miseria e la sopraffazione, le «storie raccapriccianti, purtroppo sempre autentiche»), ma è anche un testo in cui questa terra rappresenta tante altre terre e si carica di valori metaforici, divenendo la waste land sulla quale l’uomo trascina la propria esistenza (e l’omonimo testo di T.S. Eliot appare significativamente al Tomasi lettore e critico una «straordinaria composizione»)
[[ Cfr. G. Tomasi di Lampedusa, Opere, cit., p. 1369.]],
la terra desolata trafitta dai raggi del sole (come scriveva un altro siciliano, Salvatore Quasimodo). La Sicilia di tante pagine del Gattopardo, riarsa, arroventata, rantolante, assetata, non risponde certo ad una semplice esigenza di descrizione oggettiva, ma diventa metafora della condizione umana, del deserto esistenziale che il Principe percepisce in tutta la sua drammaticità, tanto da paragonare il viaggio a Donnafugata alla propria vita, facendo coincidere l’incandescente asprezza della terra al tempo presente:
«[…] non aveva potuto fare a meno di paragonare questo viaggio schifoso alla propria vita, che si era svolta dapprima per pianure ridenti, si era inerpicata poi per scoscese montagne, aveva sgusciato attraverso gole minacciose per sfociare poi in interminabili ondulazioni di un solo colore, deserte come la disperazione».

La terra desolata rimanda all’immobilità non della storia umana ma del destino. Non può essere un caso se immagini paesaggistiche che trasmettono l’idea della mancanza di cambiamento siano affiancate, spesso, a passi in cui si descrive la trasformazione in corso nella storia o la dimensione temporale dell’esistenza («Natura immutabile che relativizza i mutamenti sociali e politici, mentre questi non tangono quella»).
[[ F. Orlando, L’intimità e la storia. Lettura del «Gattopardo», cit., p. 116.]].
Dopo aver ascoltato le parole piene di fiducia di don Ciccio Ferrara, che crede nell’arrivo di tempi migliori, don Fabrizio ripensa alle dominazioni che si sono succedute in Sicilia – con le immancabili promesse di miglioramento –, pensa alle trattative che seguiranno la rivoluzione risorgimentale («Trattative punteggiate da schioppettate quasi innocue») e poi osserva gli eterni fianchi del Monte Pellegrino: «Guardava i fianchi di Monte Pellegrino arsicci, scavati ed eterni come la miseria» (dove «miseria» fa riferimento, più che alla situazione sociale di tante persone, alla condizione dell’uomo). Le riflessioni sulla situazione politica che si succedono nella mente del Principe nella prima parte del libro vengono interrotte dalla contemplazione del sole, «autentico sovrano» della Sicilia (assai più dell’agonizzante Re borbonico o di Vittorio Emanuele in ascesa): «Il sole […] si rivelava come l’autentico sovrano della Sicilia: il sole violento e sfacciato, il sole narcotizzante anche, che annullava le volontà singole e manteneva ogni cosa in una immobilità servile […]». È sufficiente allontanarsi da Donnafugata e immergersi nell’«immemoriale silenzio della Sicilia pastorale» perché i rivolgimenti politici e sociali appaiano lontani e insignificanti di fronte all’immutabilità delle contrade: «Si era subito lontani da tutto, nello spazio e ancor più nel tempo. Donnafugata con il suo palazzo e i suoi nuovi ricchi era appena a due miglia ma sembrava sbiadita nel ricordo come quei paesaggi che talvolta s’intravedono allo sbocco lontano di una galleria ferroviaria; le sue pene e il suo lusso apparivano ancor più insignificanti che se fossero appartenuti al passato, perché rispetto all’immutabilità di queste contrade fuori di mano sembravano far parte del futuro». È in mezzo a questa natura «che se ne infischiava» dell’arrabattarsi umano, percorrendo un paesaggio che da venticinque secoli è lo stesso, attraversato da un vento «noncurante» e sempre identico, che il Principe tenta di collocare nella giusta dimensione tutti gli affanni e le preoccupazioni che lo hanno travolto a Donnafugata; è in questa dimensione che ripensa alla giornata del Plebiscito: una giornata fondamentale per la storia, ma che si è conclusa con il ritorno eterno della notte che, come sempre, avvolge tutto: «[…] alle otto tutto era finito, e non rimase che l’oscurità come ogni altra sera, da sempre».
La dimensione dell’eternità influisce sulla visione della esistenza umana e anche della storia. Nel palazzo Panteleone, un Principe sempre più malinconico guarda Tancredi e Angelica e pensa a «quei loro corpi destinati a morire», osserva le altre coppie che ballano e prova pietà per il comune destino. C’è, in questa pagina, il tempo e c’è anche l’eternità. Non a caso è proprio in questo punto del romanzo che Don Fabrizio mette a confronto il carattere effimero della vita e il persistente destino di morte, giungendo a quell’«approdo solidaristico», da Ginestra leopardiana, di cui ha parlato Samonà
[[G.P. Samonà, Il Gattopardo. I racconti. Tomasi, cit., p. 157.]]:
I due giovani si allontanavano, altre coppie passavano, meno belle, altrettanto commoventi, immerse ciascuna nella propria passeggera cecità. Don Fabrizio sentì spetrarsi il cuore: il suo disgusto cedeva il posto alla compassione per questi effimeri esseri che cercavano di godere dell’esiguo raggio di luce accordato loro fra le due tenebre prima della culla, dopo gli ultimi strattoni. Come era possibile infierire contro chi, se ne è sicuri, dovrà morire? […] Non era lecito odiare altro che l’eternità.
E non a caso, poco prima, giungendo nella sala da ballo tutta dorata, ha ripensato all’immutabile paesaggio siciliano, mentre le note del valzer gli hanno riportato alla mente il vento che da sempre ha soffiato e che per sempre soffierà sulla terra: «Il valzer le cui note traversavano l’aria calda gli sembrava solo una stilizzazione di quell’incessante passaggio dei venti, che arpeggiano il proprio lutto sulle superfici assetate, ieri, oggi, domani, sempre, sempre, sempre». Il vento che si caricava di valori politici nella parte del romanzo dedicata allo storico giorno del Plebiscito, porta con sé un significato esistenziale in queste pagine dedicate all’eternità.
Giovanni Capecchi
LINK: Il Gattopardo: l’estraneità alla Storia. Intervista ad Andrea Camilleri a firma di Giovanni Capecchi.
Articolo pubblicato da Altritaliani il 2 ottobre 2010