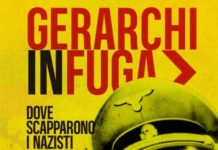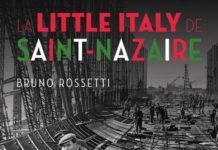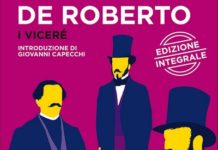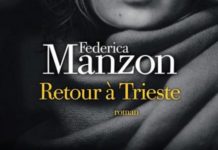Nell’ambito del Festival Italissimo 2025 diretto da Fabio Gambaro* è stata presentata all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, in presenza della scrittrice, l’edizione in lingua francese del suo libro “Vita mia”. Dacia Maraini è una grande signora della letteratura italiana, dalla vita e dall’opera ricca e appassionante. Ha molto da condividere a cominciare dai due anni trascorsi nel campo giapponese dove lei da bambina fu imprigionata con la sua famiglia nel 1943, un’esperienza durissima che l’ha segnata e che svela nel libro “Vita mia”.

*****
Il trattamento degli italiani antifascisti arrestati dopo l’8 settembre 1943 in Giappone non è stato migliore di quelli in Germania per non aver aderito alla Repubblica di Salò.
Lo hanno ricordato recentemente sia lo storico Eugenio Di Rienzo in “Un’altra resistenza” (ed. Rubettino 2024, tra cui quella dei diplomatici italiani che per questo motivo sono stati lì internati senza i riconoscimenti d’immunità), sia Dacia Maraini in occasione dell’edizione francese di “Vita mia” (éd. Payot-Rivages 2025), con titolo in italiano (dell’edizione Rizzoli 2023) cui segue “Une enfant italienne dans une prison japonaise (1943-1945)”.
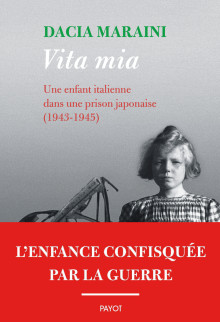 La presentazione del 4 aprile di questo libro all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, nel dialogo tra il Direttore Antonio Calbi e l’autrice, è stata la conferma non solo della notorietà di questa scrittrice in Francia per la quantità di pubblico presente, ma anche di come la sua “vita” estesa a quella famigliare non abbia avuto un solo istante banale: dall’infanzia, quando nel 1938 a due anni d’età era stata portata dal padre Fosco, antropologo orientalista, insieme alla moglie Topazia Alliata di Villafranca in Giappone, dove sono nate le sue sorelle Yuki e Toni e dove le ricerche del padre erano state interrotte dal loro arresto; e dall’adolescenza quando, stabilitasi nel 1945 la famiglia a Bagheria (dall’omonimo romanzo autobiografico, ed. Rizzoli 1993), aveva sentito quel peso delle tradizioni nobili e di famiglia dal quale la madre era fuggita nel 1935 sposando Fosco a Firenze, e dal quale lei stessa (nata a Fiesole nel 1936) era fuggita nel 1956 raggiungendo il padre a Roma, lì stabilitosi da Firenze dov’era tornato dopo la separazione dalla moglie e dalla società siciliana di quei tempi. O dal peso che questa costituiva su di un uomo che alla cultura avuta dalla famiglia (dal padre Antonio, scultore e critico d’arte in auge durante il fascismo, con i dissensi del figlio: Segretario generale della Biennale di Venezia dal 1928 al 1942 e come tale anche Commissario del Padiglione Italiano all’Expo di Parigi del 1937, e dopo la guerra Presidente dell’Accademia del Disegno a Firenze; e dalla madre inglese di origini polacche e ungheresi) aveva aggiunto la cultura orientalista fino al punto di parlare nove lingue, e di essersi immedesimato drammaticamente nel “bushido”, ossia nel codice dei samurai di dimostrazione del coraggio tagliandosi nel campo di concentramento di Nagoya il mignolo di fronte alla guardia giapponese affinché aumentasse la razione di cibo alle figlie.
La presentazione del 4 aprile di questo libro all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, nel dialogo tra il Direttore Antonio Calbi e l’autrice, è stata la conferma non solo della notorietà di questa scrittrice in Francia per la quantità di pubblico presente, ma anche di come la sua “vita” estesa a quella famigliare non abbia avuto un solo istante banale: dall’infanzia, quando nel 1938 a due anni d’età era stata portata dal padre Fosco, antropologo orientalista, insieme alla moglie Topazia Alliata di Villafranca in Giappone, dove sono nate le sue sorelle Yuki e Toni e dove le ricerche del padre erano state interrotte dal loro arresto; e dall’adolescenza quando, stabilitasi nel 1945 la famiglia a Bagheria (dall’omonimo romanzo autobiografico, ed. Rizzoli 1993), aveva sentito quel peso delle tradizioni nobili e di famiglia dal quale la madre era fuggita nel 1935 sposando Fosco a Firenze, e dal quale lei stessa (nata a Fiesole nel 1936) era fuggita nel 1956 raggiungendo il padre a Roma, lì stabilitosi da Firenze dov’era tornato dopo la separazione dalla moglie e dalla società siciliana di quei tempi. O dal peso che questa costituiva su di un uomo che alla cultura avuta dalla famiglia (dal padre Antonio, scultore e critico d’arte in auge durante il fascismo, con i dissensi del figlio: Segretario generale della Biennale di Venezia dal 1928 al 1942 e come tale anche Commissario del Padiglione Italiano all’Expo di Parigi del 1937, e dopo la guerra Presidente dell’Accademia del Disegno a Firenze; e dalla madre inglese di origini polacche e ungheresi) aveva aggiunto la cultura orientalista fino al punto di parlare nove lingue, e di essersi immedesimato drammaticamente nel “bushido”, ossia nel codice dei samurai di dimostrazione del coraggio tagliandosi nel campo di concentramento di Nagoya il mignolo di fronte alla guardia giapponese affinché aumentasse la razione di cibo alle figlie.
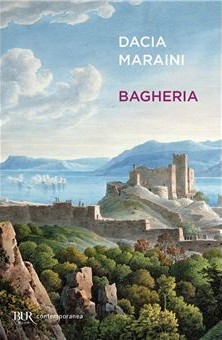 Se la società siciliana appariva dunque pesante alla famiglia (comprese le influenze mafiose nell’edilizia del dopoguerra), alla madre Topazia appariva comunque doveroso nel 1946, alla morte di suo padre, continuarne la tradizione gestendo l’azienda vinicola (cantine di Casteldaccia: Corvo di Salaparuta) fino al 1961, quando era stata ceduta alla Regione. Dovere che Topazia aveva sentito nonostante l’attrazione per la pittura per cui era già nota come donna avanguardista: prima o tra le prime frequentatrici della Scuola del Nudo a Palermo nel 1932, e frequentatrice del gruppo di cui facevano parte, tra gli altri, Giovanni Rosone, Giovanni Barbera e Renato Guttuso che l’aveva più volte ritratta.
Se la società siciliana appariva dunque pesante alla famiglia (comprese le influenze mafiose nell’edilizia del dopoguerra), alla madre Topazia appariva comunque doveroso nel 1946, alla morte di suo padre, continuarne la tradizione gestendo l’azienda vinicola (cantine di Casteldaccia: Corvo di Salaparuta) fino al 1961, quando era stata ceduta alla Regione. Dovere che Topazia aveva sentito nonostante l’attrazione per la pittura per cui era già nota come donna avanguardista: prima o tra le prime frequentatrici della Scuola del Nudo a Palermo nel 1932, e frequentatrice del gruppo di cui facevano parte, tra gli altri, Giovanni Rosone, Giovanni Barbera e Renato Guttuso che l’aveva più volte ritratta.
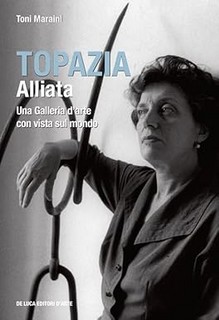 La personalità di Topazia (figlia della cantante cilena Sonia Ovalle de Olivares), dal 1959 al 1964 anche gallerista a Trastevere, ha influito allora non meno di quella di Fosco nella formazione delle figlie, come Toni ha scritto nella biografia “Topazia Alliata. Una Galleria d’arte con vista sul mondo” (ed. De Luca, 2022), dopo aver riportato anche i racconti di prigionia che la madre le aveva fatto non potendo più scriverli nel suo diario essendo stata esaurita l’ultima matita.
La personalità di Topazia (figlia della cantante cilena Sonia Ovalle de Olivares), dal 1959 al 1964 anche gallerista a Trastevere, ha influito allora non meno di quella di Fosco nella formazione delle figlie, come Toni ha scritto nella biografia “Topazia Alliata. Una Galleria d’arte con vista sul mondo” (ed. De Luca, 2022), dopo aver riportato anche i racconti di prigionia che la madre le aveva fatto non potendo più scriverli nel suo diario essendo stata esaurita l’ultima matita.
In “Vita mia” Dacia prosegue le descrizioni de “La nave per Kobe. Diari giapponesi di mia madre” (ed. Rizzoli 2001), con altre considerazioni non meno riflessive: il ritorno dopo la guerra con suo padre a Nagoya dove intanto la scomparsa del luogo d’internamento non aveva potuto non suscitare i sentimenti ambigui; il dormire abbracciati per scaldarsi; le visite durante la prigionia del rappresentante della Repubblica di Salò Principini e di quello della Croce Rossa Angst, durante le quali perfino i cognomi dell’antimonarchico e dello svizzero (Angst=angoscia) sembravano una farsa come quella per cui i prigionieri erano stati quel giorno maggiormente nutriti; e quella del Delegato Apostolico Marella, la cui promessa d’intervenire “in alto” aveva avuto come risultato solo l’aumento della razione di cibo per qualche giorno.
In “Vita mia” il confronto con i campi di concentramento in Polonia e Germania, su cui l’autrice si è dedicata assai profondamente, è drammaticamente quello dell’organizzazione degli orrori, già riflessi nel suo precedente romanzo “Il treno dell’ultima notte” (ed. Rizzoli 2008), con la protagonista alla ricerca nel 1956 d’un amico ebreo scomparso durante la guerra, tramite le frequentazioni a Vienna e Budapest delle persone utili a questo fine e soprattutto tramite i racconti delle vicissitudini loro e dei loro parenti in quei drammi. E negli orrori sono compresi quelli dei sacerdoti internati per l’opposizione al regime, ricordati da Primo Levi, compreso Monsignore Gabriel Piquet che, sotto Vichy dal 1940 al 1944, era stato poi internato a Dachau per avere nascosto numerosi ebrei.
 Dopo il terribile campo di prigionia, il “santuario della grande saggezza”, “Kosai”, nella regione di Koromo ove i Maraini erano stati trasferiti nel dicembre 1944 sembrava quasi, con il suo nome e il paesaggio delle sue colline, anticipare il ritorno alla normalità in antitesi alla guerra. Normalità anche di pascolare la capra (seppure “di proprietà del governo imperiale nipponico”) per nutrirsi e fornire il latte, e normalità per Topazia d’avere una macchina per ricucire i vestiti dei giapponesi in cambio di maggiori razioni alimentari. Normalità, queste, insieme ai bombardamenti finché quelli atomici di Hiroshima e Nagasaki hanno costretto nell’agosto 1945 l’Imperatore Hirohito alla saggezza “terrena” di parlare alla radio per annunciare la resa firmata il 2 settembre successivo. E “saggezza” delle guardie giapponesi in quanto poi scomparse per il disonore. “Saggezza”, infine, dopo che i Maraini erano stati portati a Tokyo, di arruolare Fosco come interprete tra gli americani e i giapponesi, fino a quando erano stati imbarcati in una nave americana per l’Europa.
Dopo il terribile campo di prigionia, il “santuario della grande saggezza”, “Kosai”, nella regione di Koromo ove i Maraini erano stati trasferiti nel dicembre 1944 sembrava quasi, con il suo nome e il paesaggio delle sue colline, anticipare il ritorno alla normalità in antitesi alla guerra. Normalità anche di pascolare la capra (seppure “di proprietà del governo imperiale nipponico”) per nutrirsi e fornire il latte, e normalità per Topazia d’avere una macchina per ricucire i vestiti dei giapponesi in cambio di maggiori razioni alimentari. Normalità, queste, insieme ai bombardamenti finché quelli atomici di Hiroshima e Nagasaki hanno costretto nell’agosto 1945 l’Imperatore Hirohito alla saggezza “terrena” di parlare alla radio per annunciare la resa firmata il 2 settembre successivo. E “saggezza” delle guardie giapponesi in quanto poi scomparse per il disonore. “Saggezza”, infine, dopo che i Maraini erano stati portati a Tokyo, di arruolare Fosco come interprete tra gli americani e i giapponesi, fino a quando erano stati imbarcati in una nave americana per l’Europa.
“Saggezza” rimasta da allora nei Maraini avendo ognuno di loro ricostruito “una vita” degna di questo nome al loro rientro in Italia, e in Dacia avendo scritto nella “Vita mia” di non sapere se tutti i criminali (come i due omicidi conosciuti a Rebibbia quando vi ha organizzato la biblioteca) possono pentirsi, ma di credere nel carcere rieducativo anziché in quello repressivo e in una condizione disastrosa innanzitutto per loro; e di non detestare il Giappone: “anche durante la prigionia ho conosciuto la gentilezza, la generosità e la solidarietà della gente comune, poco importano il sadismo, la follia nazionalista e il disprezzo razziale dei guardiani”. In Europa i Paesi si sono fatti la guerra senza tener conto degli interessi comuni: “forse sappiamo finalmente che ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide”, e che “i Paesi minori, trincerati dietro le loro frontiere, saranno divorati da quelli più grandi se non si alleano tra di loro”; “purtroppo si assiste per reazione alla crescita di potenze arcaiche che tentano di riportarci all’era delle nazioni l’una contro l’altra armate”; “idee in controcorrente con la Storia”: dovrebbero “morire come muoiono tanti sentimenti di pretese contrarie all’evoluzione e ai cambiamenti indispensabili alla coesistenza pacifica”.
Dacia ha anche scritto d’avere prudentemente continuato a nascondere una o due zolle di zucchero sotto al cuscino! Altra saggezza?
Lodovico Luciolli
*L’evento è stato organizzato in partenariato con Les Ateliers de Cribeau di Parigi
LE LIVRE PRÉSENTÉ, édition française
Vita mia
Une enfant italienne dans une prison japonaise (1943-1945)
Auteur: Dacia Maraini
Editeur Payot-Rivages, janvier 2025
Description: À l’automne 1943, l’ethnologue italien Fulco Maraini et sa famille, installés depuis cinq ans au Japon, sont incarcérés à Nagoya avec quelques compatriotes pour avoir refusé de prêter allégeance à la nouvelle république mussolinienne de Salò. Leurs geôliers détournent la nourriture et les transforment ainsi en «savants de la faim», comme dit Fulco. Jusqu’au jour où il applique le code d’honneur des samouraïs et se tranche un doigt devant un gardien insultant. Il reçoit en retour une chèvre dont le lait sauvera les captifs. Un témoignage poignant sur l’enfance confisquée par la guerre ; une expérience qui est pour beaucoup dans la vocation de l’écrivaine engagée, grande dame des lettres italiennes.