C’era una volta il lupo cattivo che mangiava Cappuccetto rosso e la nonna, che aggrediva l’incolpevole agnello, che divorava i sette capretti, che inseguiva i tre porcellini, che braccava lo spensierato Pierino sulle note della musica di Prokofiev, che ne combinava di tutti i colori e che perdeva il pelo ma non il vizio.

C’era una volta, appunto. Oggi, invece, grazie ai “buoni sentimenti” del “politicamente corretto”[1], non si deve più avere paura del lupo, perché è diventato buono[2], come annuncia, in una nota pubblicità, una bambina vestita da cappuccetto rosso con a fianco un lupo docilissimo[3]. Il lupo, quindi, “non deve” più essere considerato come – secondo tradizione[4] – il pericolo in persona, animale crudele, scaltro e insaziabile nella sua voracità, seminatore di morte e di terrore tra abitanti e viaggiatori indifesi, tra pastori e cacciatori. Sì che, colui al quale viene scherzosamente rivolto, in occasione di una prova difficile, l’augurio “in bocca al lupo” non può più rispondere “crepi”[5] – perché sarebbe tacciato, per la sua insensibilità, di essere “politicamente scorretto” – bensì “viva il lupo”. Per giustificare tale straordinaria metamorfosi, al fine dichiarato di salvaguardare le specie in via di estinzione[6] e di smetterla di spaventare i bambini con la storia del lupo cattivo (in ossequio al protezionismo cognitivo ed emotivo nei confronti della vulnerabile generazione “fiocco di neve”)[7], è stato spiegato che il lupo, essendo ormai diventato un animale inoffensivo (forse, chissà, anche vegetariano), in realtà usa le sue fauci non già per assecondare il suo presunto istinto predatorio, bensì per trasportare amorevolmente i suoi cuccioli da una tana all’altra in caso di pericolo (pertanto, non c’è posto più sicuro della bocca del lupo), proprio come narra la storia del lupo di Gubbio dei Fioretti di San Francesco[8]. Ecco, dunque, quale sarebbe il vero significato dell’augurio “in bocca al lupo”, ed ecco perché “si deve” rispondere sempre “viva il lupo”.
Questa reinterpretazione “buonista” del mondo animale ha comportato, com’è noto, la messa all’indice o, nella migliore delle ipotesi, la rilettura di molte favole (e non solo quella di Cappuccetto rosso, in cui il lupo non viene ucciso dal cacciatore, ma se la dà a gambe levate, non prima di aver fatto uscire dalla sua pancia, con un colpo di tosse, Cappuccetto rosso e la nonna, sane e salve), in chiave politicamente corretta. Si pensi, ad esempio, alla messa all’indice, in Giappone, della favola di Pinocchio, con l’accusa di discriminazione verso i disabili, essendo (evidentemente, nell’immaginario nipponico) i “cattivi” – la volpe zoppa e il gatto cieco – invariabilmente segnati da un handicap fisico, come riflesso di una depravazione morale. Si pensi, ancora, alla proposta di cambiare il finale de La piccola fiammiferaia “ per rendere la storia più allegra”, o alle accuse di “sessismo” e di “razzismo” rivolte alle favole dei fratelli Grimm dalla ministra tedesca della Famiglia, Kristina Schroder, o ancora al divieto – nel Regno Unito – della visione di Biancaneve e i sette nani ai minori di 16 anni non accompagnati da un adulto e all’assoluto divieto per i minori di 12 anni, per la presenza, nella pellicola, di “elementi macabri, gotici e spaventosi” (si alludeva, in particolare, a scene come la fuga nel bosco, la trasformazione della regina in vecchia e il momento della sua morte, scene addirittura tagliate dalla censura svedese); e via esemplificando.
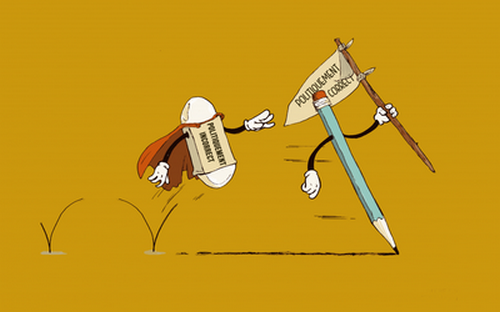
Tale fenomeno non può non riportare alla mente quanto accadeva in Unione Sovietica, nel periodo stalinista, allorché i protagonisti dei racconti popolari e perfino delle creazioni artistiche ad essi ispirati[9] dovettero in qualche modo essere resi funzionali[10] – e perciò piegati – all’ideale dell’eroe positivo. Così, ad esempio, proprio per aderire a questo nuovo ideale, lo svolgimento narrativo – segnatamente, il finale – de Il lago dei cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij, pietra miliare del balletto classico, venne modificato. Nella versione di Vladimir Bourmeister del 1953, infatti, dopo un combattimento tra il malvagio mago Rothbart e il principe Siegfried, questi riesce a sconfiggere il mago e Odette riprende le sue sembianze umane, potendo così vivere il proprio sogno d’amore con il principe.
Rimanendo all’esempio più su riportato, la storia del lupo e di Cappuccetto rosso è l’indice – solo in apparenza ameno – di una tendenza, oggi assai diffusa (e non soltanto in Italia), a rendere “politicamente” accettabile una storia, un dramma, un’opera d’arte, una favola cambiandone la trama o il finale ovvero epurandone il testo, oppure modificandone l’interpretazione anche di là dalle intenzioni dell’autore. Si pensi, ad esempio, al Mercante di Venezia di Shakespeare, “censurato” – da alcuni – per il forte antisemitismo che ispira il personaggio di Shylock (immaginario usuraio ebreo, demonio grottesco e vittima “naturale” del “giusto” castigo che gli verrà inflitto), ovvero “purificato” – da altri – attraverso interpretazioni adeguatrici dello stesso Shylock, visto come figura tragica, controcorrente rispetto alla cultura cristiano-occidentale tradizionalmente anti-ebraica dei tempi di Shakespeare, in quanto vittima delle continue calunnie e pubbliche umiliazioni ingiustamente subite ad opera di Antonio, alle quali si ribella con la richiesta della penale omicida.
Discorso analogo vale per l’altro capolavoro, La bisbetica domata, tra le più rappresentate e celebri commedie del drammaturgo inglese e sicuramente tra le più discusse se vista con occhi contemporanei, in considerazione della scelta di Caterina, che nel famoso monologo finale si assoggetta ai “voleri” e ai “valori” di Petruccio, suo novello sposo, uomo dalle maniere “forti”[11].
Atteggiamenti – questi – palesemente antistorici, che alla contestualizzazione dell’opera nel tempo in cui fu concepita preferiscono la sua idealistica e insensata attualizzazione. A questa stregua, bisognerebbe “epurare” lo stesso Dante Alighieri, per aver etichettato gli omosessuali col termine di “sodomiti” (secondo la terminologia del tempo) e per averli considerati (sempre, secondo la morale del tempo), “violenti contro Dio” in quanto “peccatori contro natura”, collocandoli all’Inferno, costretti, per la legge del contrappasso[12], a correre sotto una pioggia di fuoco, condannati in eterno a non fermarsi mai per evitare di essere inchiodati al suolo senza potersi proteggere dalle fiamme[13].
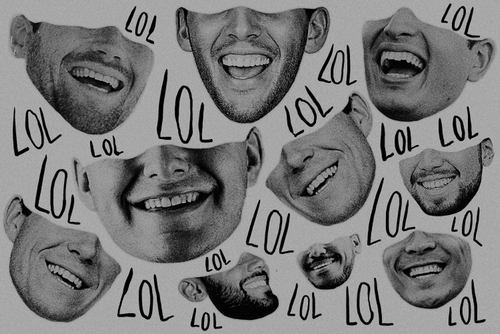
Questi, appena evidenziati, sono soltanto alcuni degli eccessi del politicamente corretto, ma ve ne sono molti altri, sempre riguardanti il piano linguistico-culturale[14], che, nell’illusione – per dirla con Hughes – che “il male e la sventura svaniscano con un tuffo nelle acque dell’eufemismo”, raggiungono risultati spesso grotteschi. Si pensi al bizantinismo di certi appellativi che sfumano negli anni: quelli che un tempo venivano chiamati, brutalmente, “minorati” sono diventati prima “invalidi”, poi “handicappati”, successivamente “portatori di handicap”, quindi “disabili”, infine “diversamente abili” (evidentemente, per escludere termini che sottintendono un’inferiorità rispetto a uno standard, a favore di termini che suggeriscono un’idea di mera “diversità”). Frequente è pure il ricorso alla denominazione negativa (“non vedenti” per ciechi[15], “non udenti” per sordi, “non deambulanti” – o addirittura “ipocinetici” – per paralitici, “persona non vivente” per cadavere), o alla perifrasi (“verticalmente svantaggiato” per chi è affetto da nanismo: immaginate una fiaba dal titolo Biancaneve e i sette uomini verticalmente svantaggiati).
A tal riguardo, Natalia Ginzburg, in Non possiamo saperlo, ha scritto che le parole ”non vedente” e “non udente” sono state coniate «con l’idea che in questo modo i ciechi e i sordi siano più rispettati, ma la nostra società non offre ai ciechi e ai sordi nessuna specie di solidarietà o di sostegno, ma ha coniato per il loro falso rispetto di queste nuove parole. Le troviamo artificiali e ci offendono le orecchie e francamente le detestiamo».
L’ossessione di non offendere l’altrui sensibilità – in primo luogo, quella religiosa – fa sì che perfino gli auguri debbano essere politicamente corretti: così, è ritenuto offensivo per le altre fedi utilizzare termini che hanno una connotazione religiosa, per cui anziché “buon Natale” meglio dire “buone feste”; per la datazione, anziché “avanti (o dopo) Cristo” meglio dire “prima (o dopo) dell’era volgare”[16]; e, poi, niente più simboli religiosi, come croci o presepi, anche se propri della cultura del luogo, e così via.
Il politicamente corretto, inoltre, “promuove” la condizione dei lavoratori cambiando loro il nome, senza neanche interpellare le categorie interessate (il che costituisce già un fattore di discriminazione): per cui abbiamo il personale “non docente” e quello “paramedico” (sappiamo solo quello che “non” fanno), abbiamo un’inflazione di “operatori” – ecologici, sanitari, socio-sanitari, scolastici, penitenziari, balneari ecc. – che non si capisce bene quale mestiere esercitino e non si sa se si sentano gratificati dal nuovo nome, che ha in sé qualcosa di distaccato e burocratico, se non, addirittura, di disumanizzante.
Per non dire della velatura ipocrita delle perifrasi e degli eufemismi: così, ad esempio, meglio dire “ottimizzazione aziendale” che “licenziamenti di massa”; meglio “esuberi” che “lavoratori da licenziare”, meglio “delocalizzazione” che “chiusura e trasferimento all’estero dell’azienda”, meglio “danno collaterale” che “vittime civili dell’azione militare”, e via esemplificando.
Si ha quasi l’impressione di avere a che fare con la “neolingua” immaginata da Orwell nel romanzo 1984, dove si prospetta l’esistenza di un apposito “ministero del condizionamento”, addetto alla manipolazione del linguaggio al fine di imbrigliare o indirizzare il pensiero collettivo, e dove la lingua – dato che le idee non possono essere espresse senza parole – diviene strumento di potere. E, in effetti, ad Oxford esiste la figura del diversity officier, che è un funzionario appositamente addetto a verificare se, durante i vari corsi di lezione, siano usate espressioni che qualcuno possa percepire come offensive (per motivi razziali, religiosi, sociali, o perché sessiste, omofobe ecc.): nel caso, il responsabile viene convocato, ascoltato ed, eventualmente, ammonito, affinché l’episodio non si ripeta, altrimenti scattano le misure disciplinari.
Così, l’attenzione maniacale alle parole – a volte ossessiva e goffa – del “politicamente corretto” spesso comporta un’isteria censoria, che pretende di imporre ovunque – dai comuni rapporti sociali al mondo della comunicazione e dello spettacolo, fino a quello della politica – formule linguistiche e codici di comportamento paranoici[17]: si deve fare attenzione a come si parla in pubblico – dove spesso emerge il massimo dell’ipocrisia (si pensi ai frequenti e imbarazzanti “fuori onda”, dove si dice quello che realmente si pensa) – tra amici, parenti o semplici conoscenti, dove nessuno deve sentirsi escluso o sminuito; una frase o una singola parola fuori posto potrebbero causare vivaci contrasti e crescenti malumori, e chi non si adatta viene emarginato e, talvolta, addirittura, criminalizzato. Sì che, sembra arrivato il momento in cui, prima di aprire bocca, occorre consultare i codici e le sentenze dei giudici per sapere quale termine utilizzare. Secondo la Corte di cassazione (50659/2016), ad esempio, occorre distinguere tra la parola “gay” e altri appellativi – più volgari e, quindi, aventi presumibilmente un «intento denigratorio» – usati per esprimere lo stesso concetto: gli ermellini chiariscono che, al giorno d’oggi, è da escludere che la semplice attribuzione della qualità di omosessuale, che riguarda solo una qualità personale (segnatamente, l’orientamento sessuale dell’individuo) abbia di per sé «un carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo, e ciò tenendo conto della percezione della circostanza da parte della collettività»[18]. Sennonché, l’atteggiamento della Suprema Corte appare non soltanto palesemente discriminatorio (qualche tempo fa, si sarebbe detto “classista”), poiché non tiene conto che l’uso dell’elegante inglesismo “gay” non appartiene a chi vive in un contesto in cui il dialetto è la lingua veicolare, ma appare altresì contraddittorio, quando afferma che l’uso del suddetto termine non deve ritenersi offensivo “neppure se viene pronunciato o scritto con intento denigratorio“ (Cass., 50659/2018).

L’altro grande difetto e l’intima contraddizione del “politicamente corretto” sta nel fatto che esso presuppone il sentimento di vergogna delle categorie protette: proprio il contrario del risultato che si vuole raggiungere (tipico esempio di antilogismo): affermare, infatti, che l’addetto alla nettezza urbana debba qualificarsi “operatore ecologico” – e non più “spazzino” – sottintende che a spazzare le strade ci si dovrebbe vergognare. Lo stesso vale per altri lavori, come quello di bidello, di infermiere, di secondino, di bagnino e così via. Così, ancora, “stabilire” che una persona affetta da cecità debba qualificarsi “non vedente” sottintende che tale persona si dovrebbe vergognare di essere cieca (altrimenti non le sarebbe stato assegnato un diverso appellativo). Ancora, che “negro”[19] fosse un termine offensivo è stato deciso, paternalisticamente, da intellettuali “bianchi”, che hanno ritenuto che fosse preferibile, prima, il termine “nero”, poi quello “di colore” – termine, quest’ultimo, che, oltre ad accentuare l’elemento del colore della pelle, segna ancor di più una deviazione rispetto a una “normalità” bianca – infine il termine “afroamericano”, che, a rigor di logica, comporterebbe la denominazione degli americani “bianchi” in termini di “euroamericani”.
Quelli, appena descritti, sono gli eccessi del politicamente corretto, dovuti, come si è detto, all’ossessione – sempre più pervasiva e diffusa – di non offendere la sensibilità altrui e all’isteria censoria che ne è seguita e che ha causato dannose conseguenze alla cultura collettiva, prima fra tutte, quella di aver provocato – e alimentato[20] – la deriva politico-culturale odierna[21], con i tentativi di strumentalizzazione e speculazione della destra più retriva, becera e reazionaria che fa della battaglia contro il politicamente corretto il mezzo per “sdoganare” tesi razziste, xenofobe, omofobe, misogene e sessiste, e chi più ne ha più ne metta. Il significato stesso dell’espressione “politicamente corretto” sembra aver subito uno slittamento semantico, evocativo di ipocrisia, di conformismo e di elitarismo[22], teso a controllare il discorso e i pensieri delle persone “normali”; mentre essere “politicamente scorretti” è diventato indice di sincerità, di autenticità e di coraggio[23].
La critica al politicamente corretto ha due varianti: quella rozza e oscurantista, che qui non prendiamo neanche in considerazione, e quella progressista che conduce una giusta battaglia in nome della libertà di espressione e di critica, libertà che rappresenta un valore se ciò che si esprime contribuisce alla costruzione di una sfera pubblica e di un’opinione pubblica articolata e non oppressiva: il sentire comune non si costruisce “per decreto”[24], ma grazie a un dibattito culturale, libero e aperto, che richiede tempi lunghi e sul quale occorre lavorare incessantemente. I divieti e le demonizzazioni, infatti, non hanno avuto la forza per dare seguito ai cambiamenti che il linguaggio annunciava e avviava, né la capacità di armonizzarsi – proprio in quanto espressione della retorica dominante nel discorso pubblico delle società occidentali, sostenuta da élites intellettuali, politiche e mediatiche – con gli interessi e la sensibilità delle masse impoverite ed esasperate dalla globalizzazione.
Il politicamente corretto avrebbe dovuto seguire la sua vocazione originaria che non era quella di « risolvere » determinati problemi o di “imporre” il pensiero unico, bensì quella di fissare delle regole preliminari per una civile discussione sui fenomeni di emarginazione e di esclusione che caratterizzano le nostre società, rivolgendosi a un certo gruppo etnico, sociale o culturale nei termini che il gruppo stesso avesse scelto, dimostrando in tal modo un rispetto e una volontà di dialogo che avrebbero aumentato le possibilità di successo nella discussione successiva.
BRUNO TROISI
NOTE:
[1] Com’è noto, “politicamente corretto” – traduzione letterale della locuzione angloamericana politically correct – è un’espressione ambigua e polisensa: essa fu usata, all’inizio (negli anni Settanta), ironicamente, dai movimenti femministi e dalla sinistra radicale statunitense contro il rischio di un piatto conformismo linguistico e culturale; soltanto dopo – negli anni Novanta – cominciò a imporsi come vera e propria ideologia comportamentale, con una precisa modalità cognitiva e programmazione neurolinguistica, entrando prepotentemente nel dibattito mainstream. Essa consiste in un uso più rispettoso del linguaggio pubblico, al fine di non offendere – facendole sentire escluse – persone e categorie di persone, contraddistinte dal fatto di essere minoranze e/o di trovarsi in condizione di subalternità internamente a rapporti di dominio: segnatamente, i neri, le donne, gli omosessuali, quelli che venivano definiti tranquillamente minorati o handicappati, le persone esercenti mestieri considerati “umili” e così via. Può dirsi, dunque, che l’espressione in questione stava a significare “inclusivo”, nel senso che aspirava all’inclusione di persone o categorie sociali in qualche modo discriminate. Il “politicamente corretto” è fiorito nel massimo splendore della filosofia del linguaggio, che ha improntato tutto il Novecento. L’intuizione che ne costituisce il fondamento è che il linguaggio non si limita a descrivere il mondo ma, denotandolo, lo costruisce, lo crea. Questo perché, come per primo dimostrò Austin negli anni ’60 (in Come fare cose con le parole, il filosofo e linguista inglese sviluppò la teoria degli “atti linguistici”), e poi Michel Foucault (che discorreva di “dispositivi di potere e di controllo” nella società), Gilles Deleuze (che parlava di “regimi di verità” generati dal linguaggio) e Jacques Derrida (che rimise in discussione, attraverso il decostruzionismo, la storia della filosofia) negli anni ‘70 e ‘80, il linguaggio è anche un’azione che produce direttamente effetti sul mondo. Non era dunque peregrina l’idea che, incidendo sul linguaggio, si potesse incidere anche sul reale. Ma, se l’intento originario del “politicamente corretto” era quello di riconoscere anche simbolicamente pari dignità alle diverse componenti sociali ed etniche esistenti, si caratterizzava cioè per un sincero afflato multiculturalista, teso a garantire il rispetto delle molteplici diversità esistenti in una società, gli esiti, come vedremo, sono stati assai discutibili.
[2] Anzi, “bravo”, come il nome del nuovo telefono, che non deve far paura ai nonni, cui è rivolta la pubblicità “buonista”.
[3] Ovviamente si tratta non già di un lupo ma di un cane domestico molto rassomigliante a un lupo.
[4] Della visione quasi apocalittica del lupo e delle paure che egli incuteva per secoli agli abitanti di tutt’Europa, permangono numerose tracce in varie lingue europee sotto la forma di modi di dire e proverbi (es., “gridare al lupo”, avere una “fame da lupi” ecc.), di favole nonché di leggende e storie tramandate per generazioni. Basti pensare che lo stesso Vocabolario degli Accademici della Crusca, fin dalla sua prima edizione del 1612 definisce il lupo come “animal salvatico voracissimo”.
[5] Tutti i dizionari (dal Vocabolario degli Accademici della Crusca al Dizionario etimologico della lingua italiana di M. Cortelazzo e P. Zolli, della Zanichelli; dal Vocabolario Treccani, al Grande Dizionario della lingua italiana di S. Battaglia edito dalla UTET; dal Dizionario dei modi di dire della lingua italiana di B.M. Quartu, edito dalla Rizzoli; a Frase fatta capo ha. Dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni di G. Pittano, edito dalla Zanichelli, e così via) sono concordi nell’attribuire alla locuzione In bocca al lupo! una funzione apotropaica, capace cioè di allontanare il male o di tenere lontana un’influenza maligna, per la sua carica di magia. L’origine dell’espressione risale a un’antica formula di augurio rivolta per antifrasi ai cacciatori, alla quale si soleva rispondere, sempre con lo stesso valore apotropaico, « crepi! ». L’augurio, testimonianza della credenza nel valore magico della parola, si sarebbe esteso dal gergo dei cacciatori all’insieme delle situazioni difficili in cui incorre l’uomo.
[6] Estinzione, come affermano gli animalisti e gli etologi, rischiata dal lupo negli anni settanta del secolo scorso.
[7] È la denominazione che viene assegnata ai millennials – americani e britannici, prima, e poi anche europei, superprotetti da genitori-chioccia, sempre pronti a far loro da scudo per evitare l’esposizione alla cruda realtà – incapaci di affrontare tutto ciò che si pone come problematico o che viene percepito come offensivo, solo perché contrasta con il loro modo di pensare, che poi è quello convenzionale e dominante. Sarebbero così fragili che, di fronte a un’idea diversa dalla loro, chiedono che venga eliminata per essere rassicurati. Accade perché non sono assolutamente in grado di opporsi a visioni differenti con argomentazioni ragionevoli. Sono inconsistenti come fiocchi di neve, appunto, e perciò vanno protetti.
[8] E proprio come oggi fanno tutti gli altri animali che una volta erano feroci – si pensi ai leoni, alle tigri, agli orsi, alle iene ecc.- ma che oggi, a dispetto del principio di realtà, sono divenuti mansueti.
[9] Su tale fenomeno, assai significativa è la Storia sociale dell’arte di Arnold Hauser , Einaudi, 2003.
[10] Si pensi, da noi, alla nota polemica tra Vittorini e Togliatti sul rapporto tra intellettuali e politica (Gli anni del Politecnico Lettere 1941-1951, a cura di Carlo Minoia, Torino, Einaudi, 1977).
[11] Ma gli esempi sono numerosissimi: dalla cancellazione dal programma della Deutsche Oper Berlin, nel 2006, dell’Idomeneo di Mozart, dopo l’allarme di grave rischio per l’ordine pubblico a causa del finale in cui viene mostrata la testa decapitata del profeta Maometto, alla rivisitazione della Carmen di Bizet, andata in scena nel 2018 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nella quale la protagonista non muore più (con l’odierna piaga del femminicidio, come si potrebbe applaudire l’uccisione di una donna?), anzi è lei ad ammazzare il suo carnefice, don José; dalla censura americana alle Metamorfosi di Ovidio, dove si parla di uno stupro, alle censure a Nabokov, considerato da taluni “troppo” trasgressivo e ossessionato dal sesso (basti pensare a Lolita); significativa è, poi, la vicenda dell’opera “Lady Macbeth del Distretto di Mcensk” del compositore russo Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, che, rappresentata per la prima volta nel 1934 al Leningrad Maly Operny, fu avversata dal regime comunista, sebbene fosse nata proprio come espressione di critica nei confronti della società borghese, tanto che in Russia non fu più eseguita perché “inadatta al pubblico sovietico”, e tutta la musica di Šostakovič, in generale, fu attaccata violentemente dalla stampa del suo paese. Il compositore, nonostante la sua “Lady Macbeth” fosse rappresentata con successo in Europa, temendo ritorsioni, approntò un’altra versione del lavoro, che, finalmente senza più problemi, debuttò a Mosca nel 1963 nella sua nuova veste e con un altro titolo (“Katerina Izmajlova”). E via esemplificando.
[12] Una sorta di contrappasso per analogia: come la pioggia infuocata distrusse Sodoma, così tormenta i dannati; invero, un fatto così innaturale come il piovere fuoco, invece che acqua, è consono a coloro che andarono contro le leggi di natura.
[13] Come spiega Natalino Sapegno, per Dante era possibile separare giudizio umano e giudizio divino nel campo della sodomia. Egli, infatti, pur collocando all’Inferno, come cristiano, quanti si erano macchiati di tale “peccato”, come uomo, non riteneva tale comportamento tanto grave da annullare la stima che eventualmente nutrisse per tali persone. Si spiega, così, perché proprio al “sodomita” Brunetto Latini, e non ad altri, Dante affidi il compito di rivelare un’importante profezia sul proprio futuro. La sodomia, insomma, è per Dante uno dei “peccati” per i quali la condanna, in quanto giudice in nome della legge cristiana, può coesistere con la pietà dell’uomo consapevole della fragilità umana.
[14] V., in argomento, tra i tanti, Robert Hughes, La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto, Adelphi, Milano, 2003, il quale sostiene che l’ossessione per i diritti civili ci ha fatto sprofondare nell’esaltazione di qualsiasi minoranza, meglio se perseguitata: nella cultura del piagnisteo l’autore disprezza in particolare ilfalso moralismo che, a suo avviso, è diventato il pilastro del pensiero unico; Edoardo Crisafulli, Igiene verbale. Il politicamente corretto e la libertà linguistica, Vallecchi, Firenze, 2004, il quale mette in luce quelle che a suo dire sono le insidie e le ipocrisie del politicamente corretto: il mutare nome alle cose mantenendone però invariata la sostanza, l’adoperare eufemismi e termini socialmente accettabili per designare realtà che non lo sono e autoconvincersi che le cose siano mutate solo perché le chiamiamo diversamente; Jonathan Friedman, Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime, Meltemi, Milano, 2018, che mette a nudo la dinamica e le radici del fenomeno, che a suo parere ha contribuito in maniera significativa alla “mutazione genetica” delle sinistre occidentali; Eugenio Capozzi, Politically correct. Storia di un’ideologia, Marsilio Editore, Venezia, 2018, che fa una ricostruzione storica dell’ideologia del “politicamente corretto”; AA. VV., Contro il politicamente corretto, in MicroMega, 6, 2018.
[15] Il termine « cieco » (ma il discorso vale anche per gli altri termini che seguono) sarebbe inadatto, discriminatorio e offensivo per descrivere le persone affette da cecità: ma, proponendo « non vedente » come alternativa universalmente migliore viene completamente ignorata l’etimologia, e il nuovo termine enfatizza molto di più l’assenza di visione, rigirando maggiormente il coltello nella piaga ogni singola volta che è pronunciato.
[16] Per fare un esempio, anno 100 era volgare significa 100 anni dopo il convenzionale anno zero dell’era cristiana, a sua volta ascrivibile all’anno 753 secondo il computo ab Urbe condĭta e quello del calendario giuliano.
[17] Per essere “considerati” politicamente corretti, occorre evitare il linguaggio cosiddetto sessista, ad esempio attraverso l’impiego di forme non marcate dal punto di vista del genere (diritti della persona al posto di diritti dell’uomo); evitare espressioni che evocano discriminazione nei confronti di minoranze etniche (come negro o giudeo) e di categorie con svantaggio fisico; e, ancora, evitare in generale espressioni tradizionalmente connotate in modo discriminatorio, ad esempio per quanto riguarda i nomi delle professioni considerate “umili” (bidello, spazzino, ecc.); neutralizzare gli ambienti eliminando elementi verbali che rafforzino il predominio di un gruppo o la marginalizzazione di un altro (come, ad esempio, dire “se Dio vuole” o augurare “buon Natale”, in un contesto che comprenda appartenenti a religioni diverse).
[18] Precisa la Corte che occorre distinguere la lesione della reputazione e dell’onore da quella dell’identità personale, che corrisponde al diritto dell’individuo alla rappresentazione della propria personalità agli altri senza alterazioni e travisamenti. Così, ad esempio, se Tizio dice che Caio è un luterano e Caio invece è cattolico, non sussistono gli estremi del reato di diffamazione, perché dare del luterano ad uno che non lo è sarà pure falso (violazione del diritto all’identità personale, appunto), ma non è oggettivamente lesivo dell’onore e del decoro di una persona. Altrimenti chi è luterano per davvero dovrebbe sentirsi offeso. In altre parole appartenere alla confessione protestante non è di per sé una condizione lesiva del buon nome di una persona. Parimenti per l’omosessualità: il termine in questione, infatti, assume un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato, ed è in tal senso entrato nell’uso comune.
[19] Fino alla fine degli anni sessanta, la parola negro non veniva percepita in senso dispregiativo, e costituiva il modo più comune per riferirsi ai popoli di pelle scura, sia in letteratura (spagnolo negro, inglese nigger e francese nègre), sia nel linguaggio comune. Esempi di tale uso li troviamo nel romanzo La Capanna dello zio Tom, che non può certo essere accusato di razzismo per l’uso continuo del termine “negro” – proprio perché l’autrice, la statunitense Harriet Beecher Stowe, utilizzava linguaggi e parametri dell’epoca nella quale scriveva – anzi, molti ritengono che esso possa aver alimentato la causa abolizionista del 1850; l’uso del termine in questione si trova, ancora, nel brano classico Le petite nègre di Dèbussy (1914), nel brano musicale Angeli negri, dal film Angelitos Negros del 1948, eseguito in italiano da Barreto Jr. nel 1959, e ancora ricantato da Fausto Leali nel 1968. Un altro esempio di quegli anni risultò il brano italiano del 1963, I Watussi, cantato da Edoardo Vianello. Anche vocaboli ancora in uso come negritudine, o il titolo della rivista Nigrizia dei padri comboniani derivano dal termine negro, ancora usato senza alcuna connotazione negativa o discriminatoria. Anche alla fine degli anni Sessanta, nel film « Indovina chi viene a cena? » di Stanley Kramer, venne usato il termine nigger con disinvoltura, pur trattando il tema interrazziale in maniera ancora molto netta.
In quegli anni, anche lo stesso Marti Luther King usava correntemente la parola nigger nei suoi comizi pubblici, in difesa dei diritti civili degli afroamericani, sebbene fosse più una provocazione sociale che un uso neutro del termine.
[20] Per reazione al conformismo linguistico, al tentativo cioè di imporre un pensiero unico che limita la libertà d’espressione, oltreché a una forma di ipocrisia istituzionale, che si limita a cambiare la « forma », cioè le parole, senza intervenire sostanzialmente sul problema.
[21] Invero, la società attuale sembra immersa in un’atmosfera di profondo degrado culturale, a partire dalla scorrettezza sintattica, grammaticale, lessicale – oltre che morale – che domina l’uso della lingua italiana su tutti i fronti: dalla stampa alla televisione, per non parlare delle reti sociali, che – per dirla con Umberto Eco – hanno «dato diritto di parola agli imbecilli: prima parlavano solo al bar e subito venivano messi a tacere».
[22] Si tratterebbe, secondo alcuni, della moderna “boria dei dotti” di vichiana memoria, dove talune élites impongono il pensiero unico politicamente corretto, stabilendo ciò che si può o non si può dire.
[23] Paradigmatico è il celeberrimo commento dissacratorio del Secondo tragico Fantozzi alla proiezione del film di Eisenstein, La Corazzata Potemkin, considerato una delle pietre miliari della storia del cinema.
[24] Nonostante ciò, com’è stato sottolineato, l’attenzione maniacale alle parole qualche risultato l’ha ottenuto: è, infatti, diventato un tabù definirsi “razzista”, “omofobo” o “sessista”, sì che il razzismo, l’omofobia o il sessismo si presentano in forma più attenuata rispetto al passato ed hanno minore facilità di diffusione.










































Grazie Signor Troisi, per questa magistrale, e irresistibile, messa a punto del conformismo linguistico.
Difatti, chi penserebbe mai di diffidarsi delle parole?
Pensandoci sù, non sono il mero riflesso della realtà, ma si impadroniscono della mente e dicono come si deve vivere. Giacché da sole non esistono e vengono create con un’intenzione.
Mi piace trovare un eco del Suo pensiero in un libro di Serge Bassenko sull’argomento:
« Il cibo … fa vivere [gli uccelli]. Nessuno cambia la loro vita dando nomi diversi a quello che mangiano. … Colui che ha dato due nomi a una stessa cosa vuol farci credere che viviamo due vite, allorché ne viviamo una sola. … Qualcuno puo` crederlo. Qualcuno puo` perdere la sua vita. »
(« Il faisait chaud », in francese: http://www.lupusae.com/it/i_f_r3.htm)
Un cordiale saluto!