Avevo cominciato con una certa diffidenza La città celeste, l’ultimo lavoro “autobiografico” di Diego Marani dedicato a Trieste (La nave di Teseo 2021): perché se amo molto questa città, in genere non amo le autobiografie. Per giunta, più avanzavo nella lettura, più Trieste pareva scomparire fra le righe, si assottigliava, diventando ai miei occhi sempre più esile, sfocata, sino a risultarmi praticamente invisibile – di fatto nel libro quasi non se ne trova traccia, eccetto alcuni elementi geografici o letterari, per altro non di rado marginali, bislacchi, che sembrano affiorare come per caso: il tutto molto lontano in ogni caso dalla minuziosa descrizione che ne promette la quarta di copertina, e che principalmente mi aveva spinto a procurarmelo.
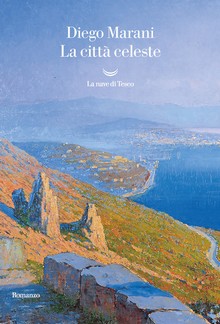 Eppure, con un senso di iniziale sorpresa che si è andato via via trasformando in un rassegnato sentimento di benessere, non potevo interrompere la lettura, e ho continuato pagina dopo pagina, d’un fiato, sino in fondo, perché qualcosa mi stava misteriosamente avvincendo – e dopo averla conclusa mi sono improvvisamente reso conto, guardando indietro, che in quella gracile Trieste autobiografica di Marani mi ci ero sentito spesso a casa, e mi aveva a tratti profondamente commosso. Com’è stato possibile? Le poche riflessioni che seguono non intendono comporre una critica del libro – ce ne sono già state diverse, anche su questo giornale [ndr. QUI la recensione di Fulvio Senardi] – ma appunto indagare questo paradosso.
Eppure, con un senso di iniziale sorpresa che si è andato via via trasformando in un rassegnato sentimento di benessere, non potevo interrompere la lettura, e ho continuato pagina dopo pagina, d’un fiato, sino in fondo, perché qualcosa mi stava misteriosamente avvincendo – e dopo averla conclusa mi sono improvvisamente reso conto, guardando indietro, che in quella gracile Trieste autobiografica di Marani mi ci ero sentito spesso a casa, e mi aveva a tratti profondamente commosso. Com’è stato possibile? Le poche riflessioni che seguono non intendono comporre una critica del libro – ce ne sono già state diverse, anche su questo giornale [ndr. QUI la recensione di Fulvio Senardi] – ma appunto indagare questo paradosso.
A un certo punto di quell’inesauribile capolavoro di Godard (e Truffaut) che è À bout de souffle, Patricia, la deliziosa Jean Seberg, intervista insieme a un gruppo di giornalisti e ammiratori il famoso insopportabile scrittore-filosofo Parvulesco, impersonificato da un perfetto Jean-Pierre Melville – e proprio alla fine della serie di domande e risposte torna a chiedergli (glielo aveva già chiesto qualche attimo prima, senza ricevere attenzione): “Quelle est votre plus grande ambition dans la vie”? E questa volta lui, dopo un attimo di riflessione, sentenzia: “Devenir immortel, et puis… mourir!” (‘Un attimo di riflessione’, in cui prima di parlare si leva gli occhiali da sole che non aveva fino ad allora mai tolto, rivelando per la prima volta i suoi occhi; e dopo aver ascoltato la sua risposta, se li leva anche lei, i loro sguardi riempiono lo schermo, restando sospesi nell’aria, intrecciandosi per sempre alla musica di Martial Solal, che comincia proprio in quel momento – e la scena finisce).
Ecco, come se fossi al cinema, questa sequenza mi è tornata in mente mentre leggevo le ultime parole del libro, in cui è evocata la raggiunta “senilità” dell’autore, e anzi mi è sembrato finalmente di capire, come togliendomi io stesso gli occhiali, che il suo senso mi aveva accompagnato durante l’intera lettura. Insomma, come succede a volte proprio al cinema, ma anche in letteratura, un’ultima immagine fa da déclic, mettendo in una nuova luce un intero film, un intero libro… Ma quale senso? La tensione fra morte e immortalità che resta sospesa per aria, in quella scena del film: per essere immortali bisogna passare attraverso la morte, o più precisamente essere insieme vivi e morti, quel puis sarebbe in realtà un aussi, una contemporaneità. È di questa contemporaneità che vibra, di nascosto, la Trieste di Marani: ogni momento dell’esuberante giovinezza che si afferma e si racconta in ogni pagina del libro, contiene già la sua melanconica fine, e proprio per questo commuove e si dispone a vivere per sempre.
In altri termini – parlo certo a partire dalla mia esperienza di umano e di scrittore, ma lo ricordo, questa non è una critica… – c’è nella Trieste di Marani una versione dell’idea che vive in tutte le non molte pagine di letteratura che ho scritto, e che sento profondamente mia, anche al di là della letteratura: i luoghi, i nostri luoghi, non sono spazio, sono tempo, un tempo. E appunto: quel tempo che è stato… diventa immortale proprio perché in generale il tempo passa, e passeremo noi stessi, ma nulla può far sì che quel momento passato non sia stato, niente e nessuno potrà cancellarlo: quel suo esser passato, finito, lo rende appunto eterno.
 Certo, quest’idea della temporalità dello spazio non è una trovata originale di Marani, né mia, vive nelle opere di ben più autorevoli, se non sacri scrittori: basti pensare al Calvino de Le città invisibili, con alcune frasi-culto (“… in ogni nuova città il viaggiatore ritrova il suo passato, un suo passato… Viaggi per rivivere il tuo passato?… per ritrovare il tuo futuro?”, etc.), o al grande scrittore palestinese Murid el-Barghuthi di Ho visto Ramallah (“… Il tale luogo non è un luogo, è un tempo… I luoghi cui desideriamo fare ritorno sono in realtà spazi di tempo…” ma poi aggiunge, il che è tragicamente appropriato per il suo Oriente, ma anche per Trieste, o i Balcani: “… ma è per i luoghi che si combatte…”), o ancora ovviamente al maestro assoluto del tempo ritrovato, Proust, e poi anche Cechov, per non citare che i primi (e per me ricorrenti, cari) che mi vengono in mente in questa prospettiva.
Certo, quest’idea della temporalità dello spazio non è una trovata originale di Marani, né mia, vive nelle opere di ben più autorevoli, se non sacri scrittori: basti pensare al Calvino de Le città invisibili, con alcune frasi-culto (“… in ogni nuova città il viaggiatore ritrova il suo passato, un suo passato… Viaggi per rivivere il tuo passato?… per ritrovare il tuo futuro?”, etc.), o al grande scrittore palestinese Murid el-Barghuthi di Ho visto Ramallah (“… Il tale luogo non è un luogo, è un tempo… I luoghi cui desideriamo fare ritorno sono in realtà spazi di tempo…” ma poi aggiunge, il che è tragicamente appropriato per il suo Oriente, ma anche per Trieste, o i Balcani: “… ma è per i luoghi che si combatte…”), o ancora ovviamente al maestro assoluto del tempo ritrovato, Proust, e poi anche Cechov, per non citare che i primi (e per me ricorrenti, cari) che mi vengono in mente in questa prospettiva.
Nelle pagine di Marani, però, l’attenzione al tempo resta come dissimulata, impigliata com’è fra le maglie di una narrazione in apparenza a filosofia zero, priva di graffi, che non urtica (come la letteratura dovrebbe anche fare): il tratteggio dei personaggi è non di rado bozzettistico, abbondano i dialoghi concreti del quotidiano, il tono generale è semplice, persino ostentatamente superficiale (in senso letterale), ora piano, ora euforico, confidenziale, intimista…, e con più di un guizzo giovanilistico – associazioni, qua e là: Treno di panna, Porci con le ali… – a volte anche nell’uso dei termini: mamma, papà, scopare, nel senso dell’amore in cui il desiderio di sesso travolge tutto il resto… E tuttavia appunto il tempo, la vera anima del romanzo, sta là in agguato, o meglio sta sempre là, come se scorresse sotto, basta cambiare di livello per incontrarlo, e ti avvolge, ti si impone, creando un sorprendente senso di contrasto, tanto più forte in quanto non è mai esplicitamente spiegato. Tranne nell’ultimo capitolo del libro, dove l’autore quasi sul finire rivela: “Se sono tornato qui è perché ho capito che non era di Vesna né di Jasna che ero innamorato. Ma dei miei vent’anni, che qui sono andati in scena e ancora si replicano, come quegli spettacoli che restano sempre in cartellone, da una generazione all’altra e gli attori che vi recitano invecchiano nella loro parte, solo quella per tutta la vita. È la magia di questa città scontrosa, la mia città celeste, dove un giorno sono stato immortale...” (Ma per me, lo si sarà capito, il culmine, la conclusione della lettura si situano piuttosto nel capitolo precedente, dove questo potente mistero è annunciato ma non spiegato, vive nel dolore della felicità svanita, imprigionato in quell’amore che non c’è più, e la cui mancanza sembra aprirsi sull’infinito – con i versi di Saba: “Io sono il prigioniero in riva al mare, / cui l’acqua entrava nella tonda cella…”)
Così, leggendo, innanzitutto mi è sembrato di riconoscere… Parigi, la Parigi giustamente dei miei vent’anni da studente, delle mie case condivise, dei miei amori, in cui non a caso avevo subito letto L’Éducation sentimentale, il luogo dove sono appunto tornato molti anni dopo (ma per restarci)… E poi, piano piano, definitivamente, è apparsa finalmente Trieste, la mia Trieste, cioè innanzitutto quella della mia memoria, della scrittura: anche se, o proprio perché, la Trieste celeste di Marani è come un’ombra, uno scheletro, quasi invisibile, avara di nomi, di luoghi come di scrittori. Saba, direi, è quello più esplicito. Ma tanti, luoghi come scrittori, affiorano per chi li abbia già incontrati. Così via San Nicolò, dove il narratore s’installa con i suoi amici, rimanda proprio a Saba, ma ancora prima a Joyce… E un po’ più lontano, o un po’ più sotto, come coperto da uno strato di terra sottile, anche Svevo: come non pensare a Zeno e alle sorelle Malfenti, leggendo dell’incontro amoroso del narratore con le sorelle triestino-slovene, appunto Vesna e Jasna? Solo che è come se Zeno si fosse sciolto in tutti i personaggi, come se infiltrasse non solo il narratore, ma anche le stesse sorelle, ognuna a suo modo in bilico, ambigua… Del resto l’ultima parola del romanzo, la già evocata senilità, non costituisce di per sé, per la sua preziosità, una sponda al secondo, omonimo, romanzo sveviano, in cui di nuovo è questione del desiderio d’amore, cioè di vivere, e dell’impossibilità di realizzarlo? Ché finalmente è proprio l’amore uno dei grandi grandi temi-protagonisti del romanzo di Marani, un amore che – nonostante gli spunti apparentemente un po’ goliardici di cui dicevo sopra – è profondamente già nel nascere intriso di nostalgia, sempre sfuggente, come la città cui volentieri si sovrappone (scambio e sovrapposizione fra la donna amata e Trieste, impossibile non pensare a Saba…) e raccontato in una sorta di miscuglio, di confusione di carne e poesia: di nuovo mi sono sentito a casa… Come a casa mi sono sentito nell’elogio vibrante dell’amicizia (altro tema-protagonista), che all’amore si affianca, e che concretamente prende la forma di quelle amicizie di giovinezza, in cui il tempo degli scherzi, delle condivisioni, delle chiacchierate leggere e profonde non conosce limiti, e che comunque vadano a finire restano, anch’esse, per sempre.
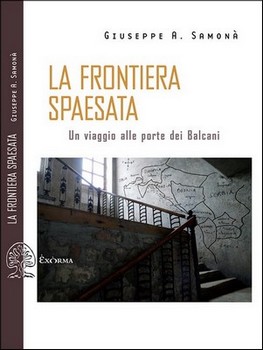 Un’antica storia indiana compara i molti libri che, una volta letti, dimentichiamo, all’acqua del fiume che passa attraverso un setaccio rendendolo limpido: il fiume-lettura che è passato attraverso la nostra mente-setaccio, anche se non può essere trattenuto, l’ha resa più limpida, attenta. Mi è rivenuta appunto in mente, questa storia, leggendo La città celeste: come se i tanti libri, letture, luoghi sciolti dentro le sue pagine e resi per così dire invisibili, in senso letterale – come infossati, interrati, giustamente, pronti per chi li volesse scoprire, riscoprire, inventare – servissero comunque, soprattutto per chi già li conoscesse, a rendere ben visibile, palpabile, l’atmosfera, il senso di una città – proprio come quell’amore cui si sovrappone… – inafferrabile, tutta avvitata sul confine, sulla frontiera, e sui continui passaggi da una parte e dall’altra, sulla coabitazione e gli scambi di lingue e culture, sul loro confrontarsi e anche mescolarsi, e ancora, caratterialmente, su quell’originale misto di accoglienza e diffidenza che sembra – come l’amore… – caratterizzarla quasi ontologicamente: una città, o meglio, una città-tempo, quello della prima giovinezza umana mescolandosi con la storia e la letteratura che sono proprie a Trieste… (Addirittura, a tratti, via via in modo più coinvolgente, mi è sembrato – era inevitabile, ci si intreccia sempre con la propria esperienza – che i personaggi visibili della storia di Marani, cioè Chris, Benni e gli altri amici della via San Nicolò, le amate sorelle Kovač con la loro famiglia, il narratore stesso, etc. fossero quelli invisibili nel libro in cui più ho espresso il mio amore per Trieste, La frontiera spaesata [ndr. QUI la recensione di Sergio Roić]; e i luoghi e nomi visibili nel mio, quelli che nel suo non sono nominati, o sono nominati poco, come sottovoce, per caso – ma via via li ho ritrovati, quei personaggi, quei luoghi, quegli itinerari, li ho come dissotterati sussultando: da i “matti di Basaglia” – e anzi, la risonanza con la mia Trieste mi ha qui ingannato, deluso, ché mi sarei aspettato più spazio per quella che mi sembra una delle anime di questa città – alla chiesa greca, dai tramonti nel mare, la sera – quel che a mio modo di vedere rende l’orientale Trieste “superiore” alla più occidentale Venezia – alle ‘sconfinate’ in Jugo, o alle passeggiate sul Carso, alle soste nei Caffè, ai molti scrittori, e scrittrici, incontrati in cammino… )
Un’antica storia indiana compara i molti libri che, una volta letti, dimentichiamo, all’acqua del fiume che passa attraverso un setaccio rendendolo limpido: il fiume-lettura che è passato attraverso la nostra mente-setaccio, anche se non può essere trattenuto, l’ha resa più limpida, attenta. Mi è rivenuta appunto in mente, questa storia, leggendo La città celeste: come se i tanti libri, letture, luoghi sciolti dentro le sue pagine e resi per così dire invisibili, in senso letterale – come infossati, interrati, giustamente, pronti per chi li volesse scoprire, riscoprire, inventare – servissero comunque, soprattutto per chi già li conoscesse, a rendere ben visibile, palpabile, l’atmosfera, il senso di una città – proprio come quell’amore cui si sovrappone… – inafferrabile, tutta avvitata sul confine, sulla frontiera, e sui continui passaggi da una parte e dall’altra, sulla coabitazione e gli scambi di lingue e culture, sul loro confrontarsi e anche mescolarsi, e ancora, caratterialmente, su quell’originale misto di accoglienza e diffidenza che sembra – come l’amore… – caratterizzarla quasi ontologicamente: una città, o meglio, una città-tempo, quello della prima giovinezza umana mescolandosi con la storia e la letteratura che sono proprie a Trieste… (Addirittura, a tratti, via via in modo più coinvolgente, mi è sembrato – era inevitabile, ci si intreccia sempre con la propria esperienza – che i personaggi visibili della storia di Marani, cioè Chris, Benni e gli altri amici della via San Nicolò, le amate sorelle Kovač con la loro famiglia, il narratore stesso, etc. fossero quelli invisibili nel libro in cui più ho espresso il mio amore per Trieste, La frontiera spaesata [ndr. QUI la recensione di Sergio Roić]; e i luoghi e nomi visibili nel mio, quelli che nel suo non sono nominati, o sono nominati poco, come sottovoce, per caso – ma via via li ho ritrovati, quei personaggi, quei luoghi, quegli itinerari, li ho come dissotterati sussultando: da i “matti di Basaglia” – e anzi, la risonanza con la mia Trieste mi ha qui ingannato, deluso, ché mi sarei aspettato più spazio per quella che mi sembra una delle anime di questa città – alla chiesa greca, dai tramonti nel mare, la sera – quel che a mio modo di vedere rende l’orientale Trieste “superiore” alla più occidentale Venezia – alle ‘sconfinate’ in Jugo, o alle passeggiate sul Carso, alle soste nei Caffè, ai molti scrittori, e scrittrici, incontrati in cammino… )
Insomma, ho finito con l’avere l’impressione che l’impalcatura della narrazione, il suo autobiografismo, i suoi simpatici personaggi-bozzetto, etc., rivelassero, proprio perché lontanissimi dalla minuziosa descrizione, il cuore pulsante di una Trieste (il terzo tema-protagonista) a cavallo di molte lingue e paesi, spaesata, aperta su un’Europa sconosciuta – i misteriosi paesi oltre-cortina – e insieme modello, per via di quella coabitazione mescolanza, dell’Europa che vorremmo costruire, ma anche melanconica, sempre in ritardo o in anticipo, perennemente sfasata, in cui mi riconoscevo completamente; e, al di là di quella, una profonda meditazione sull’amore, sull’amicizia, sulla vita.
Dulcis in fundo l’autobiografismo, appunto, per cui dichiaravo provare una certa avversione. Ecco, l’elemento che mi risulta come il più misteriosamente importante è proprio questo, insieme al senso del tempo di cui ho detto prima (i due elementi sono del resto intrecciati): l’autobiografismo di questo libro è nel contempo totale e inesistente. Ciò è reso possibile da una particolare articolazione dell’ineffabile meccanismo di cui Proust è stato in certo senso inventore e maestro: la quasi coincidenza fra l’autore dell’opera e l’io narrante – è in questo quasi, in questo décalage presente sin dalla prima parola ma talmente leggero dal finire col passare inosservato, che attinge la sua originale potenza creativa La recherche… Ora La città celeste si offre al lettore come se quel décalage non esistesse: l’io che narra della sua vita di studente alla Scuola superiore per interpreti e traduttori a Trieste e l’autore Diego Marani, di cui la breve bio ci informa essere stato studente proprio a quella stessa Scuola, sono la stessa persona. Solo che rapidamente, senza che ce ne si renda conto, l’io narrante acquista una dimensione favolosa, separandosi radicalmente dall’autore, come se i due ‘io’ diventassero del tutto indipendenti, e questo semplicemente attraverso il ritmo e lo stile della narrazione: con i personaggi che sembrano acquarelli, con l’atmosfera misteriosa di una città che non si lascia chiaramente localizzare e che proprio in questo esemplifica la sua natura sfuggente, il suo esser frontiera, con la poesia melanconica che impregna e mitiga l’esuberanza della giovinezza (la vita, la morte, l’immortalità), con la realtà che come per magia si disegna intessendo fra di loro situazioni squisitamente letterarie (il sotterraneo Svevo, ma anche Saba, con la continua sovrapposizione fra città e donna amata, e a scavare ci sono anche altri spunti: sotto lo scorrere piano della narrazione c’è una grande sapienza…). Il problema allora non è che quell’autobiografia potrebbe essere completamente inventata, ma che anche se fosse completamente vera, sarebbe comunque finta, fantastica – perché attraverso la letteratura è comunque nato un altro mondo, completamente nuovo, in cui ognuno potrà ritrovare il suo: com’è successo a me che (poco amando le autobiografie!) sono stato colto di sorpresa, ritrovandomi spiazzato e, finalmente, irretito.
(… Ma Diego Marani ha veramente detto queste cose? O non voleva comunque dirne anche altre che forse mi sono sfuggite? Ecco, mai come questa volta ho avuto conferma di come il leggere sia un atto creativo: il lettore fa camminare un libro, lo completa, se vogliamo, persino al di qua o al di là delle esplicite intenzioni del suo autore, lo fa risuonare, lo intreccia con il proprio itinerario – in un certo senso lo traduce in un’altra lingua, arricchendone la personalità, infondendogli nuova vita… Del resto, in generale, una delle caratteristiche fondamentali della letteratura, quella che più le permette di viaggiare nel tempo, non è proprio questa sua capacità di moltiplicarsi e prolungarsi attraverso la voce altrui?)
Giuseppe A. Samonà
P. S. Già! – mi chiede un’amica – come mai celeste? Forse, come suggerisce Senardi nell’articolo prima menzionato, perché era il colore che piaceva a Saba (ed io aggiungerei, come gli piaceva la città scontrosa, che Marani gli mette accanto: “…questa città scontrosa, la mia città celeste…”); o forse perché celeste evoca la bora al cui contatto si prova quel piacere quasi fisico di cui parla Stuparich, ma anche Slataper, la bora che rischiara il cielo sopra la città, ripulisce il mare, riempe le narici d’un piacevole odore di sassi e di pini, la bora insomma che è come l’apertura d’un mondo rinnovato; e forse anche, al primo grado, perché celeste è la città divina opposta alla città terrestre – Sant’Agostino –, una città, si potrebbe dire a questo punto, fatta non più di spazio ma di tempo. Infinita.




































