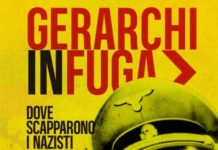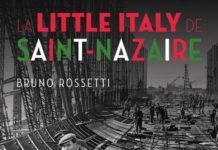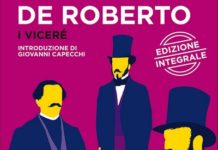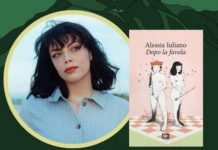Per il mese di giungo 2025 proponiamo, per la nostra rubrica Missione Poesia, il libro La padrona delle oche di Maria Antonietta Viero (Arsenio Edizioni), un’opera che sposta lo sguardo in direzione dell’interiorità, con un’intensità notevole da sostenere, laddove tutto si interseca con il sentire dei giorni quotidiani, attraversato dalle frequentazioni filosofiche e dalla frequentazione del Movimento cifrematico di cui fa parte.
***
Maria Antonietta Viero, nata a Breganze (Vicenza), vive e lavora a Padova. Laureata in filosofia, è stata campionessa d’Italia di pallacanestro e mannequin d’importanti stilisti italiani, attualmente è imprenditrice, in quanto svolge la sua attività nel settore della moda con un suo show room a Padova, e brainworker. Come scrittrice ha pubblicato i romanzi: Viaggio di una foglia (Di Felice Edizioni, 2021), La ballata del Moro di Canossa (Spirali, 2024), La Dogaressa (Arsenio Editore, 2025), la raccolta di poesie La padrona delle oche (Arsenio Edizioni, 2023), uscita anche in lingua francese e rumena per Eikon Edizioni nel 2024, e il libro Rugaciune si alte versuri, (Preghiera e altri versi), tradotte da Alexandru Macadan, (Cosmopoli). Sue poesie sono contenute anche nell’antologia di poeti italiani, Una furtiva lacrima. Poeti al tempo del dolore, uscita recentemente in libreria e nell’antologia Poeti per Dante, che uscirà a breve da Di Felice Edizioni.

Conosco Maria Antonietta Viero da qualche tempo. Ci siamo incontrate alla premiazione del Premio di Poesia Camaiore nel 2023, quando il suo libro La padrona delle oche ricevette una segnalazione di merito. Ci siamo poi riviste al Salone del Libro di Bucarest lo scorso anno, quando abbiamo presentato i nostri rispettivi testi pubblicati dalla Casa Editrice Eikon. Mi è parsa da subito una persona solare, molto empatica e, cosa non da poco, soddisfatta del suo percorso di vita e di scrittura che ha continuato senza sosta, tra prosa e poesia. Lieta di averla con noi a Bologna, nel mese di giungo, alla rassegna Un thè con la poesia.
La padrona delle oche
Silenziosa la via,/lontano una motosega è al lavoro […] con questi versi inizia una delle poesie più significative del libro La padrona delle oche di Maria Antonietta Viero, un libro che sposta lo sguardo in direzione dell’interiorità, e lo fa con un’intensità non facile da sostenere, intersecata nella ferialità dei giorni, nei momenti del quotidiano laddove nelle vie silenziose si confondono i rumori di chi è intento al lavoro. Nei suoi scritti si percepisce la roccaforte filosofica e la frequentazione del Movimento cifrematico[1] di cui fa parte insieme al marito, il dott Ruggero Chinaglia. Ma non parleremo di questo perché non siamo nel contesto giusto, né siamo così competenti in materia. Qui, come sempre, affronteremo la poetica dell’autrice e lo stile messo in campo per realizzarla. Cercheremo dunque di prescindere – per quanto possibile – dalla formazione della disciplina scientifica a cui abbiamo accennato, per addentrarci in quella più letteraria che ci compete. A cominciare dal titolo del libro: La padrona delle oche. Da sempre, pensando a questi animali il rimando è immediato alle oche del Campidoglio che vennero in soccorso ai romani, cominciando a starnazzare, all’arrivo dei barbari nei pressi della cima del colle capitolino, impedendo così che venisse conquistato. Le oche, dunque, per quanto si pensi a loro come ad animali sciocchi e ridanciani in realtà vennero considerate, dai romani stessi, animali sacri, proprio per questa loro impresa. Pensandole invece in termini poetici, non si può fare a meno di citare una poesia molto nota di Gabriella Sica, ripresa dal libro Le lacrime delle cose, dove le oche di Villa Borghese vengono così definite, in un’intervista, dall’autrice stessa: “Le oche sono bambine ancora candide, sono angeli inattesi, sono esseri dolenti e un po’ creduloni, come siamo tutti noi davanti alla vita, destinati al sacrificio. Sono un po’ le sorelle dell’agnello sacrificale, figlie innocenti di Dio. E sono anche uno squarcio di candore struggente e di luce.”
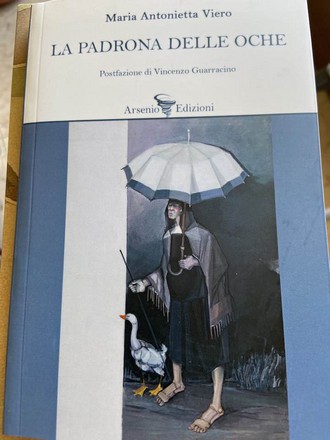 Tanto premesso, in che modo possiamo pensare di declinare dunque il significato della figura de la padrona delle oche? Cosa simboleggia una tale identità? Se le oche bambine di Gabriella Sica, sacre ai romani, ma comunque sfuggenti e inarrestabili possono essere identificate negli accadimenti della vita, non di meno la loro padrona è colei che cerca di governare i sentimenti conseguenti agli accadimenti, che sussulta alle emozioni della vita, che prova a gestire l’imprevedibile che arriva, e che sprona al sorriso, alla leggerezza anche nella consapevolezza del trascorrere del tempo. Non mancano le paure di non saper gestire le oche, da ora in poi diremo i sentimenti o le emozioni, non mancano i ricordi che diventano memorie, non mancano le riflessioni intorno alla parola, la voglia necessaria di nominare tutte le cose, di dare un senso agli insegnamenti di padri e maestri, e di provare a darne a sua volta all’insegna delle esperienze che mette a disposizione del lettore, quasi fossero una speranza di salvezza portata da quel Viandante – forse un Gesù pellegrino – che offre un’eucarestia di pane condiviso, un pane della vita.
Tanto premesso, in che modo possiamo pensare di declinare dunque il significato della figura de la padrona delle oche? Cosa simboleggia una tale identità? Se le oche bambine di Gabriella Sica, sacre ai romani, ma comunque sfuggenti e inarrestabili possono essere identificate negli accadimenti della vita, non di meno la loro padrona è colei che cerca di governare i sentimenti conseguenti agli accadimenti, che sussulta alle emozioni della vita, che prova a gestire l’imprevedibile che arriva, e che sprona al sorriso, alla leggerezza anche nella consapevolezza del trascorrere del tempo. Non mancano le paure di non saper gestire le oche, da ora in poi diremo i sentimenti o le emozioni, non mancano i ricordi che diventano memorie, non mancano le riflessioni intorno alla parola, la voglia necessaria di nominare tutte le cose, di dare un senso agli insegnamenti di padri e maestri, e di provare a darne a sua volta all’insegna delle esperienze che mette a disposizione del lettore, quasi fossero una speranza di salvezza portata da quel Viandante – forse un Gesù pellegrino – che offre un’eucarestia di pane condiviso, un pane della vita.
Volendo segnare la presenza del divino, o del sacro che dir si voglia, non possiamo non notare, nella pienezza delle similitudini di rimembranze stilistiche della Commedia dantesca (e come… così, ripetute in vari testi e/o anche più volte nello stesso testo), di cui le poesie sono oltremodo ricolme, non possiamo non notare, dicevamo, una di esse, questa volta di natura semantica, laddove assume particolare rilievo la vicinanza al contesto in cui appare quell’uomo di fumo, quel Perelà, di palazzeschiana memoria. Stiamo parlando della poesia dal titolo CASA, nella quale si descrive una struttura priva di porte e finestre, ma con un camino che risucchia il vento che scuote la casa, proprio come accade all’apparizione di Perelà che, a detta di molti critici, impersona il figlio di Dio sceso in terra, molto acclamato all’inizio, richiesto, interrogato su tutto lo scibile umano, mentre tutti si interrogano su lui, condannato a morire in un secondo momento, salito poi al cielo dallo stesso camino da cui era apparso, e che in Viero si traduce in questi versi: È forse un torto al pensiero del dio/nascosto ma giusto,/in rivolta al senso del suo giudizio,/perché il fatto sveli l’essere,/verità senza parola ?/Che vai cercando mai, vento ?/Indizi ?/Prove/Di quale passaggio ?/E perché mai il fatto eretto a muro ?/Il fatto… C’è chi l’ha visto,/chi l’ha sentito dire,/chi l’ha vestito,/per l’altare di fuoco,/chi dice di sapere che è proprio così […] (in specie queste domande ricordano davvero molto le domande che le persone si pongono sull’uomo di fumo).
Non sappiamo se l’autrice avesse in mente l’opera che citiamo, ma la poesia gioca sulle nostre reminiscenze culturali, sulle immagini che compaiono alla lettura, sui maestri che la tradizione ha messo sul nostro cammino e, facendo voli assai strani, consente collegamenti forse impensabili.
A proposito di voli, non possiamo non evidenziare quante volte nell’insieme dell’opera vengono citati uccelli di varie specie, ali, becchi, voli e tutto ciò che attiene alla dimensione aerea del sentire, del vedere, dell’udire, segno certo di una volontà di libertà che sempre si esprime in questa rappresentazione Anche la forma uditiva dell’eco è citata ripetutamente, come a suggellare una necessità di risentire le cose dette, di fare in modo che vengano ridette, ripetute, riascoltare con evidente desiderio di non dimenticarsene, di non perderne memoria.
Una nota a parte merita il breve poemetto in prosa poetica dal titolo VUOTOPIENO, dedicato alla vita di Daniela Moro e che riassume una stagione di lutti, dolore, sofferenze affrontate nella doppia dimensione del vuoto e del pieno, senza compiere nessuna scelta di merito ma, al contrario, facendole assurgere entrambe a valore di testimonianza che, nella storia drammatica e traumatica della protagonista, diventa strumento necessario per continuare a vivere.
Infine, una nota sullo stile linguistico dell’autrice. Abbiamo già accennato all’uso dello strumento retorico della similitudine, al quale si aggiungono le anafore d’inizio verso, specie nel segno dell’interrogativo (e se, quando), le metafore e le immagini ricorrenti, e una lingua che spesso diventa onomatopeica quasi a sottolineare l’esigenza del suono, del significante oltre che del significato. Questi alcuni esempi: il vento rumóra, strisci e stridi lo specchio, impedire l’udire di quell’orlo di lingua, mulina il vento, mulina mulinella l’acqua del fiume, e come suono rantoloso rabbuiato, come sul grafo di penna… Concludendo, in questa prova letteraria, riteniamo che Maria Antonietta Viero possa aver voluto cimentarsi e confrontarsi con una nuova lingua che, lontana dalle sue esperienze precedenti, le ha comunque dato la possibilità di raccontare, attraverso una visione peculiare, le sue esperienze di vita, trasformandole in esperienze di poesia e che, al contempo, la prova sia perfettamente riuscita.
Alcuni testi da: La padrona delle oche
(incipit)
Maestro, disegnami una foglia.
Fammi seguire il tratto del debutto
sino all’inseguire quell’altro
tratto interno alla foglia
che quasi la divide
e rifà il canto del calco
e poi, su quel tratto,
ritrovare i rami e riprendere
il disegno che dice dell’albero
di cui il ramo vive.
*
E TUBA
E come tortorella a giugno,
già piumata, tenta il suo primo volo,
lasciando il nido sicuro sul ramo più alto del pino
marittimo, vigili il padre e la madre,
schiatta con tonfo al suolo,
e la madre in picchiata si fa cuscinetto
prima che il cemento la trattenga nell’ultimo saluto
ma non arriva in tempo.
E tuba, tuba
e rumorosa vola sul ramo più basso,
più vicina possibile
a dove è caduta la sua piccola e sta lì immobile,
fisso lo sguardo sulle piume
che il vento appena solleva e attende, che attende?
Vano tentativo di riportarla su, su al riparo,
ancora in quell’uovo
che dischiuse la vita…
La tortorella apre il becco, ma la voce non giunge,
chiama senza ascolto, ansima,
apre appena le ali,
il cuore pulsa sulla schiena che ancora respira…
*
L’UMUS
E se il fiore mostrasse la pagina
della foglia che in bozzolo teneva…
Una pagina geroglifica a indicare la mappa sua propria,
il disegno della vita che,
come corolla rivolta al sole, all’aria,
si lascia sorprendere dal segno,
in polvere di granello di sabbia,
sottilissimi quasi invisibili solchi
di calchi lontanissimi
reinventati in viaggio d’incontri,
il tempo del rilievo come battito d’ala o di ciglia,
aquilone trattenuto, un filo in mano per battere un tempo,
una corsa per impostare il ritmo,
e poi lasciarsi condurre, scivolare sull’onda
in corrente di vento che, da qualche parte, ci lascerà.
Su che pagina potrebbe la foglia dirci
dell’anticipo o del ritardo
se c’è un credo nel già avvenuto o saputo,
il segno come predestino
e a nulla valga lo sforzo di un rivolo
che occorre tastare per dire che, sì,
qualcosa è sfuggito e sfugge?
L’imprevisto ci coglie e libera il riso,
l’aria si terge, è terso il cielo,
la pagina ritorna come Altro in foglia,
e nell’humus il passo va
sul filo del tempo suo proprio…
*
VEGLIA
E veglia sulla brace che pur non scoppietta
e cenera calma la forma.
Fascìna si alza e poggia la cima più in cima la testa,
in idea di capanno, casa sotto la brace,
un requiem senza riposo.
E veglia la forma distesa, in mano rosario
che sgrana i santi e i miracoli, induplicate chiavi.
E toppa s’innalza e smisurata luce
impedisce la sua piana colore;
la veglia impedisce che spanda e disperda i contorni,
impedisce lo sfrastaglio illusorio nella sua ansa, sua casa.
E, illusoria la lingua, speranza di fuoco la brace.
E veglia, ché sonno, come chiave, non apra la porta
e disperda l’abitante che invece la veglia trattiene
a impedire l’inganno di sfrangio ché firma in calca
non mostri,
– abbandono – per veglia di capezzale vacante.
E sfugge il filo della mano che attenta la corsa al vento,
accanto, nel posto vacante.
E onda il filo dell’aquilone
in corrente nel suo vento a sfuggire quell’abbrevio di filo
ché rombo non plani rovinoso a terra…
E veglia l’aria a innalzare di un poco i piedi
ché, tremula terra, l’angolo di roccia spuntato,
– in spunto d’angolo roccioso di roccia –
come cappio d’aquilone più nel cielo (non) vola…
Bologna, maggio 2025
Cinzia Demi
[1] La cifrematica è l’esperienza dove si tratta della qualificazione, del processo di qualificazione e del modo con cui ciascuna cosa qualificandosi approda alla cifra, approda al valore estremo.
 P.S.: “MISSIONE POESIA” è una rubrica culturale di poesia italiana contemporanea, curata da Cinzia Demi, per il nostro sito Altritaliani di Parigi. Altri contributi e autori qui: https://altritaliani.net/category/libri-e-letteratura/missione-poesia/
P.S.: “MISSIONE POESIA” è una rubrica culturale di poesia italiana contemporanea, curata da Cinzia Demi, per il nostro sito Altritaliani di Parigi. Altri contributi e autori qui: https://altritaliani.net/category/libri-e-letteratura/missione-poesia/