Lingua italiana. Anni fa, in questo luogo del cielo chiamato Italia, cominciò a diffondersi un uso sbagliato dell’espressione « piuttosto che ». Per etimologia (più e tosto, cioè “più presto”) e uso storico, questa espressione ha significato avversativo: preferisco andare al mare piuttosto che in montagna. Esprime cioè una preferenza, una scelta.
A partire dagli anni Novanta, o forse già dagli Ottanta, ha invece preso piede un uso scorretto, disgiuntivo, per indicare una cosa « oppure » un’altra. Capita di sentire: « al mare piuttosto che in montagna », da qualcuno che intende dire “al mare oppure in montagna”.
È interessante notare come questo uso scorretto, e secondo me anche inelegante, si sia diffuso a partire da ceti sociali considerati medio-alti, per scolarità e possibilità economiche; in particolare nel mondo delle professioni tecnocratiche e nella zona economicamente più forte del paese: Milano e dintorni, il Nord. È stato un segno (tra altri) di una trasformazione antropologica (inconsapevole, ma evidente) portata dalle nuove classi dominanti. Gli usi “scorretti”, a-grammaticali della lingua erano stati fino ad allora di matrice popolare, o dialettale. In quel senso avevano rappresentato una sorta di alternativa eversiva, e conservato un sapore e un colore diversi, rispetto alla lingua « colta », la lingua della borghesia e degli studi.

Per usare letterariamente una lingua popolare (come Pasolini, su un registro diverso Gadda e più tardi Meneghello) occorreva di solito essere legittimati da un’estrazione sociale e culturale borghese (e infatti Jean Genet diceva che, da detenuto qual era, per farsi intendere aveva dovuto usare la lingua dei suoi “torturatori”, i borghesi: “pour l’argot il fallait un docteur, médecin des pauvres, Bardamu (protagonista del “Voyage au bout de la nuit” di Céline, ndr), qui ose écrire l’argot. Le détenu que j’étais ne pouvait pas faire ça, il fallait utiliser la langue du tortionnaire”. Come a dire che Céline poteva permettersi l’argot perché aveva scritto in francese la sua tesi di laurea in medicina, mentre Genet, disertore, assassino, carcerato, disgraziato, no).
Il « piuttosto che » disgiuntivo, scorretto dal punto di vista linguistico, era destinato a diventare comune nella parlata di quadri e dirigenti aziendali, di solito con formazioni orientate alla tecnica e all’ingresso nel mondo produttivo (ingegneria, economia e commercio). Divenne rapidamente simbolo di parlata pragmatica, efficientista, tipica di chi cerca di ostentare un certo controllo del linguaggio. Negli intenti di chi lo usava, ho l’impressione che fosse persino considerato un’espressione ricercata. L’Accademia della Crusca ne parla infatti come di “una voga d’origine settentrionale, sbocciata in un linguaggio certo non popolare e probabilmente venato di snobismo”.

Il “piuttosto che” disgiuntivo era insomma segno distintivo di una nuova classe dominante, consolidatasi negli anni Ottanta e Novanta. Una classe sociale scolarizzata (di solito laureata o almeno diplomata) ma incolta. Lontana sia dalla cultura popolare (associata a povere condizioni economiche, e perciò disprezzata, ritenuta cafona, volgare) sia da quella umanistica (altrettanto disprezzata e ritenuta sorpassata, inutile, inefficiente).
Qualche tempo fa fui colpito da un episodio. Una persona che inconsapevolmente fa parte di tale classe mi disse, convinto di suscitare la mia approvazione: « basta, non si può più andare a teatro, ti rendi conto che fanno ancora Goldoni? Non se ne può più! ». In Francia, la Comédie Française custodisce splendidamente Molière (autore capitale, certo, ma non è detto che in concreto Goldoni gli sia inferiore) con rappresentazioni memorabili, e la consapevolezza del proprio dovere di trasmetterlo alle nuove generazioni. In Italia, temo che il pubblico dei teatri stabili e del cosiddette « consumo culturale » sia ormai in buona parte composto da persone come quella che ho citato.
Quella classe ha insomma prevalso. Ha conquistato l’egemonia e domina il mondo di adesso, soprattutto nei paesi (come è purtroppo l’Italia) di identità più fragile, meno dotati di anticorpi e quindi più sottomessi alle mode della « modernità ». Il “piuttosto che” scorretto, usato nelle aziende del Nord per darsi delle arie, è diventato quasi corrente, e lo si sente anche in trasmissioni televisivi o discorsi di politici. In un certo senso, quella locuzione è, tra altri, simbolo della sconfitta dei vecchi mondi (la cultura borghese e quella popolare) di fronte al mondo nuovo: quello della tecnica, del linguaggio aziendale che, attraverso l’impoverimento e la brutalizzazione conformistica della lingua, riduce non tanto la lingua, quando proprio il mondo, a ben povera cosa.
Maurizio Puppo







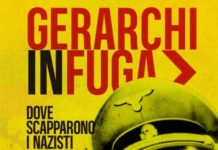








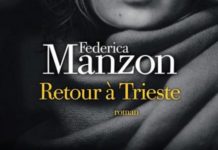





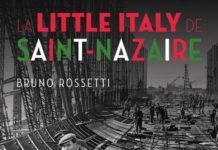



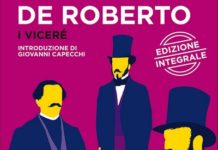












Buonasera Maurizio
Ho letto e riletto questo articolo con attenzione e interesse da amante delle lingue, quale io sono e per le quali nutro un profondo rispetto.
Vuoi per le mie origini tosche, vuoi per una reale passione per la lingua italiana gli obbrobri mi irritano « piuttosto » (nel suo secondo significati di « alquanto »)😉
In ogni caso se sono pronta a stendere un velo pietoso su chi pecca per ignoranza non posso assolvere chi lo fa per presunzione.
Che simili distorsioni siano frutto di una classe dirigente ben scolarizzata e prova della efficienza tecnologica nordica corrobora in me il sentimento di quanto debbano essere carenti gli insegnamenti scolastici e specie quelli del « ramo scientifico » e con quanta superficialità si voglia semplificare, snaturare e ridurre la bellezza e la ricchezza di un idioma.
Mi vengono in mente paralleli con il Bac scientific francese, che forse non esiste più nella forma in vigore una ventina di anni fa quando il Bac era un problema familiare di attualità.
Alle prove del Bac S il coefficiente delle materie scientifiche era talmente alto che bastavano buoni voti in tali discipline per ottenere il 10 di media necessario per essere promossi anche se con voti da vergognarsi nelle materie « letterarie » : lingua francese e straniera, filosofia, storia ecc…il cui apprendimento era più che opzionale( tanto il coefficiente era basso!!!! ) e servivano a ben poco.
Mi chiedo in finale se questa subcultura linguistica sia la vendetta ( e non vedetta) lombarda di chi detestava il Manzoni non tanto per i Promessi Sposi quanto per l’aver risciacquato i panni nelle acque «argentate» dell’Arno e abbia deciso di ridorarli in quelle dei Navigli, dove il congiuntivo, modo oramai sconosciuto è naufragato e affogato.
Amen!( purtroppo)
grazie Rebecca. « Il congiuntivo è affogato ai Navigli »; sarebbe un titolo perfetto per un libro sull’irresistibile degrado della lingua italiana. Un caro saluto, Maurizio