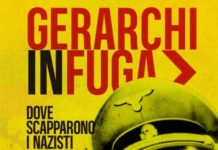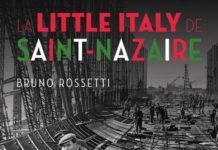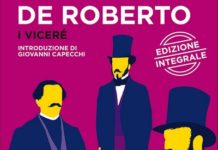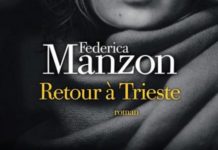Giovanni Pascoli non è solo il poeta delle piccole cose: con Nell’Anno Mille (Zanichelli, Bologna, 1924) ci porta dritti nel cuore di un Medioevo inquieto, sospeso tra la paura della fine e la speranza di un nuovo inizio. Un dramma intenso, carico di tensioni e interrogativi, che oggi, nel 2025, risuona con una forza sorprendente.
Anche noi viviamo un’epoca di passaggi cruciali: crisi climatiche, rivoluzioni tecnologiche, incertezze globali. Come gli uomini del X – XI, ci troviamo davanti a un futuro incerto, combattuti tra il timore dell’ignoto e la voglia di cambiamento. Pascoli, con la sua capacità di dare voce ai sentimenti universali, ci offre uno specchio in cui riconoscere le nostre ansie e speranze.
Leggere (o rileggere) il dramma pascoliano oggi significa riscoprire un’opera visionaria, capace di parlare al nostro tempo. E chissà, forse ci aiuterà anche a guardare con occhi diversi le nostre “soglie del millennio”, quei momenti in cui il mondo – e noi con lui – sta per cambiare volto.
Questa riflessione nasce dall’analisi condotta da Andrea Carnevali, che in questo contributo propone una lettura attuale di Nell’Anno Mille, intrecciando gli elementi storico-letterari con le inquietudini del nostro presente.
**********
Nell’Anno Mille di Giovanni Pascoli non è solo un’opera teatrale, ma una riflessione appassionata e tormentata sulla transizione tra due epoche, sospese tra la fine del mondo e l’inizio di un nuovo ciclo. Il dramma affonda le sue radici nel clima di paura che, alla fine del X secolo, segnò la diffusione della credenza che il mondo fosse destinato a finire. Intrisa di simbolismi, l’opera mescola storia, religione e psicologia, sviluppandosi come un percorso di esplorazione che diventa un’odissea artistica e personale per Pascoli.

Nel 1897, in occasione del centenario della nascita di Donizetti, Pascoli accettò l’invito di Bergamo a partecipare al numero unico commemorativo, inviando un prologo di dramma musicale intitolato Anno Mille. L’embrione dell’opera risale al periodo tra il 1894 e il 1895, quando Pascoli lo abbandonò per poi rimaneggiarlo in vista della pubblicazione. Dopo il successo ottenuto, si aprì per Pascoli la possibilità di intraprendere una carriera teatrale. Seguirono diverse versioni, inizialmente con la collaborazione del compositore Marco Enrico Bossi e poi con quella del figlio Renzo Bossi. Tuttavia, a causa di incomprensioni e divergenze poetiche, il progetto del libretto del dramma e il suo rifacimento Il ritorno del giullare rimasero incompiuti. Solo successivamente, il materiale confluirà nelle Canzoni di Re Enzo. Postuma, l’opera verrà musicata da Renzo Bossi sui versi di Luigi Orsini, mantenendo la visione originaria di Pascoli.
Il viaggio del poeta, che si estende per oltre quindici anni di revisioni e riflessioni, si può paragonare a quello di un pellegrino che attraversa alternati momenti di sconforto e speranza. Nonostante le continue modifiche, l’opera non fu mai rappresentata. Ma lo scrittore non si arrese: perseverò nel perfezionarla fino al 1910, quando l’ultimo atto rimase incompleto. Questo lungo cammino testimonia una passione inestinguibile per la poesia musicale, che, sebbene frustrata, segnò in modo indelebile la sua evoluzione creativa.
Nel saggio introduttivo a Testi teatrali inediti (1979), Antonio De Lorenzi esplora la genesi del dramma, illuminando i tormentati scambi tra Pascoli e Bossi e tracciando la traiettoria evolutiva dell’opera. All’inizio, il dramma si delinea come una visione apocalittica, intrisa di oscurità, in cui le figure archetipiche – l’Astrologo, la Dama, l’Anticristo, la Strega – popolano uno scenario di sofferenza, di penitenza collettiva e di attesa sospesa tra la terra e il cielo.
Nel corso delle revisioni, l’atmosfera si arricchisce di nuovi elementi, come la melodia dolce e struggente della ninna nanna cantata dalla giovane madre, che assume un ruolo sempre più centrale. Questo segna il passaggio da una visione fantastico-descrittiva a una più intimista, dove l’esplorazione psicologica dei personaggi – come Oriòr, Gaietta e il Torriere – diventa il nucleo pulsante dell’opera.
Con il titolo Il ritorno del giullare, l’opera subisce un’ulteriore trasformazione, sostituendo il Torriere con Gaucelm, un giullare che ritorna nel suo paese per ritrovare la fidanzata Oriòr. De Lorenzi, con il suo studio approfondito, suggerisce che questo ritorno rappresenti una sintesi delle diverse fasi del dramma, segnando la riscoperta della poesia dopo il “Mille”. Il passaggio da un’epoca all’altra, purificato dal dolore, apre la porta alla rinascita. Le potenti immagini della morte, della redenzione e della speranza si intrecciano: Oriòr, la giovane che suona una melodia accanto alla pietra sepolcrale, diventa il simbolo di un amore non ricambiato. Ma il suo grido, rimanendo inascoltato, risuona come un invito alla riflessione sul mistero della morte. L’apparizione degli arcangeli e del popolo dei morti evoca una salvezza che trascende la vita terrena.
La citazione «Il drago starà nell’abisso, anni mille… mille, non più!» segna il culmine di una riflessione apocalittica, non solo storica, ma anche psicologica. Il drago, simbolo del male, è destinato a essere sconfitto. Ma questa fine non è solo cosmica: rappresenta anche il confronto dell’uomo con le proprie paure e sofferenze. Con una visione cristiana dell’Apocalisse, Pascoli suggerisce che, pur nelle tenebre del mondo, la speranza sia sempre presente, pronta a rinascere.
L’immagine del bordone del pellegrino, simbolo di determinazione, diventa un veicolo di riscatto spirituale, un cammino che, pur tra sofferenze e incertezze, può condurre alla salvezza. Il pellegrino rappresenta una metafora della continua evoluzione interiore dell’individuo, una lotta che si rinnova in ogni fase dell’esistenza. In questo cammino, la morte non è vista come un epilogo definitivo, ma come una transizione, un passaggio verso una trasformazione spirituale.
Il concetto di riscatto personale si riflette anche nell’immagine dei re che si nascondono nelle tombe, costretti a ritirarsi di fronte alla morte. Pascoli, con questa potente metafora, suggerisce che, nonostante il potere e la vanità umana, la morte è una condizione comune a tutti, senza distinzione di status. Ma anche nel sepolcro, si nasconde una speranza di riscatto, una possibilità di rinascita.
Infine, la riflessione pascoliana sulla morte e sull’amore si intreccia con una visione spirituale che porta a una trasformazione interiore. Il dolore, l’amore e la fede sono gli strumenti di questa evoluzione, che si compie attraverso un processo continuo di crescita e purificazione, fino a giungere a una nuova consapevolezza, dove la sofferenza stessa diventa la via per raggiungere la salvezza.
Andrea Carnevali
IL LIBRO:
Nell’Anno Mille. Sue notizie e schemi di altri drammi
Opere di Giovanni Pascoli
Zanichelli, Bologna, 1924