Leopardi fu estremamente critico nei confronti della lirica di Petrarca. Tuttavia, nel confronto tra i “Canti” del sommo poeta di Recanati e il “Canzoniere” appaiono numerosi esempi di petrarchismo, specie sull’amore, “pensiero dominante”.
In una lettera ad Antonio Fortunato Stella datata 13 Settembre 1826 Leopardi scrive:
«Io le confesso che, specialmente dopo maneggiato il Petrarca con tutta quell’attenzione ch’è stata necessaria per interpretarlo, io non trovo in lui se non pochissime, ma veramente pochissime bellezze poetiche e sono divenuto partecipe dell’opinione del Sismondi, il quale […] confessa che nelle poesie del Petrarca non gli è riuscito di trovar la ragione della loro celebrità».
Già cinque anni prima nello Zibaldone Leopardi tracciava il suo cammino di progressivo distanziamento poetico da Petrarca:
«Avendo letto fra i lirici il solo Petrarca, mi pareva che dovendo scriver cose liriche, la natura non mi potesse portare a scrivere in altro stile ec. che simile a quello del Petrarca. Tali infatti mi riuscirono i primi saggi che feci in quel genere di poesia. I secondi meno simili, perché da qualche tempo non leggeva più il Petrarca. I terzi dissimili affatto, per essermi formato ad altri modelli, o aver contratta, a forza di moltiplicare i modelli, le riflessioni ec., quella specie di maniera o di facoltà, che si chiama originalità» (Zib., 2185).

Se l’iniziale viatico petrarchesco non solo è dichiarato apertamente dall’autore, ma risulta evidente anche da una prima ricognizione dei testi [[In particolare cfr. N. BELLUCCI, Il «gener frale», Marsilio, 2010, p. 74: «Il viatico petrarchesco, caratterizzato dalla cifra della «celeste naturalezza», si accompagna alla lezione degli antichi, primi maestri di questa «celeste naturalezza […] colla quale esprimevano il patetico» (Petrarca è dal Leopardi del Discorso messo tra gli antichi «perché loro uguale»). Nel comporre questi versi pressoché d’esordio, il giovane poeta cerca di essere il più possibile fedele a tale ideale di naturalezza». A riguardo cfr. anche L. BLASSUCCI, Alle origini della poesia leopardiana: «Il primo amore», in L. BLASUCCI, I titoli dei canti, cit.]], non si può altrettanto agevolmente accettare l’ipotesi di un tardivo e totale distacco dal modello, come se si fosse lentamente consumato un vero e proprio ‘rinnegamento del padre’.
Molto si è scritto sul petrarchismo all’interno del cosiddetto ciclo d’Aspasia, in particolare su Alla sua donna [[Cfr. L. BLASUCCI, Petrarchismo e platonismo nella canzone Alla sua donna, in I tempi dei canti, Einaudi, 1996.]], ma un’analisi, seppur indicativa, di alcuni luoghi de Il pensiero dominante può testimoniare quanto il modello petrarchesco – opportunamente rielaborato, reso problematico e, infine, fatto proprio – agisca ancora, e a fondo, anche nei testi più maturi.
In prima analisi si noterà che Il pensiero dominante si apre con una serie di apposizioni e con un vocativo che rimane come isolato:
«Dolcissimo, possente
dominator di mia profonda mente;
Terribile, ma caro
dono del ciel; consorte
ai lugubri giorni,
Pensier che innanzi a me sì spesso torni».
(vv. 1-6).
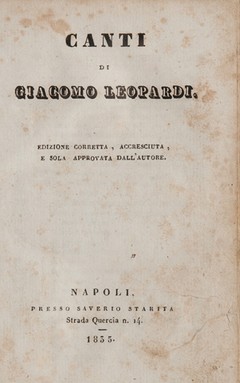
Si tratta, a ben vedere, di una rarità all’interno dei Canti, che potrebbe far pensare al vocativo che apre il Canzoniere di Petrarca[[Significativo può essere anche un raffronto con la serie di vocativi che occupano tutto il sonetto 161 (O passi sparsi, o pensier’ vaghi e pronti) in cui il desiderio amoroso viene definito «possente desire» (cfr. anche RVF, 73, 24: «sì possente è ’l voler che mi trasporta», vicino al leopardiano «possente dominator/ di mia profonda mente», dove, tra l’altro, l’omissione dell’articolo davanti al possessivo ricorda l’uso trecentesco, cfr. L. SERIANNI, La lingua poetica italiana, Carocci, 2009, p. 146).]]. Tuttavia sono soprattutto le apposizioni a ricordare l’andamento ossimorico del verso petrarchesco[[Cfr., senza pretese di esaustività, RVF, 169, v. 4: «dolce et ria»; 173, v. 4: «dolce et d’amar piena»; 181, v.6: «dolce et acerbo»; 182, v. 10: «dolce male»; 205, vv. 1-2: «Dolci ire, dolci sdegni et dolci paci, / dolce mal, dolce affanno et dolce peso»; 363, v. 11: «amara et dolce», ma gli esempi potrebbero essere moltiplicati.]] : l’amore, il pensiero dominante, è «dolcissimo», ma anche «possente dominator», «terribile, ma caro/ dono del ciel», «consorte» sì, ma «ai lugubri giorni».
Del resto l’intero componimento è attraversato da stilemi e richiami a Petrarca: i versi 9-12 («Pur sempre / che in dir gli effetti suoi, / le umane lingue il sentir proprio sprona, / par novo ad ascoltar ciò ch’ei ragiona») ricordano RVF, 71, vv. 7- 13:
«Occhi leggiadri dove amor fa nido,/ a voi rivolgo il mio debile stile,/ pigro da sé, ma ‘l gran piacer lo sprona;/ et chi di voi ragiona/ tien dal soggetto un habito gentile,/ con l’ali amorose/ levando il parte d’ogni pensier vile»; «per prova intesi» del v. 44 è stilema petrarchesco (RVF, 1, v. 7: «per prova intenda»), come pure «mi pare un gioco» al v. 46 (RVF, 133, v. 7: «et parvi gioco»). Particolarmente interessante risultata poi la dimensione assoluta, che porta all’oblio e alla dimenticanza, dei vv. 100- 106:
«Che mondo mai, che nova
immensità, che paradiso è quello
là dove spesso il tuo stupendo incanto
parmi innalzar! dov’io,
sott’altra luce che l’usata errando,
il mio terreno stato
e tutto quanto il ver pongo in obblio!»
Sono versi che sembrano riecheggiare l’ultima strofa della famosa canzone 126, Chiare, fresche et dolci acque:
«Quante volte diss’io
allor pien di spavento:
costei per fermo nacque in paradiso.
Così carco d’oblio
il divin portamento
e ‘l volto e le parole e ‘l dolce riso
m’aveano, et sì diviso
da l’imagine vera,
ch’i’ dicea sospirando:
Qui come venn’io, o quando?
credendo esser in ciel, non là dov’era»
(vv. 53- 63).
Tuttavia fra i due passi, fra i due oblii – e non potrebbe, per ovvi motivi, essere altrimenti – c’è una differenza sostanziale: ne Il pensiero dominante non viene descritto uno smarrimento dei sensi, una dimenticanza di sé suscitata da quella che oggi potremmo definire un’ alienazione amorosa, ma a cadere nell’oblio è la consapevolezza della condizione umana («il mio terreno stato») e, dunque, di «tutto quanto il ver». Non a caso nei versi seguenti, nonostante ricorrano – in un’accezione filosofica ben diversa – termini tipicamente petrarcheschi quali «sogno» e «errore», emergono temi propriamente leopardiani:
[…]Ahi finalmente un sogno
in molta parte onde s’abbella il vero
sei tu, dolce pensiero;
sogno e palese error. Ma di natura,
infra i leggiadri errori,
divina sei: perché sì viva e forte,
che incontro al ver s’adegua,
né si dilegua pria, che in grembo a morte»
(vv. 108- 115).
Argomento de Il pensiero dominante è «l’amore che esalta e trasfigura, sentito e cantato come valore assoluto, esclusivo, totalizzante da parte di chi ha interiorizzato la nullità del vivere e dell’esistere»[[G. TELLINI, Leopardi, Salerno Editrice, 2001, p. 241.]], un «incanto stupendo» che rende più accettabile l’esistenza[[ «Il più solido piacere di questa vita è il piacer vano delle illusioni. Io considero le illusioni come cosa in certo modo reale stante ch’elle sono ingredienti essenziali del sistema della natura umana […] e senza cui la vita nostra sarebbe la più misera e barbara cosa ec.» (Zib., 51).]], ma che, effimero e fuggitivo, è condannato a svanire; inganno vissuto e sentito nella certezza della sua illusorietà, può affermarsi nel breve respiro dei versi di una canzone dove, comunque, il sentimento del vero e del nulla rimane sempre vigile e pronto ad ingombrare la pagina e l’esistenza, fino a prorompere nella disillusione lapidaria di A se stesso.
Tuttavia già in Amore e Morte l’inganno è svelato ed è la Morte, sorella di Amore, ad essere l’immagine della «quiete» (v. 40), del «porto» (v. 42) da opporre al deserto della vita e del «terreno stato». Ancora una volta Leopardi, però, nell’esprimere contenuti originali utilizza, con le opportune differenziazioni, una topica e ricorrente immagine petrarchesca, riscontrabile pressoché in apertura del Canzoniere:
«Morte pò chiuder sola a’ miei penseri
l’amoroso camin che gli conduce
al dolce porto de la lor salute»
(14, vv. 5-7);
come nell’ultimo sonetto prima della conclusiva canzone alla Vergine:
«sí che, s’io vissi in guerra et in tempesta,
mora in pace et in porto […]
(365, vv. 12- 13).
Vincenzo Allegrini








































