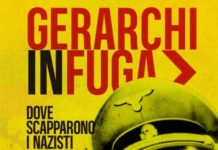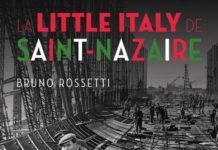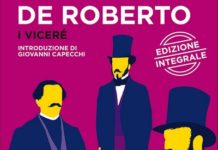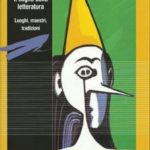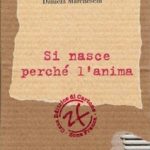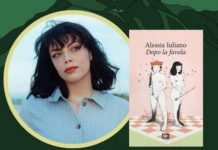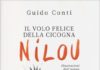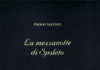Per parlare esaustivamente di Daniela Marcheschi e del suo operato non basterebbero certo gli spazi virtuali della nostra rubrica ma, facendo di necessità virtù, abbiamo deciso di parlare della sua attività di critica tramite l’esame del libro “Il sogno della letteratura” (Giaffi editore, 2012) e di commentare sinteticamente due raccolte di poesie: “La regimazione delle acque” (Il cavaliere azzurro, 2001) e “Si nasce perché l’anima” (ZonaFranca, 2009).

Daniela Marcheschi è critico, docente e studiosa, di letteratura italiana e scandinava dagli orizzonti interdisciplinari e di fama internazionale. Ha pubblicato fra l’altro Prismi e poliedri. Scritti di Critica e Antropologia delle Arti (Sillabe, 2001); Una luce dal Nord. Scritti scandinavi. 1979-2000 (Le Lettere, 2001); Sandro Penna. Corpo, tempo e narratività (Avagliano, 2007); Alloro di Svezia. Carducci, Deledda, Pirandello, Quasimodo, Montale, Fo: le motivazioni del Premio Nobel per la Letteratura (MUP, 2007). Ha curato i « meridiani » Mondadori delle Opere di Carlo Collodi (1995), di cui dirige attualmente l’Edizione Nazionale dopo averne promosso fin dagli anni Ottanta il recupero moderno degli scritti per gli adulti, e delle Opere di Giuseppe Pontiggia (2004), che ha seguito come critico fin dal 1978.
Sue interpretazioni critiche innovative, si leggono inoltre nelle introduzioni al saggio L’Umorismo di Luigi Pirandello, (Mondadori Oscar 2010), a Malombra e Piccolo Mondo Antico di Antonio Fogazzaro (Mondadori Oscar 2009 e 2010) e nella postfazione a Ernst Robert Curtius, L’ abbandono della cultura (Aragno, 2010). Sua anche l’introduzione a Piccolo Mondo moderno, primo volume dell’Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Fogazzaro (Marsilio, 2012). I suoi saggi sono tradotti in diverse lingue.
In poesia ha pubblicato: Sul molo foraneo (Poesie 1979-1990), Introduzione di Giuseppe Pontiggia, Firenze, Esuvia Edizioni, 1991. La regimazione delle acque Poesie 1992, Con il saggio Una classicità senza classicismi di Amedeo Anelli, Parma, Il Cavaliere Azzurro, 2001. Si nasce perché l’anima. Poesie e Poemetti 1995-2003, Lucca ZonaFranca, 2009.
Ha ricevuto i seguenti Premi internazionali: Premio Speciale Carlo Collodi, Firenze, Gabinetto Vieusseux, 1996. Rockefeller Award, The Rockefeller Foundation, 1996. Primo italiano premiato per la Letteratura (Critica) con Geoffrey Hartman e Richard Weisberg. Premio alla Carriera, Regione Toscana nell’ambito del Premio Scrittore Toscano dell’anno, Firenze 2004. TolkningsPris dell’Accademia di Svezia, Stoccolma 2006. Primo italiano premiato per il contributo dato alla diffusione (traduzione ecc.) della Letteratura Svedese.
Collabora con numerose riviste internazionali. Ha, inoltre, al suo attivo svariati incarichi scientifici di livello internazionale.
Conosco Daniela Marcheschi per la gran fama che la precede e la circonda e per aver letto alcuni suoi lavori di critica e poesia. Abbiamo amicizie comuni che me la fanno amare al solo parlarmene e radici toscane che me la rendono empaticamente vicina, anche senza averla mai vista di persona. Ho ascoltato molti dei suoi interventi televisivi e in specie il suo racconto su Collodi realizzato per la RAI l link:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-fa415668-32ab-4979-9f16-5ebff96095d9.html
racconto quanto mai interessante e pregnante di verità storica e letteraria.
IL SOGNO DELLA LETTERATURA

Il libro con cui iniziamo a parlare del lavoro di critica svolto da Daniela Marcheschi è l’importante titolo Il sogno della letteratura – Luoghi, maestri, tradizioni, frutto indiscusso di riflessioni intorno alla capacità della critica di opporsi alle ormai più che conclamate mercificazioni che riguardano tutta l’arte in generale e la cultura letteraria senza alcuno sconto. Già dalle premesse al libro, l’autrice si scaglia – così com’è il suo pensiero, sempre espresso – contro il conformismo intellettuale, condannando la molteplicità di critici che, improvvisando e chiudendosi nell’autoreferenzialità, non producono altro che “chiacchiere” senza valore su libri e relativi autori. Questa tonalità piuttosto piccata e pungente viene conservata dalla Marcheschi in tutto il libro, quasi utilizzando a metafora della situazione descritta, il malanno di cui soffre la critica tutta e poi trasmesso alla letteratura stessa, che è quello di un indebolimento tale da non poter essere curato che con “medicine amare” per ottenere una possibile guarigione, laddove quest’ultime non posso no essere che le verità anche se dolorose, in luogo della menzogna. Tra le questioni su cui riflette l’autrice, contestandone i contenuti, non mancano i riferimenti ai canoni utilizzati per i romanzi tipicamente naturalisti che non hanno contribuito a portare benefici alla prosa nazionale con il permesso proprio di quella critica che, sottraendosi “al proprio dovere di costruire significati e valori, costruire e guardare in alto” ha contribuito alla degenerazione del genere, ormai in larga parte adeguato “alla volgarità di questo mondo consumistico e pronto a mercificare ogni valore”. Anche nei confronti della così detta “letteratura della piacevolezza” la Marcheschi non è affatto tenera, considerandolo territorio più commerciale che letterario stesso. Ad esempio porta quella letteratura, ispirata ai romanzi di U. Eco, che ha al proprio attivo una colpa piuttosto grave, ovvero, dice la Marcheschi: “La colpa grave della “letteratura della piacevolezza” è preferire il diporto dei significati alla nuda consistenza di essi, è renderli a priori secondari, evitando l’onere obbligato di una ricerca concettuale e coerentemente formale”. E se la letteratura sta male, non sta certo meglio la poesia. Sempre secondo l’autrice: le patologie sono gravi: “Proliferazione dei verseggiatori e solipsismo, povertà e uniformità del linguaggio poetico, epigonismo…” con una risposta che va di pari passo alla decadenza delle istituzioni culturali, o ai cedimenti qualitativi editoriali.
Certo, recuperare l’idea della “responsabilità dello scrittore”, etica ed estetica, recuperare il valore della custodia della parola, servirebbe certo a far riflettere anche giovani scrittori propensi solo al successo facile, convalidato dai mezzi di comunicazione di massa, e impossibilitati a proporre una propria visione del mondo o anche a interpretare originali passaggi della tradizione, e potrebbe aiutare ad evitare di ridurre la letteratura a puro divertimento a sfondo di lucro.
Un ultimo e significato passaggio del libro, al quale voglio accennare è quello relativo al contributo che la Marcheschi porta rispetto all’interpretazione dell’opera di Harold Bloom “Il canone occidentale” (una lista contente i nomi degli autori sui quali, che a detta del critico, la società occidentale avrebbe costruito la propria base culturale letteraria) spiegando come tali teorie si possono salvare solo per il fatto che aiutano a censire le categorie di opere in: universali, belle, graziose. Secondo la Marcheschi dunque, Bloom con il suo atteggiamento elitario, derivato da una visione idealistica della letteratura, sarebbe incappato in errori fatali come esagerare l’importanza di Shakespeare a discapito di Dante e Leopardi (quest’ultimo neanche menzionato), e come prendere a riferimento per il canone solo le problematiche delle università americane, credendo di poterle adattare ad ogni contesto.
Insomma, per farla breve, la Marcheschi non risparmia a nessuno la propria determinazione e le proprie convinzioni tra le quali rientra, senz’altro, anche l’idea che attraverso la letteratura si possano costruire prospettive, si possa supportare un cambiamento, si possa cogliere quella che è “l’essenza antropologica della vita, giacché l’uomo è animale culturale” e quello che è il “mandato antropologico delegato alla parola e alle arti” ovvero: “memoria del passato, percezione del presente, progetto del futuro rilanciati con e nella parola portata al massimo grado di espressione e comunicazione”. E noi condividiamo appieno questo pensiero.
LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE
Questa preziosa plaquette, arricchita da un vero saggio critico di Amedeo Anelli, è la rappresentazione più efficace che le teorie possono essere messe in pratica. Dal contesto al testo, infatti, l’autrice ci restituisce una dozzina di poesie esemplari che mettono in scena con limpidezza e chiarezza del verso, rare qualità nelle poetiche contemporanee, concetti etici e morali che non mancano di concedere una forte tensione e tenuta all’insieme costruito. La mia nota andrà nel senso però delle sensazioni dettate all’impronta dalla lettura delle poesie, dalle impressioni nate dal vissuto della loro musicalità, e dalle immagini comparse nel percorso visionario perché – dopo il saggio scritto da Anelli – sarebbe davvero superfluo aggiungere parole tecniche cercando di fare meglio.

Dunque la poesia di Daniela Marcheschi così, d’acchito, mi ha dato l’impressione di ritrovarmi immersa nella favola di Pinocchio, riscritta in poesia e con la stessa musicalità di quel Collodi – che tanto amo e di cui la Marcheschi è una delle massime conoscitrici – che esprimendosi con la musicalità tipica della lingua popolare, tra detti e rimandi, filastrocche e saggezza popolare, addensa ogni elemento terreno di intenso significato raffrontandolo in specie alla natura che col suo ordine tutto regolamenta. Non è un caso che il primo testo sia un Rondò per la Betulla dove la pianta viene identificata con il desiderio di raccoglimento, di concentrazione, di comunione con la propria interiorità che potrebbe essere raggiunto attraverso la mimesi con l’albero e le sue caratteristiche, ovvero con la natura tutta. La concatenazione ritmica su cui è imbastito questo testo dà al contenuto una sonorità che si evolve nell’assoluta scioltezza della simmetria tra l’uomo e la natura, nel cerchio che si apre e chiude con lo stesso verso, che ritorna alla partenza dopo il suo percorso di vita. I toni sono scanzonati – in tutto il percorso del libro – affrontando tematiche di grande rilievo con la disinvoltura data dall’uso sapiente dell’ironia che nel testo dal titolo Scherzo produce un effetto quasi pantagruelico mischiando il cibo ad una morale fiabesca di tipo Perraultiano, mentre nell’ultimo testo dal titolo La lingua lo scherzo si fa amaro – alla bernesca – come dice la stessa autrice, raccogliendo l’eredità di Francesco Berni (autore vissuto tra la fine del 1440 e gli inizi del 1500), giocoso e satirico poeta toscano, che ha fatto del suo modo canzonatorio uno stile di scrittura, e attraverso la metafora della lingua – come elemento da cui nasce la parola, l’assaggio – e la comparazione con l’atteggiamento aggressivo simile a quello dell’uso del becco d’una gallina, questa diventa sinonimo dell’inconsistenza del senno ormai perduto dall’uomo stesso. Ci vuole coraggio, mestiere, forza di parola e conoscenza dell’uso degli strumenti retorici, ci vuole intelligenza e voglia di rischiare a scrivere testi come questi che si distanziano da buona parte della lettura contemporanea, fatte salve le similitudini – che qui non posso che riportare – indicate anche da Anelli nel saggio, ovvero quelle con Giampiero Neri e Guido Oldani, poeti anch’essi dell’emblema che spiega e raccoglie la tradizione per farne altro da sé.
Due testi da: La regimazione delle acque
Rondò per la Betulla Chi stare dento sé volesse Che nel mentre il duo ***** Scherzo La pasta d’uomo mai Di tutte le abbuffate l’abbuffata: Ah, l’utopia del crogiolo SI NASCE PERCHÈ L’ANIMA In quest’altro lavoro, nella particolarissima confezione in cui è raccolto dalla Casa Editrice ZonaFranca – copertina di cartone e carta riciclata, seguendo l’esperienza dei cartoneros in Guanda Vieja a Buenos Aires – l’autrice con poesie e poemetti scritti tra il 1995 e il 2003, conferma una ricercata perfezione di ritmo che appaga i sensi dell’ascolto, un’attenzione all’ironia sottile che ricorda l’istinto Palazzeschiano legato alla leggerezza, e un atteggiamento alla moda di Saba nel porgere una poesia onesta, tendente solo a concentrarsi su quanto di più vero ci possa essere. Esemplare la poesia Versi dell’asino
nella quale l’animale e il suo modo di vivere viene preso a pretesto per raccontare la vita, per esorcizzare i desideri di onnipotenza – anche dei poeti – per fare propri il senso delle tradizioni e di quel “fare” che lo stesso Anelli, nel saggio al precedente libro, indicava come “il fare principalmente poetico” che caratterizza la Marcheschi. Un testo da: Si nasce perché l’anima
Versi dell’asino Dovrei ignorare l’asino? Lo sento ragliare No, non voglio ignorarlo Cinzia Demi
sentendosi compiuto e saldo
somiglierebbe la betulla, purché stesse
a caccia d’un suo
ricompensarsi spavaldo.
s’assomma, ne imiti l’altezza
non rompa la scorza lucente
la ramatura che veleggia.
Nell’involto della sua calda ispidezza
affidi il corpo, poi, al vento negligente
lo governi del fuoco e acqua che spumeggia
quasi aereo così vivesse
chi stare dentro sé volesse.
esistesse
non si farebbero più torte
con pinoli, uvette, e verdure
lesse: cucina povera
che le annovera e le censura
perciò odorosa
con cannella e noce moscata
a far da contrafforte.
e dolce sarebbe il mangiare
la pelle gustosa
e il sesso davvero speziale.
In una terrina si acciambelli
dunque un alimento nuovo:
la femmina farina e il maschio uovo.
della lingua che crea l’immaginare!
Quantunque sovente ai fornelli
gli uomini, però,
non si danno all’indomani
alla parola che è natale –
loro aspirano soltanto
i piedi ad averli lunghi e le mani
in piena pasta:
per il loro borderò
è questo quanto basta.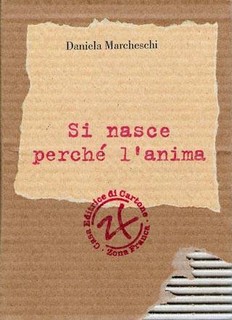
il più incompreso degli animali
spregiarlo?
Eppure ha udito e vista
e il poeta architetta
spiega la sua visione
dove io
è una metafora agonista –
come metafora e paragone
dell’ignoranza
è l’asino
e ogni sua usucapione.
Ingiusta lingua, smentita
dalla vita e va corretta
come un fiume in secca
dai suoi canali.
sulla salita.
Lo vedo arrampicarsi, arrancare
come lo sciancato, il sesso
penzolone, pinnacoli
le orecchie, la coda che spazza
e scarta – altri ostacoli
alla sua disperazione.
Lo stesso capita in montagna
quando non c’è alternativa:
si bestemmia, si deve avanzare,
prende la paura, arriva
la guazza.
L’idillio è un’idea improvvida
della campagna:
e la lingua è anche frutto di umori,
strumento, non dato
ontologico.
quest’animale rubacuori
caro a Luciano, a Omero,
e che nel peso ha stipato
a memento un chiaro destino.
E’ logico
quel suo portamento.
E’ lui
il maestro della mia presunzione.
Prima di Galileo e Newton
della legge di Gravità
scoperta dal pensiero,
fu in lui l’estro: la quiete
poi lo slancio uguale
e contrario verso l’alto –
la capacità campale
di portare il basto,
quell’anti-fasto che urta chi guarda
dal proprio giardino.
Bologna, novembre 2015