Si parla tanto oggi di scuola e le si chiedono prestazioni straordinarie come la lotta contro il bullismo, laddove il suo compito primario nel senso più ampio possibile è quello di insegnare a leggere, scrivere e far di conto.
 Con sorridente nostalgia ripenso all’epoca della mia vita lontana quando insegnavo alle scuole elementari di un paese aspromontano perduto tra le montagne, dove si avventuravano solo docenti di primo pelo per così dire, appena immessi in ruolo e mandati allo sbaraglio come gli inviati speciali in territori di guerra. Io ero tra questi e viaggiavamo con gli altri compagni di ventura su una macchina a nolo che in altre stagioni che non quella invernale serviva per trasportare pesci, bucata sul pavimento e senza sportelli.
Con sorridente nostalgia ripenso all’epoca della mia vita lontana quando insegnavo alle scuole elementari di un paese aspromontano perduto tra le montagne, dove si avventuravano solo docenti di primo pelo per così dire, appena immessi in ruolo e mandati allo sbaraglio come gli inviati speciali in territori di guerra. Io ero tra questi e viaggiavamo con gli altri compagni di ventura su una macchina a nolo che in altre stagioni che non quella invernale serviva per trasportare pesci, bucata sul pavimento e senza sportelli.
Il risultato era che eravamo tutti perennemente raffreddati, ma eroicamente tutti andavamo avanti.
Anche la scuola era sgangherata con infissi traballanti da cui entravano a fiotti spifferi gelidi. La popolazione scolastica era perennemente dimezzata e quella che restava era preda di ben altri drammi che non imparare a leggere e scrivere.
Metà dei padri degli alunni era in galera:
– Che fa tuo padre?
– Ha sparato.
E sembrava molto normale.
In un contesto del genere mi fissai che tutti dovevano imparare a leggere dato che facevo tanta fatica per giungere sul posto.
Ero un’ammiratrice di Maria Boschetti Alberti, insegnante e pedagogista svizzera-italiana che immaginava una scuola fondata sui principi di libertà, ordine, autoeducazione e rispetto dell’individualità dell’allievo, e perciò mi inventai il museo.
Ciascuno degli alunni doveva portare un oggetto di cui alla lavagna scrivevamo il nome. Come per un catalogo.
Ebbe un successo enorme.
Arrivarono con olive, uova, piccole cose incantate di cui diligentemente compitavamo i nomi. Ed impararono a scriverne e leggere le lettere.

Non si sa come la notizia distorta e incomprensibile circolò e suscitò allarme: la maestra folle voleva fare un museo.
Una mattina sbarcò in paese un ometto piccolo e aggrondato: era un ispettore mobilitato per indagare su che cosa stesse succedendo.
Senza preamboli mi abbordò:
– Cos’è questa faccenda?
Gliene diedi prova subito.
Una lenta processione di alunni corse alla lavagna con un piccolo oggetto in mano di cui scriveva il nome che poi leggeva ad alta voce, ma lo strano era che tutti leggevano e scrivevano correntemente come neppure io immaginavo potessero fare.
A conclusione, uno scrisse Museo ed un altro, sorridendo, Ispettore.
L’ometto sconcertato con gli occhi fuori dalla testa dovette pensare di trovarsi di fronte ad un singolare esperimento e se ne andò quasi sconvolto.
Così il museo aveva trionfato.
Trionfa sempre la passione per la scuola dove leggere significa interpretare, scrivere, esprimersi, comunicare, far di conto, misurarsi.
Carmelina Sicari







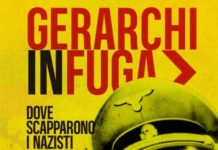














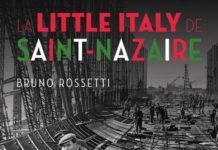



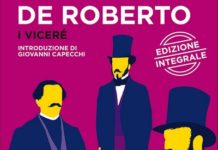












Ce ne fossero volute mille come lei