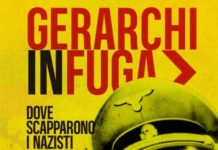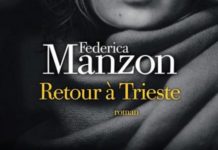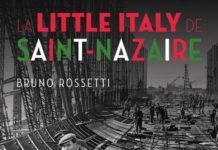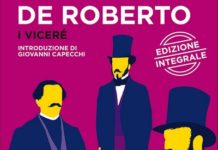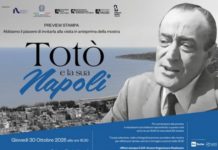La memoria del Risorgimento, 150 anni dall’Unità d’Italia: il cinema ha avuto un rapporto non sempre conciliante con tali eventi storici, ovvero con l’Evento per eccellenza.
Nel 1905, epoca del muto, Filoteo Alberini (classe 1865,
pioniere del cinema) realizza il primo lungometraggio italiano a soggetto, dal titolo “La presa di Roma”, composto da sette episodi. La prima proiezione del lungometraggio sarà eseguita in occasione dell’anniversario di Roma Capitale, in un luogo sacro del Risorgimento: Porta Pia. Era il 20 settembre 1905 e si stima che vi assistettero più di centomila persone. Si tratta di un’opera – sostenne la critica – dai contenuti anticlericali, con influenze persino massoniche. Di quel lungometraggio oggi restano circa 75 metri di pellicola, più di 4 minuti di proiezione, restaurata e conservata dalla Cineteca nazionale.

Michele Cammarano, La carica dei bersaglieri a Porta Pia, 1871, Napoli, Museo Capodimonte
Trascorsi alcuni decenni, si approda nel ventennio fascista, quando ad Alessandro Blasetti (siamo nel 1932) viene commissionato il film “1860”. Serve al regime per “costruire un certo consenso intorno all’idea di
nazione”. Rimane uno dei primissimi film di ispirazione neorealista, dallo stile asciutto e con una regia magistrale.

« 1860« , di Alessandro Blasetti
Trascorsa la guerra e la stagione neorealista, il cinema dei grandi maestri scorgerà ancora nel Risorgimento tematiche vitali per analizzare la nascita e il concetto di nazione. Lo farà Luchino Visconti in due
capolavori: “Senso” (1954, tratto da un racconto di Camillo Boito) con una indimenticabile Alida Valli; e “Il Gattopardo” (1963, dal romanzo di Tomasi di Lampedusa) entrambi sceneggiati con Suso Cecchi D’Amico. Interpreti maestosi Burt Lancaster e Claudia Cardinale.

« Senso » di Luchino Visconti
Negli anni ’70 Paolo e Vittorio Taviani gireranno il cult “Allonsanfan” con Marcello Mastroianni (1974) imperniato sulle vicende di Carlo Pisacane.

« Allonsanfan » dei fratelli Taviani
Nel decennio successivo i due fratelli toscani porteranno sullo schermo “Kaos”, tratto da Pirandello, nel quale spicca la breve novella del passaggio dalla Sicilia di Garibaldi (Carobbardo come lo chiama l’anziana protagonista).
Anche Luigi Magni, romanissimo autore di opere storiche sulla capitale, negli anni ’80 girerà due film gradevolissimi: “Arrivano i bersaglieri” con Ugo Tognazzi e “O’ Re” con Giannini e la Muti, sulla malinconica parabola di Francesco II di Borbone, spodestato da Garibaldi.

“Arrivano i bersaglieri” di Luigi Magni
E’ dunque un rapporto audace e riuscito fra la nascita della
Nazione e il racconto romanzato sul grande schermo, curato da autorevoli
maestri.
Oggi è toccato a Mario Martone, autore napoletano di raffinato senso estetico, anche regista teatrale.

« Noi credevamo » di Mario Martone
Per i 150 anni redige a quattro mani con Giancarlo De Cataldo una monumentale sceneggiatura per il film “Noi credevamo”, oltre tre ore e mezzo portato in concorso a Venezia nel settembre scorso (alla 67. Mostra). A Martone tocca riprendere le fila di un discorso più che mai ineluttabile, in una fase storica minacciata da fanatismi scissionisti e da “scossoni demagogici”. Il regista, suffragato da un cast d’eccezione (Luigi Lo Cascio, Valeria Binasco, Toni Servillo (è Mazzini), Luca
Barbareschi), dipinge un affresco di vaga lezione viscontiana, con tinte esili e poetiche come nei Taviani. Attraversa oltre trent’anni di storia dal 1830 al 1863, mediante l’esperienza di tre giovani patrioti, travolti da un intreccio di passioni, fra il politico ed il sentimentale. Il film si ispira all’omonimo romanzo di Anna Banti, e sugli schermi italiani è appena uscito, ridotto di una mezz’ora.

« Noi credevamo » di Mario Martone
Rimane comunque gradevolissimo, scorrevole e perspicace nell’analisi dell’ impeto giovanile, delle inquietudini, spesso occultate dai personaggi che i libri di storia hanno infarcito ed esaltato, da Cavour a Garibaldi a Mazzini e Crispi.
Il film recupera invece una figura femminile fondamentale: la nobile Cristina di Belgioioso, interpretata nelle diverse età da Francesca Inaudi e da Anna Bonaiuto. Una donna al centro delle trame, una rivalutazione di personalità talvolta ritenute di secondo piano. Come la figura di Eleonora Pimentel Fonseca (trattata nel film di Antonietta De Lillo, “Il resto di niente”, 2004), che fu fra le martiri della rivoluzione partenopea del 1799, laddove si individua il germe del Risorgimento. E così il film di Martone concentra le passioni e la fede dei giovani, contadini ed intellettuali, come un inno alla speranza.

« Noi credevamo » di Mario Martone
Tuttavia si sfiorano appena quei movimenti ritenuti ineludibili come il Brigantaggio e il dramma di Napoli. Al regista, questa “carenza” l’abbiamo rilevata durante la conferenza stampa a Venezia. Ma la sua opera – ci ha risposto – intende recuperare gli eventi dal punto di vista delle passioni, prima ancora che delle realtà cittadine e territoriali. Il racconto parte dal Cilento, attraversa l’Italia, tocca Parigi e Londra, e si chiude in un cerchio ideale proprio al Sud dove, con un colpo di regia, la macchina da presa riprende pilastri di edilizia abusiva sulla costa tirrenica odierna.

.

« Noi credevamo » di Mario Martone
Un film riuscito: Martone ci mette tanto di suo, cerca di smussare angoli talvolta insidiosi, mentre contribuisce nell’insieme a restituire una sagace dignità di nazione.
Armando Lostaglio
— –
« NOI CREDEVAMO » di Mario Martone – trailer