“Tutte le poesie” (Mondadori 2015), a cura di Roberto Deidier, raccoglie la produzione di Dario Bellezza a partire da “Invettive e licenze” (1971, edito da Garzanti), per finire con “Proclama sul fascino” (Mondadori 1996), oltre ad una serie minore di raccolte uscite dopo la morte e di riedizioni dei testi già pubblicati.
“Ecco il miglior poeta della nuova generazione”, scrisse entusiasta Pier Paolo Pasolini (del quale Bellezza fu segretario pro tempore) nel risvolto di copertina al libro esordiale, rimarcando la provenienza da un mondo vecchio, da una “vecchiaia nascente” e la tendenza ad essere “spia della sua vita mal spesa”.
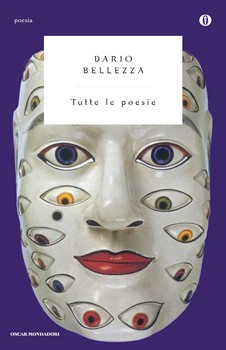
Bellezza nacque a Roma, nel quartiere di Trastevere, nel settembre del 1944, e morì nel marzo del 1996, malato di Aids, all’ospedale Spallanzani della capitale, mentre il mondo culturale e politico si batteva affinché gli venisse riconosciuto il sussidio della legge Bacchelli. Deidier coglie gli aspetti essenziali di una poesia sostanzialmente lirica, composta dal “nervosismo del fraseggio”, con alcune componenti che si ritroveranno in tutti i volumi e che accompagnano la rappresentazione mai scissa dell’uomo e del poeta, essendo Bellezza un autore che dall’io ha costruito la sua pietra angolare. “Da qualunque punto la osserviamo, la poesia di Bellezza appare in fuga, o meglio si costruisce e si atteggia come una fuga”.
L’introduzione di Deidier fissa alcuni punti schematici dove al centro si pone il teatro dell’eros, la notturnità degli ambienti romani, spesso degradati, disperanti, l’orfanità dell’amore, il sentimento del tempo e soprattutto la morte, una vera e propria ossessione non slegata dal tema dell’amore, incompiuto, sviato da una fuggevole sensazione di piacere, da un incontro malinconico, precario. Una sorta di coazione alla solitudine dei sensi avvicina Bellezza alla condizione mortuaria, tanto che si fa luce una conduzione vitale che della morte cerca spesso la provocazione, il dubbio, perfino l’invettiva.
Deidier parla di anamorfosi, di un’immagine distorta che non permette di guardare nella libertà di essere, perché ogni aspirazione viene prontamente soffocata, repressa. Bellezza non giunge mai al compimento di un proposito e formula reprimende sul suo stato, formula di un desiderio assoluto e in parte inespresso, dove proprio amore e morte coincidono come fine di qualcosa che non è mai stato posseduto del tutto.
Antieroe, vittima, come sottolinea il curatore, sull’esempio del maestro Pasolini, o dello stesso Sandro Penna, assediato da un presente ingannevole, da una volontà superiore, misterica, che non esclude il richiamo di un’entità che venga in soccorso, che raccolga l’uomo e dunque il poeta.
Abbiamo l’impressione che Dario Bellezza non sia stato maschera o personaggio: ha saputo scindere la corporalità da una tensione che guardasse oltre, mettendoci la faccia. La mens divinior appare una proiezione di sé e non una finzione scenica. E la morte, come l’amore, si affaccia nella più oscena delle domande: “Quale sesso ha la morte”?, rifacendosi, con una poesia contenuta in Invettive e licenze, alla sessualità degli angeli, forse come brandello di ricordo di un sentimento sfiorito, di una sofferenza patita: “Ma quale sesso ha la morte? / E’ ragazzo. E’ ragazza. Spaventosamente / materna mi abbraccia al limitare del sonno, / quando l’alba affretta la sua agonia / e il giorno calza i suoi occhi di malinconia…”. E sempre annettendo l’amore alla morte: “Calpesto allora il dormiveglia, / i suoi incubi che cinguettano / scemenze. Anche l’Inferno / è l’infinito. Il sesso lo squallore”. La rivelazione del poeta si può riscontrare nel non detto, nel non fatto, nel ricordo di una manchevolezza, nell’occasione che viene meno. Lo scarto si configura come tentazione e resa. Bellezza è un poeta della sconfitta, di chi alza lo sguardo al giorno che nasce “senza rancore o bene”. L’insonnia corrobora un animo smarrito tra le stanze di casa e il buio urbano, nella dicotomia, una tra le altre, desiderio/delusione, o rinascita/svilimento. Tutto cambia impercettibilmente, tra una ferita mortale e una solarità presto ingrigita come il cielo plumbeo di Roma, tra abbracci e carezze sospirate, perdute, ricercate.
Questa poesia è decisamente ritmica, quasi dialogante, e tocca punte di prosaicità. Si conferma un presente ulcerato, un universo inguaribile di affetti domestici e di lutti amorosi, mentre “l’immaginazione uccide la paura”, come il poeta scrive perentoriamente. “Ho paura. Lo ripeto a me stesso / invano. Questa non è poesia né testamento. / Ho paura di morire. Di fronte a questo / che vale cercare le parole per dirlo / meglio. La paura resta lo stesso”. Bellezza allude alla sventura di “negatore terrestre”, ad un’atmosfera funesta che lo circonda, ad una vecchiaia rinserrata nell’urlo della giovinezza, a rimarcare l’emblema patologico della memoria che riaccende il malessere, la depressività, un martirio di solitudine perdurante per la “creatura di sonno e polvere”, che potrebbe essere un giovane, un malato, un emarginato qualunque.
Nel 1982 esce Libro d’amore. Non cambiano i temi, anche se emerge meno acredine e più riflessione disincantata. “Il fradicio ponte e l’eccitato andare / che vacanza erano all’illusione piena / che la pena illudeva di smarrire / il senso elementare della vita / troncata e priva di carità per me”. Bellezza utilizza un lessico solenne, una vocazione che attinge alla mitologia umana e alla “contemplazione” da un punto lontano della giovinezza. Il registro meditativo è placato da asserzioni più leggere e l’introspezione lascia il posto, finalmente, alla dolcezza. La pianificazione fluisce di più dentro le cose e nell’utopia, appena accennata, per un luogo diverso dove il sogno possa ancora avverarsi, dove la gioventù possa servire da sprone nell’incontro con il mondo. La testimonianza del poeta è una fisionomia perfettamente descritta dentro il frantumarsi delle situazioni, nell’evoluzione della vita e dell’amore. Le presenze di Bellezza non sono più spettrali fantasmi in via di dissoluzione, ma persone in carne e ossa, e la poesia trova un’accensione nel vissuto, non nel ripensato e nella constatazione della finitudine umana. L’eros erompe come schietta versione della vita, mentre la sobrietà accantona, momentaneamente, tutto il male dell’anima e del “corpo rantolante”. La desolazione sta in un amore rubato al tempo e alla sua spigolosità, per un senso di momentanea pienezza, se non proprio di speranza, che lasci una traccia.

In Io (1983) ritornano puntuali il malessere e l’irrisolto conflitto con il soggetto più intimo. La quidditas poetica non sa più misurarsi con il senso del tutto se non per sottrazione. Una “lingua pesta” avvolge Roma: un’aria decadente, la coscienza di svuotamento, un estetismo funereo. “Non raggiungerò il Sublime perché sono vivo // Se sono vivo l’idea di morire che dietro / mi porto può sciagurare di continuo / come una Moira offesa e tremenda”. Il poeta torna al dérèglement del sentire sull’influsso dei francesi. La peregrinazione della mente manifesta un isolamento reale che dipende senz’altro dall’indagine sull’uomo più che dall’opinione sulla cultura dominante. La condizione dell’inappartenente e dell’inadatto compie quella serie di vagheggiamenti che fanno il paio con l’atteggiamento che ripiega sulla stagione all’inferno, sull’amore che coinvolge e sconvolge. L’esibizione del male e l’inibizione all’amore riproducono l’idea della fallibilità che mangia l’esistenza, che distrugge l’uomo e il tempo. In Io il personaggio evita di sorprendere, di farsi attore, e l’esperienza relazionale prende il sopravvento.
In Serpenta (1987) emerge la città regale e abbandonata, la Roma svanita, vittima del sogno e dell’agnizione, delle fughe verso il nulla, della vanità e del gran parlare. Questa raccolta emblematizza, più di altre, l’appartenenza alla Roma di ieri e non del futuro: “Ormai non resta che battere / la trafficata città / in cerca di chi non c’è più. / Non c’è più nel tempo solitario / degli addii”. Gli agglomerati urbani sono divorati dall’ansia, dalle primavere che tardano ad arrivare. In un correlativo oggettivo facilmente individuabile, il “tempo alabastrino” è quello di un approdo sconsolato. Il tumulto interiore di Bellezza viene a galla e Roma si lascia andare ad un “funerale di maggio”, ad un’illusione irreparabile. L’amore e i ragazzi, il “terribile eros”, la gioia del sesso nel vento della notte si fronteggiano con lo slancio metafisico in cui Dio viene nominato più volte: “La tua anima bisognosa di Dio / abbiamo umiliato. Ma è Dio che dobbiamo cercare – Dio che è in noi, / insieme, votati alla distruzione / per rinascere santi”; “Sali le scale della morte, / t’avventuri in un mondo sconosciuto, / ce l’hai fatta vai in pace, / a noi resta di aspettare, di Dio / al cospetto anche noi dovremo / presentarci, più peccatori e più vinti”; “Di chi sia, lo sa solo il Creatore / se esiste, se vuole sapere più / di quello che io so”.
Libro di poesia (1990) ripercorre le sequenze molecolari delle raccolte precedenti e le riassume tutte in una dimensione un po’ psicoanalitica e meno lirica, prosciugando la tensione del verso e il ritmo interno: “Credo, morte aspettando, di rifare / il già fatto nel mondo in salvazione: / volteggiando innocuo devo la sorte / ricostruire così come la volle / nel cuore la mia favola perduta”.
Leggiamo di spavento e fuga, il solito e irreversibile scivolare nella perdita a misura d’ombra. Una finta allegria e sommossa dell’anima, un ultimo sussulto, un ultimo abbaglio notturno ribadiscono il senso dell’imperfezione e della malattia che arriverà a devastare il corpo. Al mondo non si è legati che da vincoli mortuari, afferma chi si definisce il “satiro in esilio” che odia il suo aspetto. La notte è infedele peccato di amanti, un tutto tondo penitente di icone apocalittiche, da giorno del giudizio universale. “I pensieri se li svolge lontano / nel suo inesausto regno sotterraneo / con le mie sottili mani d’amoroso / verso la cuna del lento errore”. Nella notte, nel peccato (parole ripetute con una sinistra allusione) il poeta maledetto è ferito testimone di un disfacimento che abolisce ogni primavera. Il senso onnivoro del male si annida nella castità di un bacio, nell’amplificazione di gesti innocui, nel sentirsi “ossidato cittadino” che sogna la pace dei sensi e ritrova la tragicità della vita. L’impegno sublime, in un accorato appello, conserva uno spirito critico, e il filmino esistenziale consegna il desiderio non svanito della giovinezza, un profumo allegro e violento.
Nella raccolta L’avversario (1994) il cuore si fa spento, in “disuso”, in un silenzio per giorni catastrofici: “Nessuno / sa che cosa sono diventato. / Spauracchio sepolto, gattone celeste / o grigio affossatore d’avventure”. Intravvedere la propria sorte è l’unico interesse di giornata. La dedizione e la calma dell’autoanalisi decidono per un ultimo rimpianto come quando Bellezza scrive: “Poveri, pochi anni / sono rimasti, gelidi, limitati; / li dubito e li annuso sperando / di moltiplicarli e cedo deluso / al rimpianto calunnioso”.
La speranza è finita da tempo e la retrospezione propende per un annichilimento nel disperdersi di ogni energia e materia vitale. Anche il corpo è avviato ad una definitiva cancellazione delle proprie pulsioni. Muore giorno dopo giorno nell’acredine e in sillabari poetici dalla debordante aggressività. Il verso è concreto e vischioso. Il costante pensiero della morte affila un’esperienza mai riscattata fino alla ultima battuta, piena di pronunce e di detriti quotidiani, di mali che si trasferiscono nel corpo, con veri e propri sintomi fisici. Ecco, allora, che la morte non funge più da ossessione onirica. I serpenti che strisciano prima del colpo che avvelena e uccide, trovano terreno fertile per riprodursi.
Proprio la malattia segnerà il destino di Dario Bellezza. Un’atroce malattia, che sembra, a posteriori, anche un presagio. Ma c’è qualcosa che sembra peggiore della morte, che è estraneo perfino alla fine: è la convenzionalità dell’indifferenza comune, l’inferno quotidiano di un tempo lascivo, oltraggiato. Questo è il senso compiuto dell’opera di Bellezza, che genera crudeltà e compassione per i soggetti più deboli e indifesi. L’esilio è nel tempo, tra individualità e storia. Lo scontro sul piano ideale porta ad inquadrare un universo nero, irrecuperabile. La sconfitta dell’uomo è l’estremo sentire nella screpolatura delle cose. E con esse il singulto segna il passo dolente verso l’addio per un destino comune.
Proclama sul fascino (1996) è un viaggio senza ritorno, un canto e un ballo. Una sezione intitolata Il nulla, anticipa la morte e il congedo definitivo. Bellezza scrive spesso al passato. Impulsività e fervore sondano ancora la protesta vissuta, quel “lento suicidio” al quale fece riferimento Pasolini. Gli angeli della vita e della morte incarnano l’abbrutimento e la devozione. Il fascino dell’esistenza appare quello di un sinistro intuito, di una contraddizione tra l’essere e il volere, tra il bene e il male, che hanno impresso tutta l’opera del poeta. Il ritmo danzante di questo male endogeno imperversa in uno struggente impatto con la realtà e le sue implicazioni, in una lucidità razionale.
Non c’è un altro poeta del secondo Novecento che abbia scritto con la stessa foga e disperazione. Ma il suo esperpento letterario, per dirla con Enzo Siciliano, è nel veder violentata la propria scrittura. Dario Bellezza era raffinato nella percezione e barbaro nell’espressione, e la virulenza indica un segno distintivo che non può essere ritagliato solo come spazio singolo, ma anche come il rinnegare decisamente la propria contemporaneità. “Non si muore subito. / Si muore poco a poco / in ogni giornata, / impercettibilmente / in attesa di Lei / ci si copre la testa / per entrare nella Chiesa / in espiazione di peccati / mai commessi o tentati”.
Alessandro Moscè
Alcune poesie di Dario Bellezza da leggere sul sito Nuoviargomenti.net
Dario Bellezza, Tutte le poesie di Roberto Deidier
http://www.nuoviargomenti.net/poesie/dario-bellezza-tutte-le-poesie/









































Tutte le poesie di Dario Bellezza: l’atmosfera funesta del poeta.
Ero giovanissimo quando conobbi Dario, ma ebbi il tempo di frequentarlo per diverso tempo. Divetammo amici. La sua frequentazione sia umana che letteraria mi influenzò molto. Fu all’epoca il mio mentore.
L’ultima lunga intervista a Dario pubblicata è possibile leggerla qui:
==> http://bit.ly/1KLzQZM.
Gliela feci nel ’94 in procinto dell’uscita de’ L’Avversario. Ho deciso di farla conoscere ora in occasione dell’uscita dell’Oscar con le sue poesie complessive finalmente pubblicato da Mondadori.
Saluti e buona lettura!
Alessandro D’Agostini