Tra responsabilità e regole un tema oggi che investe anche la politica ma che sembra tradizionale nella società italiana. Dall’uso del treno, degli Smartphones alle tasse, passando per i mille momenti della socializzazione, esiste una difficoltà di coesistenza con il prossimo e la collettività. Cerchiamo di capire chi siamo anche sotto il profilo psicologico.
Sono su un treno a breve percorrenza. Mi guardo intorno e noto che si possono contare sulle dita di una mano le persone che utilizzano cellulari di vecchia generazione. È “di regola”, da alcuni anni, sfoggiare Smartphones di vari tipi, che danno la possibilità di collegarsi in qualsiasi momento alla rete internet, di ascoltare musica, di guardare e condividere fotografie.
È “di norma” su alcuni treni italiani, in particolare per le tratte verso il sud, trovare bagni sporchi ed intasati, scomparti in pessime condizioni igieniche; si tratta di treni, che, frequentemente, arrivano in ritardo a destinazione.

La “regola”, la “norma” diventa sinonimo di un costume, di un’abitudine diffusa, benché non sempre favorevole al benessere del singolo e/o della collettività, dato che si finisce per restare imbrigliati nella rete di un sistema e ragionare secondo la logica del sistema stesso. Allora, chi chiede al controllore – mentre altri restano in silenzio – di prendere provvedimenti o si rivolge all’ufficio reclami con veemenza è visto ed egli stesso si sente come un disturbatore rispetto a qualcosa che “così funziona”, che “accade da sempre e continuerà ad accadere”. Allo stesso modo, chi attende di arrivare a casa per collegarsi attraverso internet e guardare in privato le sue foto è quasi un eversivo, che si pone e viene allontanato da un gruppo virtuale di possessori di strumenti tecnologicamente avanzati.
Chi non possiede un computer o un cellulare all’avanguardia viene, visto, comunemente, come una persona che ha difficoltà ad accettare le trasformazioni che stanno avvenendo sul piano della comunicazione; nei fatti, risulta estromesso dalla possibilità di comunicare costantemente, visto che, oramai, ci si contatta prevalentemente tramite sms, mms, e-mail, whatsApp, skype, social network.
In treno, soprattutto nei lunghi tragitti, si vedono persone sgranocchiare continuamente; viene naturale congetturare che se, quelle stesse persone fossero rimaste a casa, alla loro vita definita “regolare”, “abituale”, in quel lasso di tempo, avrebbero fatto altro, sarebbero state impegnate in differenti attività riservando il pasto ad altri momenti della giornata. Per convenzione, infatti, abbiamo fissato degli orari – sebbene più o meno flessibili – per il pranzo e per la cena. Gli spostamenti in treno, a meno che non lo si faccia ogni giorno o periodicamente per lavoro/studio, rappresentano una sorta di interruzione della routine e di irruzione dell’insolito, a cui le persone cercano di adattarsi nelle maniere più disparate.
Se continuo il mio giro di perlustrazione nei vagoni, posso prendere nota della presenza di divieti di vario tipo: di gettare oggetti dal finestrino, di fumare, di aprire le porte e di salire/scendere dal treno quando è in movimento, etc… Per “osservare” tutto ciò, ovviamente, occorre pagare un ticket prima di salire a bordo, pena una multa in denaro!
È giusto che chi non paga il biglietto per viaggiare in treno sia passibile di un’ammenda economica, visto che usufruisce di un servizio, tuttavia c’è da chiedersi per quale servizio paga: di essere portato a destinazione? Ed è importante solo il risultato – vale a dire l’arrivo – o anche come ci si arriva, dunque le condizioni di viaggio, tra cui i ritardi? Qual è il contratto che viaggiatore ed azienda di trasporto ferroviario stipulano, con l’acquisto di un biglietto? Non sono tenuti entrambi a rispettare le regole di viaggio, seppure secondo modalità diverse?

Un contratto presuppone che tutti i contraenti si attengano alle regole, che queste ultime valgano sia per chi le emana sia per i riceventi.
Un viaggio in treno, in sostanza, è un viaggio nel mondo delle regole e in tutto ciò che deriva da esse.
Un viaggio in treno mette in risalto la pervasività delle regole: anche ciò che pensiamo non sia disciplinato da esse, in realtà, lo è. Perfino azioni ritenute ovvie, come uscire di casa vestiti, costituiscono una norma: non ci sogneremmo mai di girare per strada nudi, in quanto saremmo “dileggiati”, messi, cioè, fuori legge, banditi e tacciati come “anormali”. In fondo, è stato etichettato come ‘malato di mente’, per tanto tempo, chi è stato visto come fuori misura rispetto ad un canone, collocandolo fuori le linee tracciate da un righello sociale, che ha finito per non legittimare le sue azioni perché ascritte più alla presunta anormalità che a un modo di stare al mondo.
Si parla di pene più severe, di certezza della pena quale soluzione ad un comportamento contrario ad una norma giuridica, ragion per cui si rispetta una norma non perché la si è compresa, la si è fatta propria, la si è interiorizzata, piuttosto per il dovere di sottostare ad una sanzione, le cui ripercussioni sono paventate.
La questione delle regole, delle norme, delle leggi, a mio avviso, è molto più complessa del rapporto di causa-effetto.
La legge ha a che vedere con il fare o il non fare per pubblica utilità.
Siamo soliti vedere il volto coercitivo di una legge, quello che vincola, pone un limite, che dice cosa si può e cosa non si può fare. Perdiamo di vista il carattere facilitante, il fatto, cioè, che essa rende possibile, facilita le relazioni umane.
Il ritardo di un treno crea disagi non solo a chi viaggia al suo interno – specialmente se deve prendere una coincidenza –, ma anche ad altri treni, costretti a rallentare.
Il divieto di fumare in treno, se esige che qualcuno posticipi il proprio impulso, tutela tutti gli altri che non fumano.
Se non ci fosse un orario per andare a lavorare, ciascuno si presenterebbe sul posto di lavoro quando più gli aggrada, si creerebbe, in questa maniera, scompiglio e l’impossibilità di svolgere i compiti, gli incarichi per i quali si è stati assunti.
Il precetto religioso e giuridico di non rubare fa sì che né si sottragga né si venga sottratti di un bene personale.
Pertanto, una legge, una norma, una regola chiama in causa la presenza di altri, vincendo l’attitudine a compiere un’azione esclusivamente per un vantaggio privato. In ognuno, anche da grandi, è presente un retaggio psicologico di poter fare cose non concesse ad altri, di godere di privilegi, che lasciano fuori gli altri. Figli unici o figli prediletti! Il privilegio, essendo una legge fatta per uno o per pochi, segue la logica dell’esclusione, dell’aut-aut, anziché una logica inclusiva. Una norma ad personam genera rabbia, rivendicazioni, giacché si fa garante della gratificazione di un singolo e non delle esigenze di tutti.

Se una persona non opera una verifica periodica dell’impianto elettrico, idraulico, del gas, non solo può produrre danni alla propria abitazione, ma anche ai suoi vicini di casa. Parimenti, destinare un ambiente domestico ad un uso diverso da quello per cui è stato progettato, si pensi alla costruzione di una veranda, che porterà ad utilizzare il balcone come un altro vano, quindi a sistemarvi oggetti non adeguati ad esso, non solo può costituire un illecito, ma può minacciare la stabilità di un edificio e mettere in pericolo i restanti residenti.
La norma, la legge, la regola crea un nesso tra il tema della sicurezza – in casa, sui luoghi di lavoro, per strada, affinché siano ridotti i pericoli – e il riconoscimento dell’alterità.
Ognuno di noi è l’altro per gli altri individui; gli altri individui sono l’altro per ognuno di noi!
I comportamenti che un soggetto può tenere, allora, non sono del tutto ininfluenti; scegliere una condotta o un’altra ha una rilevanza individuale e collettiva.
La legge, la norma, la regola rappresenta un terzo che governa la relazione tra due o più soggetti (individuali, gruppali, nazionali, organizzativi, istituzionali, e così via discorrendo), in uno spazio che appartiene a tutti, con confini geografici, storici, culturali, sociali propri.
Nel rispetto delle regole, non può esserci solo il timore di essere puniti per il danno arrecato, nell’idea che ci sia una specie di oggetto persecutore – interno ed esterno – che infligge una pena (es. autorimproveri, sanzioni economiche, morali, giudiziarie), ragion per cui bisogna fare in modo di non essere scoperti e incrementare, al contempo, l’illusione onnipotente di farla franca – come quando da bambini si faceva una birichinata –.
Altra cosa è lo sviluppo del senso di responsabilità, figurandosi le conseguenze dei propri atti, nonché la possibilità di evitare una determinata conclusione adottando un comportamento diverso. La responsabilità, in questo senso, è intrinsecamente legata alle regole, poiché un mondo privo di norme non sarebbe prevedibile e gestibile, dunque nessuno potrebbe costruirsi uno scenario degli eventuali esiti delle proprie azioni.
La responsabilità è l’antidoto contro l’anonimato, che, premendo affinché l’identità dell’autore di un comportamento resti ignota, costringe ad una incessante ripetizione, perché non può esserci consapevolezza alcuna degli effetti che le azioni hanno nello spazio e nel tempo e della fattibilità di ripararvi.
La responsabilità riduce le intese collusive, nelle quali ci si colloca, vicendevolmente, in uno spazio funzionale ai propri bisogni, molte volte di conferma, si cercano modalità di adattamento che riducono la spinta strategica ed evitano qualsiasi cambiamento autentico.
Pensiamo, per un attimo, al politico di turno, che, per essere eletto, promette di salvare un paese che non ce la fa ad andare avanti, senza, poi, nei fatti fare nulla se non quello di perpetuare una condizione di attesa passiva o ancor peggio di rispondere con l’erogazione di fondi alle aspettative – proprie delle fantasie rispetto ai genitori di un’infanzia che alberga sempre dentro ognuno – di un’assistenza senza limiti e non con progetti per la promozione della responsabilità personale e dell’ingegno.
Questa può essere la via scelta dai cittadini e dai politici per assecondare gli uni il gioco degli altri, così da ottenere il vantaggio di non mettersi in discussione. Più in generale, consideriamo i rapporti amorosi, familiari, amicali, lavorativi, associativi, nei quali il patto sotterraneo mira a creare regole che, anziché essere rivolte al reale rispetto dell’altro e a garantire la non invadenza – cosa che fortemente si sostiene, quando, non volendo riflettere sulle proprie azioni e sulla natura del legame con l’altro, non ci si espone mai né si dice niente all’altro –, mantengono lo status quo, lasciano che gli aspetti non elaborati di ognuno restino tali, restino misconosciuti. In tutti questi casi, ci si viene a trovare invischiati in un processo che non è evolutivo: una nazione, una coppia, una famiglia, un lavoro, un’associazione resta in una situazione di stallo o addirittura involve.
Essere responsabili significa, invece, impegnarsi, in prima persona, a rispondere, a se stessi e agli altri all’interno dell’ambiente in cui si vive, delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano, ivi incluso ciò che si dice, senza nascondersi dietro frasi come «sto scherzando», «non l’ho fatto di proposito», «non ho fatto niente», «che faccio io?».
Le parole possono ferire, se non si ha cognizione di ciò che si pensa e si sente, in quanto si può attuare una disconferma dell’altro, facendo finta che non esiste. Il mancato rispetto delle regole è l’espressione di una disconferma: se, nonostante il cartello di passo carrabile, un automobilista parcheggia, mette in campo un atteggiamento che rivela di star ignorando le necessità di un altro; se in un condominio, chi abita ai piani superiori disturba nelle ore di riposo con rumori di vario tipo o stende la biancheria impedendo di fare altrettanto a chi sta sotto, nega l’esistenza di bisogni nel proprio vicino di casa.
Se si è responsabili, al contrario, gesti e parole possono curare. La psicoanalisi ha provato a sottolinearlo, ponendosi, appunto, come talking cure, quale cura attraverso la parola.
La psicoanalisi e la gruppoanalisi, per quanto con approcci diversi, invitano ogni individuo ad assumersi la responsabilità del modo in cui vive la sua vita, indipendentemente da quanto sia guidato e sostenuto dagli altri, senza andare alla ricerca affannosa di colpe proprie ed altrui, senza perdere tempo ad esaminare ciò che non va nella condotta del prossimo.

«Qual è la mia parte di responsabilità in ciò che sta accadendo?»
Se la colpa implica un ancoraggio al passato ed un ripiegamento sul fallimento che si pensa di avere ottenuto o che qualcun altro ha prodotto, la responsabilità congiunge presente, passato, futuro, apre a sé e agli altri – altri contemporanei ed altri che verranno dopo, appartenenti alle generazioni future –.
Donald Winnicott, psicoanalista inglese, collega il senso di responsabilità alla capacità di preoccuparsi. Il preoccuparsi si riferisce al fatto che l’individuo si prende cura o prova apprensione, sente ed accetta la responsabilità.
L’altro non è solo oggetto di appagamento, che si può usare a proprio piacimento, perfino distruggerlo, bensì anche qualcosa/qualcuno a cui si può dare, a cui indirizzare le proprie spinte affettive, la propria capacità di riparare il danno provocato, qualcuno di cui ci si cura.
Genitori e professionisti, per esempio, hanno la responsabilità di prendersi cura di qualcun altro, rispettivamente dei figli e dei clienti (utenti, pazienti). Questo preoccuparsi, però, non equivale semplicemente ad occuparsi delle cose da procurar loro (es. cibo, farmaci, materiali didattici, assegni familiari, etc…), finanche sostituendosi a loro, nella convinzione di sapere ciò che è bene per loro e perpetuando una condizione di dipendenza. Significa considerarli soggetti con cui realizzare le condizioni per imparare a scegliere, a conoscere autonomamente, a prendersi cura di se stessi.
Una responsabilità fondamentale, di fatti, è concettualizzabile come obbligo nei confronti della propria salute, che non corrisponde tanto a fare di tutto per non ammalarsi mai o essere perfetti nella propria perfomance – scorgendo nella patologia un inciampo da superare e nella regola un limite da travalicare –, quanto al prendersi cura di se stessi, alla conoscenza di sé senza attendere responsi oracolari e collusivi se si desidera creare una relazione autentica e trasformativa con gli altri.
I genitori, molte volte, sono poco consapevoli del fatto che stabilire le regole non rappresenta un esercizio di potere per decretare chi è il più forte in una relazione asimmetrica sul piano dell’emotività e dei bisogni, bensì è il mezzo attraverso il quale i figli possono apprendere la misura delle cose, dell’agire, come fare e quanto fare, quindi conoscere e disporre situazioni sicure e protettive per se stessi e nel rapporto con gli altri. I genitori, in primis, devono cogliere nel “no” – il proprio verso il figlio e di quest’ultimo nei loro riguardi, quando vorrebbe fare di testa sua –, il segnale di una relazione fondata sulla comprensione che non bisogna essere d’accordo necessariamente con l’altro per essere riconosciuto come persona, senza che nessuno senta l’esigenza di conformarsi alle attese altrui o di ribellarsi in un duello senza fine, trasferito pure all’esterno della famiglia.
In ambito lavorativo, è diffusa la tendenza a diluire la responsabilità, il cui peso è sentito come troppo forte, per cui tutti cercano di alleggerirlo coinvolgendo altri, delegando i propri compiti o circoscrivendo il proprio campo d’azione. Già, circa cinquanta-sessanta anni fa, Michael Balint, medico e psicoanalista, scriveva, per esempio, che, in campo medico, questa diluizione corrisponde al passaggio di un paziente da un medico all’altro, ciascuno dei quali lo sottopone a degli esami, senza che nessuno se ne assuma la piena responsabilità come persona nella sua globalità. Il paziente, quindi, diventa un insieme di pezzi del cui funzionamento occuparsi, senza integrare veramente i saperi necessari a prendersi cura di lui.
Ma … se anche le regole limitassero, perché il limite è così negativo, poco tollerato?
La possibilità di seguire le regole dipende dalla capacità di tollerare la frustrazione di non poter sempre ed immediatamente soddisfare i propri bisogni, di stemperare il proprio egocentrismo ed individualismo edonistico nella considerazione della presenza del desiderio degli altri. La frustrazione è il presupposto della crescita, dal momento che ogni stadio dello sviluppo ed ogni aspetto dell’ambiente possono fornire occasioni di frustrazione, essendo l’individuo un soggetto con una motivazione e indirizzato verso un fine, il cui raggiungimento può essere più o meno ostacolato; ciò che fa la differenza è l’opportunità di trasformare ciò che si vive in occasione di apprendimento.
Questa possibilità si costruisce già nella fasi di sviluppo del bambino, che incontra sin da subito le regole quali indizi delle leggi prescritte dalla società. Quando deve abbandonare il seno/biberon a favore del cucchiaio e del piatto, impara, gradualmente, a fare da solo ed, incominciando a constatare che i tempi in cui può mangiare si dilatano, si rende responsabile del proprio impulso alla fame e fa sua la capacità di procrastinare.
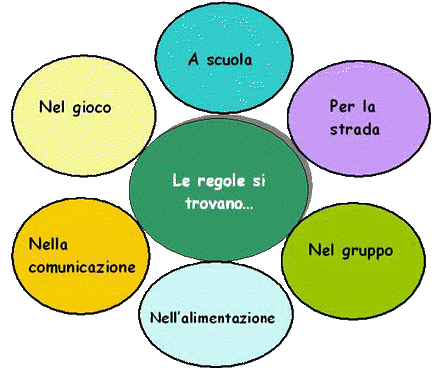
Parallelamente, contribuisce a questa acquisizione il passaggio dal pannolino al vasino e al water, perché segna il passaggio da un’espulsione involontaria ed immediata (sempre ed ovunque) ad un’espulsione volontaria e ritardata (in un altro momento e in un luogo preposto). E ancora, quando fa sua l’idea di dover rivolgere i suoi pensieri amorosi e i suoi interessi fuori dalla famiglia, si gettano le basi per lo scambio con l’esterno, per l’apertura verso il mondo, per la realizzazione di nuove alleanze e l’utilizzo delle differenze, tutto in senso evolutivo.
Assumersi la responsabilità significa essere adulti – non tanto in termini anagrafici –, accettare la realtà per quella che è – per quanto ruvida –, diversa dalla rappresentazione che si ha di essa, senza idealizzarla o svalutarla, senza vagheggiare un universo liscio e senza ostacoli, che richiama l’aspirazione a ritornare nel ventre materno prima della nascita, un luogo protettivo sì, però scarsamente volto al potenziamento dell’iniziativa personale, visto che c’è qualcun altro, la madre, che mangia al posto del figlio.
Essere adulti responsabili, cioè abili nel domandare e nel rispondere, vuol dire saper contribuire, con la propria parte di lavoro e di impegno, impedendo di sfruttare il lavoro e l’impegno altrui, al raggiungimento degli scopi comuni che una società/comunità si propone. Se lo sfruttamento esprime la paura del legame, interpersonale e sociale, l’impegno personale può concorrere all’ampliamento di un senso di appartenenza e di connessione emotiva – basilari per la co-costruzione, la condivisione e l’educazione alle regole –.
Sono i legami a far sorgere la responsabilità verso gli altri, a superare un’ottica autoreferenziale per realizzare progetti comuni sostenibili rispetto alle condizioni di vita di tutti.
Felicia Tafuri
psicoterapeuta individuale e di gruppo ad indirizzo analitico.





































Tra regole e responsabilità. Ed io speriamo che me la cavo!
Felicia
Grazie!
Penso che il titolo dovrebbe essere né responsabilità né regole. questa è la regola del nostro bel paese