La crisi politica italiana da ormai vent’anni è crisi dell’autorità. Che significa « autorità », come va interpretato questo concetto e come va utilizzato all’interno della vita politica? Proviamo a fornire una risposta utilizzando due grandi studiosi del Novecento italiano: Giuseppe Rensi e Giuseppe Capograssi. Le “Editions de la revue Conférence” nel 2012 hanno avviato la traduzione francese di alcune importanti opere di Capograssi. Hanno già pubblicato due eleganti volumi, uno dal titolo « Introduction à la vie éthique », con introduzione di Giuseppe Tognon, e un altro dal titolo « Incertitudes sur l’individu », con introduzione di Aniello Montano.
Premessa.
Partendo dalla considerazione che la crisi politica italiana da ormai vent’anni è crisi dell’autorità, dell’impossibilità cioè di una forza politica di accreditare autorevolmente e in maniera duratura la propria visione della vita (dell’economia, della morale ecc.) come vera giusta adeguata ai bisogni degli italiani, per comprendere qualcosa di questa politica e per cercare un sentiero capace di indicare la via d’uscita sarebbe utile ridiscutere il tema dell’autorità. Che significa « autorità », come va interpretato questo concetto e come va utilizzato all’interno della vita politica? L’autorità è, alla maniera di Machiavelli, pura forza scissa dalla morale e comunque da ogni spinta spirituale e interiore, o invece è espressione di una tensione al bene e all’altruismo presente all’interno, nell’intimità più profonda, di ogni singolo uomo? Considerando la questione in questo modo una risposta, ovviamente parziale e circoscritta, potremmo già provare a fornirla subito, utilizzando due grandi autori del Novecento italiano: Giuseppe Rensi e Giuseppe Capograssi. Di entrambi questi autori da alcuni anni è in corso una sorta di riviviscenza culturale. Il primo è stato riscoperto in occasione del cinquantenario della morte, nel 1991. Da allora si sono moltiplicate le riedizioni di alcuni suoi libri e le monografie sul suo pensiero. Io stesso ho riedito importanti saggi rensiani su « Spinoza », su « La morale come pazzia », su « Autorità e libertà » e ho scritto alcuni saggi. Il secondo è stato autore di nicchia per un lungo periodo, amato e studiato dai suoi discepoli (tra i quali vanno ricordati gli allievi diretti Francesco Cossiga, Pietro Piovani, Francesco Paolo Casavola, Francesco Mercadante, e gli allievi indiretti Biagio de Giovanni, Fulvio Tessitore e tantissimi altri, tra i quali da ultimo anche io. Di Capograssi oggi si sta interessando anche l’editoria francese. Le Editions de la revue Conférence nel 2012 hanno avviato la traduzione francese di alcune importanti opere di Capograssi. Hanno già pubblicato due eleganti volumi, uno dal titolo « Introduction à la vie éthique », con introduzione di Giuseppe Tognon, e un altro dal titolo « Incertitudes sur l’individu », di cui ho avuto l’onore di curare l’introduzione.

***
“Autorità” credo sia una delle parole più usate e non soltanto dagli scrittori interessati a questioni di carattere politico e giuridico. Essa è giustificata, di solito, da diverse derivazioni etimologiche ed è riferita a figure diverse. Potrebbe essere riferita all’ambito politico e derivare dal verbo latino augère, che vuol dire accrescere, far crescere. In questo senso autorità è chi ha il potere e la capacità di far crescere una comunità e di promuovere lo sviluppo della vita. Potrebbe riferirsi a un ambito di natura religiosa e derivare dal termine latino augur che designa colui che pronostica il futuro leggendo i segni divini nella natura. Potrebbe appartenere all’ambito del sapere e derivare dal termine greco autós indicante ciò che è più proprio del soggetto, l’intimità spirituale che connota ed esprime la personalità dei singoli, i contenuti profondi e universali della coscienza umana, capaci di ordinare l’esistenza umana e dar vita a nuovi ordini. Autorità, perciò, è chi si propone o viene indicato come modello di virtù morale civile politica culturale e così via enumerando. Lo è chi, per funzione istituzionale all’interno dello Stato, svolge un ruolo di guida e di comando ed emana leggi e decreti. Lo è chi, imponendosi con il potere della forza e dell’imperio, fa legge della sua volontà. Lo è anche chi con il fascino della personalità e della cultura induce gli altri a fidarsi di lui, a seguirne l’esempio, a farsi discepoli alla sua scuola. Autorità, però, è anche la “regola”, la “legge”, capace di mettere ordine nella immediatezza e confusa spontaneità della realtà umana, costituita da un ammasso di istinti, di attività, sentimenti e raziocini. Legge messa in essere dalla ragione ma ad essa superiore, emanata direttamente dalla verità, che “è l’assoluta personalità di Dio”[[G. Capograssi, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi [1921], in Idem Opere, vol. I, Milano 1959, p. 177.]].

La trattazione del tema, in questa sede, è limitata soltanto all’escussione di alcune considerazioni elaborate agli inizi degli anni Venti del Novecento da due filosofi del Novecento, lo scettico Giuseppe Rensi e il cattolico Giuseppe Capograssi.
Il concetto teorico di autorità da Giuseppe Rensi è direttamente collegato alla propria posizione di filosofo scettico-relativista. Muovendosi sull’“orma” di Protagora, al criterio dell’assoluta veridicità dei valori lo scettico Rensi sostituisce quello dell’utilità pratica. Il confronto sul piano civile e politico allora non è tra portatori di valori “veri” e sostenitori di valori “falsi”, ma tra punti di vista teorici e interessi pratici divergenti e per lo più incomponibili. Per questo motivo il suo scetticismo relativistico è attivo e combattivo e non afasico e apatico. Il filosofo deve battersi per l’affermazione delle idee che ritiene più rispondenti e utili alla specifica situazione storico-sociale del momento.
Il punto fermo a partire dal quale Rensi elabora la sua dottrina dell’autorità è rappresentato dall’accoglimento dell’“osservazione che, secondo Senofonte (Memorabili, I, 2), Alcibiade fa a Pericle, che cioè la legge pur votata dalla moltitudine contro pochi ‘senza averli persuasi’, è sempre « violenza piuttosto che legge’”[[G. Rensi, Autobiografia intellettuale. La mia filosofia. Testamento filosofico [1939], Milano 1989, p. 27.]]. Tradotta in altri termini l’osservazione di Alcibiade potrebbe essere letta come l’inclusione di fatto anche della democrazia, quale espressione della volontà della maggioranza da far prevalere su quella della minoranza, all’interno della categoria dell’autorità. Per Rensi, come per Alcibiade, quando s’impone una norma senza la preventiva adesione spontanea della totalità dei cittadini, si deve parlare di “violenza”, di imposizione autoritaria, anche se temperata e morbida, e non di applicazione della “legge”. Una filosofia politica che volesse sottrarsi all’etichettatura di “filosofia dell’autorità” dovrebbe dimostrare in maniera chiara e inequivocabile la possibilità di far convergere le menti della totalità dei singoli individui su una sola e definitiva verità, una sorta di universalis concordia omnium gentium. Risultato, questo, da Rensi ritenuto impossibile da conseguire da parte di qualsivoglia dottrina. Con queste affermazioni il filosofo veneto mira a realizzare un doppio obiettivo: l’accreditamento sul piano politico del suo scetticismo attivo e lo screditamento su questo stesso piano di ogni forma di razionalismo, quello di marca idealistica in modo specifico.

Il dramma della prima Guerra Mondiale fa maturare nella mente di Rensi il convincimento “che la ragione è non una, ma più antitetiche, e che queste più ed opposte ragioni sono certe sino al sangue e alla morte delle loro ragioni, e ciascuna sente che cedere circa queste sarebbe rinunciare alla ragione”, e “di tale fatto la guerra è l’effetto e la prova »[[Ivi, pp. 25-26.]]. In assenza di una Ragione capace di fornire le motivazioni assolutamente razionali per avviare un’azione politico-sociale, l’uomo –ragiona Rensi – non può essere condannato all’inazione e alla passività. Deve poter scegliere e tentare di imporre le scelte ritenute dal suo punto di vista più produttive e più giuste. Il principio attivato nel processo di estensione delle leggi, delle norme morali e dei giudizi estetici a quanti non li riconoscano come veri e assoluti, infatti, rimane pur sempre extralogico, irrazionale, e, pertanto, giustificato dalla sola forza, da un atto d’imperio, dall’applicazione del principio d’autorità.
Per Rensi l’assunto fondamentale del razionalismo politico e del liberalismo, secondo cui una legge per essere applicata alla totalità dei cittadini deve essere condivisa da tutti, deve presentarsi per ognuno di essi come coincidente con ciò che ciascuno autonomamente e liberamente ritiene essere verità e ragione, di fatto viene poi surrettiziamente violato. I teorici del liberalismo politico ricorrono, a suo dire, a stratagemmi falsificanti, quantunque raffinatissimi, per mostrare l’esistenza della possibilità reale di far coincidere Legge e libertà, intesa quest’ultima come libera volontà dell’individuo. Così Rousseau, nel distinguere la « volontà di tutti » dalla « volontà generale » e nell’individuare quest’ultima come la volontà diretta al bene pubblico o comune, finisce poi con il benedire come « volontà generale » la volontà della maggioranza e con l’esigere che la minoranza si sottoponga alle leggi stabilite da quella in quanto considerate incarnanti la « volontà generale ». Alla domanda su come gli oppositori possono ritenersi e essere ritenuti liberi e, nello stesso tempo, essere obbligati a sottomettersi a leggi da loro non avvertite come consonanti con il loro libero sentire, Rousseau risponde che « quando nell’assemblea del popolo si propone una legge, ciò che si chiede loro non è se approvino o respingano la proposta, ma se essa è conforme alla volontà generale, che è la loro: ognuno, col suo voto, dà il suo parere in proposito; e dal numero dei voti si ricava la dichiarazione della volontà generale »[[J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, a cura di G. Perticone, Milano 1965, p. 106.]]. La coincidenza della volontà del singolo con la « volontà generale », e quindi di libertà e Legge, dal filosofo ginevrino è spiegata con il convincimento, che deve essere fatto proprio da ogni cittadino, secondo cui « quando trionfa un parere diverso dal mio, questo fatto non prova altro che io mi ero sbagliato e che quel che credevo fosse volontà generale, non lo era. Se il mio parere avesse trionfato, avrei fatto cosa diversa da quel che volevo e non sarei stato libero » [[Ibidem.]].
Ad uno stratagemma simile – sostiene Rensi – ricorre anche Kant. Il filosofo di Königsberg, convinto che l’uomo nello Stato non abbia abbandonato la sua libertà ma l’abbia conservata non diminuita, giustifica tale asserto con la tesi per la quale la legge regolativa di tale dipendenza scaturisce soltanto dalla volontà legislatrice dei singoli individui. Nello Stato, perciò, ognuno deve decidere liberamente, seppure concordemente con gli altri, le leggi alle quali sottostare. “Soltanto dunque la volontà concorde e collettiva di tutti, in quanto ognuno decide la stessa cosa per tutti e tutti la decidono per ognuno, epperò soltanto la volontà generale collettiva del popolo può essere legislatrice”. Perciò tra gli “attributi giuridici inseparabili dalla loro natura di cittadini” c’è “la libertà legale, cioè la facoltà di non obbedire ad altra legge che non sia quella cui essi hanno dato il loro consenso”[[Cfr. E. Kant, Dottrina del diritto, par. 46, in Idem, Stato di diritto e società civile, a cura di N. Merker, Roma, 1995, p. 269, anche per la citazione precedente.]]. Di fronte alla conclamata e perennemente comprovata impossibilità di realizzare una concordia unanime, come fa Kant a mantenere il suo razionalismo politico? Ricorrendo anch’egli a un cavillo dialettico, risponde Rensi. Per Kant, perché si dia piena corrispondenza tra volontà dei singoli e Legge, non solo non c’è bisogno che tutti i cittadini, all’unanimità, votino quella legge, ma, al limite, non c’è neanche bisogno che essi siano chiamati a esprimere esplicitamente la loro volontà. Bisogna soltanto che il legislatore sia obbligato “a far leggi come se esse avessero potuto derivare dalla volontà di tutto un popolo” e a “considerare ogni suddito, in quanto vuole essere cittadino, come se egli avesse dato il suo consenso ad una tale volontà”. Una legge, infatti, non è giusta solo se “è fatta in modo che sarebbe impossibile il consenso di tutto un popolo ad essa […]. Ma se è solo possibile che un popolo consenta a tale legge, allora si ha il dovere di ritenerla giusta, anche se al momento il popolo si trovasse in una tale situazione o in un tale stato d’animo che, se fosse su ciò interpellato, probabilmente negherebbe il proprio assenso”[[E. Kant, Sul detto comune “ciò che può esser giusto in teoria, ma non vale per la prassi”, In Idem Stato di diritto e società civile, cit., p. 160, anche per le citazioni precedenti.]] . “L’unanimità – chiosa Rensi – sta dunque per Kant nella mera possibilità di essa, nel mero fatto che si possa senza assurdi pensare che una certa decisione sia unanimemente voluta”[[G. Rensi, La filosofia dell’autorità [1920], ristampa Catania 1993, p. 12.]].

Per Rensi ogni “tentativo di approdare per questa via a quell’assolutezza, universalità, identità (unanimità) che alle singole coscienze manca; non è che un parto della più vieta e abusata metafisicheria”[[Ivi, p. 43.]]. Contro questi espedienti considerati puramente formali, Rensi è convinto che ogni procedura relativa alla formazione e all’estensione alla totalità dei cittadini di una legge reca implicito l’uso della forza e, quindi, dell’attivazione del principio d’autorità. Non è pensabile neppure in via meramente ipotetica la possibilità di giungere all’unanimità attraverso il dialogo e la persuasione, perché “quand’anche esista una possibilità di persuasione individuale, non esiste mai una possibilità di persuasione che chiameremo collettiva”[[Ivi, p. 69.]]. Ma anche la “persuasione individuale” e l’accoglimento di un altro punto di vista non si verificano mai “pel motivo d’una convinzione nuovamente assunta solo perché se ne è liberamente scorta e approvata la razionalità, ma per la pressione bruta e irrazionale di puri e semplici elementi di fatto, di meri interessi materiali”[[Ivi, pp. 76-77.]]. Per tutte queste ragioni, per Rensi, “rimane ribadita la conclusione che nulla si può istituire, realizzare, mantenere, rinnovare nel campo politico, se non mediante la mera imposizione esercitata su qualcuno che non è liberamente convinto della disposizione, che non vi riconosce ragione, che vi si piega solo come a qualcosa che è, a un semplice fatto materiale e di forza”[[Ivi, p. 89.]]. Lo stesso vale nei rapporti tra Stati, nel cosiddetto diritto internazionale. Profondamente convinto dell’impossibilità di risolvere i conflitti tra nazioni diverse con il pieno consenso di tutti, Rensi ritiene che “il nodo gordiano dei problemi internazionali […] richiede di venir di continuo tagliato dalla spada; sia dalla spada figurata della pressione diplomatica e delle decisioni arbitrarie dei congressi; sia dagli atti d’imperio e autorità di potenze vincitrici, cioè dalla spada effettiva della guerra”[[Ivi, p. 144.]].

Con queste affermazioni Rensi prende atto di una realtà effettuale, mai smentita nel corso della storia umana, cioè che la guerra è “un fatto essenziale ed eterno”. Anche i più tenaci e accaniti pacifisti – afferma – sono costretti ad ammettere che c’è in loro un motivo, un nucleo di credenze, non negoziabile, non barattabile in una sorta di compromesso diplomatico e per il quale sono pronti a combattere e morire. Questo motivo è “quello che è per ciascuno essenziale”[[Ivi, p. 144.]]. La guerra assume in tal modo un supremo “significato filosofico” È la prova provata dell’illusione idealistica di far valere costrutti metafisici contro la dura realtà dei fatti.

La libertà, intesa quale antidoto all’autorità, a Rensi si presenta “nella sua essenza contraddittoria”. Intesa come rivendicazione del soggetto al libero possesso del proprio corpo e dei propri beni, la libertà prosegue con l’ampliare sempre più il proprio campo operativo e finisce con il volere essere azione sugli altri, espressione della volontà di ogni singolo di sottoporre gli altri alla propria volontà. Più diventa libertà, più rivendica la piena autonomia d’azione, più diventa libertà assoluta e si ribalta in “assoluto imperio”[[Ivi, p. 216.]]. E il confronto delle diverse libertà, improntato quanto si voglia alla reciproca fiducia, non approderà mai a un accordo perfetto e totale. Nel corso del confronto il dibattito alimenta “a dismisura le ‘varianti protestanti’”, i dissensi. Perché dalla discussione “uscisse uno Stato, una legge, una disposizione, un’azione” ci sarebbe bisogno, invece, che “le menti finissero per trovarsi d’accordo sul da farsi, diventassero unanimi, e così decidessero, facendo ognuno quel che vuole, restando ognuna libera”. La conclusione di Rensi è che “da ultimo, quindi, in un modo o nell’altro (e sia pure con l’atto di violenza attenuata del voto) bisogna che cessi la libertà e intervenga la mera autorità e la sottoposizione per atto d’imperio di alcune ad altre ragioni perché si possa operar qualche cosa, perché la vita possa proseguire il suo corso”[[Ivi, p. 217, anche per le citazioni precedenti.]]. La scelta decisoria, nell’assoluta isostenìa dei contrari, diventa tanto più autoritaria quanto più assorbe nel suo imperio aspetti della vita spirituale e quanto meno sopporta contrappesi in altre autorità nella cui azione rientrino alcune sfere di questa vita. Assorbendo in sé ogni aspetto dell’agire e del pensare umani tale autorità finisce per diventare “illimitata e sfrenata tirannide, che non lascia all’individuo alcun benché menomo margine di non-conformismo”[[Ibidem.]]. Per Rensi la visione organicistica dello Stato non suggerisce la concezione di uno « stato etico », di tipo hegeliano, avente come missione la realizzazione della pura razionalità, malgrado e contro le volontà dei singoli. Per lui, organicismo non significa affatto fede in un’entità, quasi metafisica, esistente o realizzantesi al di sopra degli individui concreti e avente una propria « missione » superindividuale da compiere. Significa soltanto tirannia resa possibile dall’abbandono della consapevolezza che le uniche realtà sociali concrete sono i singoli individui, con la loro forza e le loro debolezze.
L’aver additato la potenza come fondamento del diritto, l’aver esplicitato i meccanismi in base ai quali si forma e si estende la volontà della maggioranza e l’aver definito questa visione come « filosofia dell’autorità » non comporta affatto e meno che mai automaticamente la possibilità di considerare Rensi come teorico e difensore dell’assolutismo e dell’autoritarismo più bieco. Anzi, si potrebbe dire che, proprio perché notomizza i meccanismi della formazione della legge e dell’esercizio della forza a essa connesso, ne svela la natura, il fine e il limite, e la rende più comprensibile e più controllabile da parte dei cittadini. I veri autoritari, per il filosofo veneto, sono i difensori di uno Stato i cui contenuti normativi e la cui missione vengono considerati espressione diretta di un’imperscrutabile autorità superindividuale e non storico-esistenziale, o di natura teologica, come Dio o la Ragione assoluta, o semplicemente astratta, come Popolo, Nazione, Razza e così via. Nella chiusa di La filosofia dell’autorità, annota: “Può essere seducente e doveroso insorgere contro l’autorità e il conformismo, quando il loro impero è esteso, formidabile e potente, su tutte le sfere della vita politica, economica, religiosa, scientifica, morale dell’individuo, e, combattendoli, riuscire a sottrarre ad essi, e a rimettere alla libertà di questo, almeno un qualche margine di essa vita”[[Ivi, p. 226.]] .

Le tesi espresse in La filosofia dell’autorità, del 1920, risentivano dell’infuocata atmosfera del primo dopoguerra, degli anni in cui si avvertiva drammaticamente la frattura intervenuta nell’equilibrio tra classi e ceti sociali diversi e si veniva profilando un clima di guerra civile e di rottura costituzionale. Superato quel momento e denunciata prima di tanti altri la natura tirannica del movimento mussoliniano, in quanto mancante dello “spirito socratico del Critone”, e cioè il rispetto delle leggi[[Cfr. G. Rensi, Il Critone (Critiche al fascismo), “La Sera”, 23 novembre 1921, in Idem, Teoria e pratica della reazione politica, Milano 1922, p. 177.]], Rensi ripensa il rapporto autorità e libertà in un saggio, che vuole essere chiarificazione e precisazione, anzi “l’interpretazione autentica” delle tesi sostenute in La filosofia dell’autorità.
In Autorità e libertà, del 1926, afferma che lo Stato, se vuole salvaguardare la convivenza civile e con essa se stesso, deve organizzarsi nel rispetto non solo delle forme della democrazia e, quindi, delle ragioni dei più, secondo il principio di maggioranza, ma anche delle ragioni dei singoli, secondo «il principio dell’individualità garantita». Il criterio più esatto da tener presente nel regolare il rapporto tra questi due principi, Rensi lo formula così: «per i bisogni fondamentali rispetto alla vita spirituale dell’individuo e secondari rispetto all’esistenza politico-economica dello Stato, il principio dell’individualità garantita; per i bisogni fondamentali dal secondo punto di vista e secondari dal primo, il principio di maggioranza»[[G. Rensi, Autorità e libertà. Con un’appendice su Le colpe della filosofia, [1926], ristampa a cura di A. Montano per i tipi di Bibliopolis , Napoli 2003, p.120.]] . «Uno Stato civile – continua – non può, quindi, per essere ‘organico’ e non ‘atomistico’, menomare o lasciare indifesi poteri o facoltà concrete dell’individuo, quali l’inviolabilità del domicilio, l’integrità personale, la libertà di locomozione, di residenza, di espressione di pensiero, l’habeas corpus»[[Ibidem.]]. Nell’Apologia dello scetticismo, giunge perfino a rivendicare all’individuo il «diritto di ‘non conformismo’»[[G. Rensi, Apologia dello scetticismo, Roma 1926, p. 117.]], e il diritto-dovere alla «tolleranza […] che elimina dalla vita sociale la sopraffazione, l’oppressione, la crudeltà»[[Ivi, p. 109.]].
Vale la pena, per ultimo, ricordare che le considerazioni di Rensi di questi anni, sussurrate o gridate, risentono tutte di un clima in cui era fortemente avvertita la “crisi” dell’autorità. In questa situazione, anche se ispirate da differenti motivazioni e idealità, erano maturate diverse dottrine vòlte a ripensare il rapporto autorità-libertà, come ad esempio le Riflessioni sull’autorità e la sua crisi di Giuseppe Capograssi, ispirate al cristianesimo storicistico di Vico[[G. Capograssi, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi, in Idem, Opere, vol. I, cit.]] e poi la complessa teoria della legittimità del potere di Guglielmo Ferrero[[Pensata e abbozzata negli anni Venti, nei volumi Discours aux sourds, Paris 1924, Entre le passé et l’avenir, Paris 1926, L’unité du monde, Paris 1927, tale teoria trova piena attuazione in un’importante opera, Pouvoir, edita la prima volta a Parigi nel 1942 e in traduzione italiana a Milano nel 1981.]] .

Quelle di Giuseppe Rensi e di Guglielmo Ferrero furono vite parallele. Entrambi erano stati socialisti in gioventù e avversari decisi delle dottrine di Croce e di Gentile poi. Entrambi, in quanto pensatori della crisi, avevano preso congedo dall’idea romantica di un umanità in cammino costante verso le “magnifiche sorti e progressive” dell’umanità per rivalutare le radici irrazionali e volontaristiche della storia, con la conseguenza per entrambi dell’impossibilità di fondare un’unità spirituale e politica su un principio razionale. Alle tesi espresse da Rensi in La filosofia dell’autorità, Ferrero muoveva una serie di obiezioni: dalla presunta coincidenza di giustizia e forza alla possibilità implicita nel relativismo di far diventare morale qualsiasi cosa in nome dell’autorità. Alla prima obiezione Rensi rispondeva rimandando a un preciso passaggio della sua opera in cui affermava che “la giustizia o il diritto non è la forza”, ma che “la forza è solo ciò che determina il trionfo di fatto, e, quasi a dire, la scelta, d’una tra più opposte giustizie e diritti”, tutti isostenici dal punto di vista razionale[[F. Mancuso, L’itinerario intellettuale di Giuseppe Rensi nelle lettere inedite a Guglielmo Ferrero (1902-1928), “Nuova Antologia”, n. 2208, 1998, Lettera XXXIV, del 15.9.1920, p. 245.]] . Dalla seconda accusa si difendeva affermando che “solo alcune cose in luogo di certe altre possono essere fatte diventare morali dall’autorità: le une e le altre devono poter aver radici nella condizione di fatto; solo entro questa può aver luogo la determinazione da parte dell’autorità”[[Ivi, Lettera XXXV, del 4.10.1920, p. 247.]]. L’unica critica che si sentiva di accogliere riguardava la mancanza di “una precisa analisi di ciò che sia l’autorità”. E, nello scorcio finale di quello stesso 1920, si affrettava a precisare “che in fondo tale autorità è la maggioranza del gruppo sociale”, sulla quale “le autorità personali” dei governanti possono fondarsi[[Ivi, p. 248.]]. In Autorità e libertà preciserà che “l’unica forza che può veramente legare gli uomini e tenerli stretti in disciplina morale, civile e politica è quella del costume, della tradizione, dei ‘mores maiorum’”[[G. Rensi, Autorità e libertà, cit. p. 95.]].
Di natura completamente diversa la riflessione di Giuseppe Capograssi. Il pensatore abruzzese non esita a imputare la crisi attuale dell’autorità al declino del fondamento che dovrebbe sorreggerla. Un’autorità senza un sostegno certo e vero rischia di trasformarsi in autoritarismo e in forza cieca. L’autorità, perciò, va ancorata alla verità e “la verità è l’assoluta personalità di Dio”[[G. Capograssi, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi, in Idem, Opere, vol. I, cit., p. 177.]]. In tal modo “l’origine di tutta l’autorità e di tutti i diritti è nella prima autorità e nel primo diritto dell’Assoluto”[[Ivi, p. 178.]]. La volontà assoluta, in quanto legge, deve essere assorbita concretamente dalla volontà umana. In questo lavoro di adesione di questa a quella “l’autorità viene ad esplicare una funzione di mediatore: essa media tra due mondi, il mondo dell’assoluto ed il mondo del reale”[[Ivi, p. 180.]] . Se manca “la coscienza della verità viene meno cessa nella società ogni ordine in sé delle cose tra loro, ogni regola unitaria delle attività umane che compongono l’esperienza sociale”[[Ivi, p. 189.]].
L’autore di riferimento di Capograssi in questo, come in tantissimi altri snodi teorici del suo pensiero, è Giambattista Vico, che considerava la Scienza nuova “una filosofia dell’autorità”[[GB. Vico, Principj di Scienza nuova, a cura di F. Nicolini, 3 tomi, Milano1976, cpv. 7, p. 7.]]. Capograssi fa suo il modo di intendere l’autorità da parte di Vico. Il termine autorità deriverebbe dal quello greco autós cui corrisponderebbe quello latino proprium, suum ispisus. Nel De uno, infatti, Vico definiva l’autorità naturale come “nostra humanae naturae proprietas, per quam nemo eam nobis eripere potest”[[GB. Vico, De uno unversi iuris principio et fine uno, in Idem, Opere Giuridiche, Introduzione di N. Badaloni, a cura di P. Cristofolini, Firenze 1974, Caput XC, p. 107. Questa tesi vichiana da Capograssi è ripresa e illustrata in Dominio, libertà e tutela nel “De uno” [1925], in Idem, Opere, cit., vol. IV, p. 20.]] e attribuiva ad essa la capacità di distinguersi, pur rimanendo sempre una, in tre elementi: “nosse, velle et posse”[[Ivi, Caput XCII, p. 109.]]. L’autorità naturale dell’uomo dipende, dunque, dalla mente in cui sono presenti “quasdam communes aeterni veri notiones”[[Ivi, Principium 2, p. 41.]] , le quali, per essere comuni, consentono la comunicazione e l’unione tra gli uomini. Questi, però, non potrebbero possedere tali nozioni se non avessero in comune anche “ordinis aeterni ideam”, l’idea dell’ordine eterno[[Ivi, Principium 3, p 41.]]. Il quale, per essere eterno e comune a tutti, non può essere prodotto da menti finite, con la conseguenza che “idea ordinis aeterni est idea mentis infinitae. Mens infinita Deus est”. È Dio l’autore delle verità eterne da noi possedute[[Ivi, Principium 3, p. 43.]]. Per Capograssi, come per Vico, senza “l’ordine della Verità assoluta” non ci sarebbe l’autorità e neppure il diritto. “L’autorità consiste proprio in quella coscienza, per quanto attenuata, della verità per cui l’uomo si ricollega in certo modo all’ordine assoluto”[[G. Capograssi, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi, in Idem, Opere, vol. I, cit., p. 332.]] . In quanto amore, la verità si unisce alla vita, si realizza come vita e, “in quanto vita e forza della realtà è autorità”[[Ibidem.]] . Pur provenendo da Dio la verità, l’idea, è nascosta nel reale. Ed è là che l’uomo la deve cercare, nel “secretissimo nesso idea e vita dentro lo stesso rapporto di vita”[[Ivi, p. 12.]]. Nella visione cristiana di Capograssi l’autorità compare prima nello spirito individuale come idea dell’ordine, della gerarchia, della subordinazione e, concepita in questo modo, si accredita come “autorità essenziale senza della quale l’autorità sociale non ha alcun valore”[[Ivi, p. 261.]]. Incarnatasi nell’individuo sottoforma di “spirito razionale vivente in società”, l’autorità svolge il compito di umanizzare la vita sociale nel tendere all’assoluto. E, in quanto volontà umana tendente all’assoluto, “vive nell’ordine e dell’ordine delle cose”. L’azione dell’autorità nella società tende all’attuazione di quest’ordine, inserendo nella serie dei fini individuali fini razionali e universali. Favorendo la relazione tra uomo e uomo e trasformando “in volontaria e riflessa la naturalità della convivenza sociale”, promuove il “bene comune”. Sicché – afferma Capograssi – “la parola dell’autorità è la bella parola antica ‘amicitia sit’”[[Cfr. ivi, p. 203, anche per le brevi citazioni precedenti.]] .
Un’autorità senza forza, però, è destinata a soccombere e a rinunciare al suo compito di realizzare il “bene comune”. Per questo “il segno più comune dell’imperium è il gladium”. Ma come è possibile conciliare l’autorità, tensione spirituale tendente all’assoluto, con la forza? Capograssi sente di dover rispondere alle stesse difficoltà sollevate da Rensi nei confronti del razionalismo politico di Rousseau e di Kant. E pensa di risolvere la questione concependo l’autorità come forza obbligante espressione della volontà libera dell’individuo. In tal modo, afferma, “imperio ubbidienza dominio e soggezione diventano effetto della volontà umana opera del singolo creazione della sua ragione”[[Ivi, p. 215.]]. La legittimazione e la giustificazione dell’imperium derivano dal contratto: la volontà essendosi liberamente obbligata, quando obbedisce è libera perché osserva quello che essa stessa ha posto. E, nel creare e giustificare l’imperio, la stessa volontà “giustifica l’osservanza di tutti i rapporti della vita giuridica”[[Ivi, p. 216, anche per la precedente citazione.]]. L’individuo sente il comando dell’autorità come “esteriore coazione” soltanto perché è soggetto alla passione e al male, non è libero, non fa uso della ragione tendente al bene. È soggetto alla “riluttanza dello spirito individuale ad essere se stesso”[[Ivi, p. 225.]], con la conseguenza che “il problema della forza è dunque il problema della passione”[[Ivi, p. 227.]]. Se nell’uomo non prevalesse la passione non ci sarebbe bisogno della forza per indurlo a operare in vista della realizzazione del “beene comune”.
Il contrasto tra verità e razionalità da una parte e debolezza e passione dall’altra conferisce un’intonazione “tragica” alla vita umana. Consente, però, di considerare l’autorità vichianamente come “questione non più sensibile ma etica” e di sentire quale “principio della vita veramente umana […] questo formarsi della personalità etica questo uscir fuori dalla immediatezza dei sensi”. Intesa forza veritativa l’autorità diventa “la mente dello Stato”, “mentalità guidata dal lume dell’assoluto, moralità e bontà” e cioè “la personalità morale e la virtù”, che “debbono essere la forza direttiva della società” [[Ivi, p. 334, anche per le citazioni precedenti.]]. La vis veri, la forza della verità, perciò, non è un principio di conoscenza ma un principio d’azione consistente nello sforzo morale di combattere la passione per realizzare la virtù. Dal dominio sulle cose, dalla libertà nata dall’uso temperato delle cose e dalla tutela di sé, non secondo istinto ma secondo ragione, nasce l’autorità[[Cfr. ivi, p. 336.]]. La storia del formarsi dell’autorità e del diritto per Capograssi, infatti, fa tutt’uno con la storia della conquista umana dell’indipendenza dal bruto istinto della conservazione e con quella dell’interiorizzazione e dell’accettazione come dovere della legge dell’ordine e della verità attivi in tutto l’universo. “Se la verità non domina la città civile, presente attiva totale, questa si scompone e muore”[[Ivi, p. 335.]] .
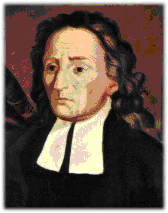
Si tratta allora di definire in maniera adeguata il concetto di ragione. In Hobbes la ragione è connessa, se non fa tutt’uno, con metus e cupiditas, e di fatto coincide con la passione. In Spinoza passione e ragione sono distinte, la prima alimenta confusamente la tendenza fondamentale alla conservazione di sé dell’individuo, la seconda tende allo stesso fine ma in forma “chiara e adeguata”[[Cfr. ivi, pp. 344-345.]]. La ragione, per Capograssi, è ragione soltanto quando è universale, quando è totalmente affrancata dalla passione e dal senso. La crisi del nostro tempo nasce proprio dall’inadeguatezza dell’azione umana al principio di moralità implicito nella ragione. “L’individuo che è stato dichiarato libero – denuncia Capograssi – scambia questa sua libertà proprio per il suo contrario, per indipendenza, e nel suo inganno si assoggetta perennemente alle sue passioni e all’oceano del movimento dei fatti”, con la conseguenza che “non la volontà umana ha preso il dominio della vita, ma la passione, il senso, la massa”[[Ivi, p. 389, anche per la citazione precedente.]].
La conclusione di Capograssi è ancora tutta sotto il segno della filosofia vichiana. Di fronte al disincanto della vita che ha reso vano le cose della vita e di fronte agli uomini “che non vogliono capire il vero valore delle cose presenti”, “le forme della vita nelle quali l’individuo ha creduto di potersi rifugiare […] spariscono si dissolvono, si inabissano nella rovina del mondo sociale”[[Ivi, p. 400.]]. Per poter risalire la china – è questo l’amaro presagio di Capograssi – “è necessario che la barbarie abbia il suo spaventevole sviluppo e soffochi se stessa nel sangue che essa stessa ha versato perché l’uomo possa essere risollevato verso i misteri dello spirito e della verità”[[Ivi, p. 401.]] . In un saggio su L’attualità di Vico, Capograssi preciserà: «Per Vico, la Provvidenza è una legge di necessità, per la quale l’individuo deve arrivare all’estremo della sua esperienza; fino alla catastrofe. Quando si è scesi per tutto il piano delle cadute, fino a Nerone, a quell’ultimo punto si ricrea l’esperienza di morte da cui nasce il pensare umano, il mondo umano. Attraverso la catastrofe si ricreano le condizioni di morte, che permettono di riattingere le tre idee centrali di Vico, cioè il pensare umanamente» [[G. Capograssi, L’attualità di Vico [1943], in Idem, Opere, vol. IV, cit., p. 401.]] . Come Vico, anche Capograssi sembra utilizzare la metafisica piegandola tutta in funzione storico-civile.
(I ritratti sono di Giuseppe Rensi, Giuseppe Capograssi, Russeau e Vico).
Aniello Montano















































L’autorità e la sua crisi in Giuseppe Rensi e Giuseppe Capograssi
Egregio professore,
non sono molto sicuro che nella riflessione umanizzante di Vico(e Capograssi)il loro Dio, variamente declinato in provvidenza o legge di necessita’, sia il Dio della tradizione. Ha gli attributi di un principio di svolgimento e movimento metafisico, caratteri, tuttavia, che un filosofo autodefinenetesi « immanentista » come Croce, potrebbe attribuire (e attribusice) alla storia; d’altra parte anche per Croce la fonte prima d’ ispirazione e’ Vico.
Questa mia convinzione o meglio, percezione intuitiva, deriva da una lunga frequentazione ormai con il pensiero di Capograssi che, alla domanda di frontiera « e’ il pensiero di Capograssi vincolato o debitore ad una concezione immanentista o trascendente », non ha mai saputo dare una risposta definitiva, propendendo per l’ uno o l’altro campo. Credo, di piu’, e in tutta onesta’, che non sia nemmeno necessario e sia alquanto surrettizio creare questa ambivalenza, se non per fini soggettivi di appropriazione di parte e di credo, operazione che non rende pero’ giustizia alla ricchezza e alla complessita’ insoluta e inconclusa del pensiero capograssiano. Ho riletto recentemente il testo la Nuova democrazia diretta dandone resoconto sintetico ad una nostra comune conoscenza (il prof. Mercadante). E’ un testo di scienza della politica e di diritto costituzionale lungimirante, affidato al taglio netto di una mente rigorosissima, lucidamente applicata al concreto. E in questo contesto viene condotta una analisi dell’ autorita’ meglio, della legittimita’, in cui e’ assente qualsiasi richiamo o appendice metafisica.
Senza sovraccarico di secondi fini si potrebbe saggiare la legittimita’ di una linea intepretativa (e percorrerla) che riconosca nelle Riflessioni la parte destruens e nella Nuova democrazia la parte construens del contributo analitico capograssiano alla crisi dello stato liberale. Si potrebbe cioe’ leggere Capograssi (mi affretto a chiudere) come Einaudi (non e’ un caso il comune interesse per Le Play) privilegiando un indirizzo di lettura rivolto al concreto, senza (quello si’) sovraccarico metafisico.
L’autorità e la sua crisi in Giuseppe Rensi e Giuseppe Capograssi
Mi ha fatto molto piacere leggere le riflessioni dell’amico Lattanzi, con il quale sostanzialmente concordo. Su concetto di Dio e di Metafisica in Vico ho discusso in più occasioni e in più occasioni ho evidenziato la differenza della posizione del filosofo della Scienza Nuova da quella dei cattolici suoi contemporanei e successori. In un passaggio dell’Autobiografia, Vico afferma di compiacersi per aver sempre fatto uso della « pratica di proporre universali argomenti, scesi dalla metafisica in uso della civile ». E nella Scienza Nuova è preconizzata una metafisica che cerchi i “principi universali ed eterni, quali devon essere d’ogni scienza, sopra i quali sursero e tutte si conservano in nazione”. E li deve cercare nelle realizzazioni storiche degli uomini, i soli autori di “questo mondo di nazioni”, e precisamente in quelle cose in cui “hanno con perpetuità convenuto e tuttavia vi convergono tutti gli uomini”. Lo stesso vale per Capograssi. Per Vico come per Capograssi il vero « motore della storia » è l’uomo e non Dio. L’uomo matura le « idee-forme » della civiltà, gli istituti civili e politici, dentro l’esperienza concreta della vita. Le « idee-forme » nascono e operano all’interno dell’azione umana in situazioni concrete e precise. Per fornire un appoggio a queste breve considerazioni invio un saggio, già nel titolo eloquente: « Giuseppe Capograssi. Oltre le interpretazioni cattoliche di Vico ». Saggio che può essere utilizzato dal sito liberamente. Grazie.