Da tempo mi interrogo su cosa significhi oggi la Dolce vita, un concetto quanto più banalizzato, stereotipato ed ancora oggi ricollegato alla vita italiana.
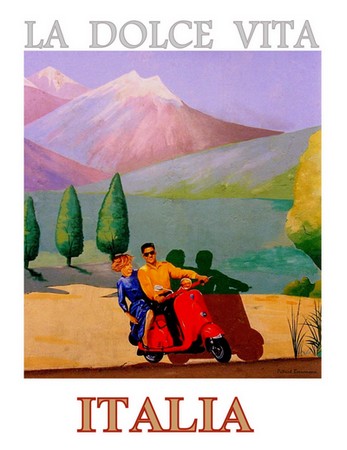
Principalmente perché ne sento la nostalgia, sentimento che riconosco essere del tutto irrazionale in quanto negli anni Novanta la Dolce vita era già un bel ricordo. Eppure è così forte in me che non posso fare a meno di evocarla. Me l’immagino come un periodo felice in cui la vita era estremamente leggera, diversamente da adesso. In che senso direte? Bè, la risposta che mi sono data è sicuramente influenzata dalla conoscenza della storia e di ciò che furono gli anni Sessanta del secolo passato.
L’Italia, dopo essersi ricostruita a seguito del Secondo Conflitto mondiale, era in pieno sviluppo economico, il lavoro non mancava, la politica si era ricostruita democraticamente sulla solidità e credibilità internazionale della Democrazia Cristiana (DC), la scolarizzazione era in aumento, la televisione e gli elettrodomestici stavano entrando nelle case degli italiani dilettandoli ed aumentando la qualità della vita, soprattutto quella delle donne che si videro, progressivamente, sollevate dagli usuali lavori domestici. Insomma, il terrore della guerra e delle politiche di regime, la miseria dilagante facevano parte del passato sebbene ancora molte regioni versassero in situazioni di grande povertà. Sto pensando, in particolar modo, alla Basilicata e alla bellissima città di Matera dove nel 1948 il 71,59% delle case erano inabitabili (senza acqua corrente, né fognature e in cui animali e umani condividevano gli stessi spazi); di esse fu ordinato lo sgombero nel 1951 e il risanamento avvenne solamente dopo un ventennio. Ad ogni modo, in quegli anni, come mi hanno sempre raccontato i mei nonni, si viveva bene. Un esempio ci è dato dalla diminuzione dei flussi migratori in uscita e dal rientro di molti connazionali che importarono nel Paese le competenze e le conoscenze, principalmente commerciali e tecnologiche, acquisite all’estero.
«Era meglio quando si stava peggio», ecco una frase che risuona adesso in relazione a quel passato, sebbene la citazione riguardi il periodo mussoliniano in cui effettivamente si stava peggio ma che, per i nostalgici della destra estrema, rappresentava non pochi aspetti positivi. In verità negli anni Sessanta del Novecento si stava veramente meglio di adesso.
Riflettiamo: davvero il computer, internet, gli I-phone, i vestiti a basso costo, lo sviluppo dei trasporti, i fast-food, l’abbattimento formale delle classi sociali ed il facile accesso a ogni bene (non soltanto di prima necessità) hanno aumentato la nostra qualità di vita? Forse sarò ritenuta una reazionaria ma a me sembra che siano più le cose che si sono perse di quelle che abbiamo acquisito. Arriva infatti il giorno in cui tiriamo le somme, un banale calcolo dei più e dei meno. L’incertezza lavorativa e relazionale è sicuramente un grosso punto a sfavore che ci ha lasciato in eredità il neoliberismo, l’idea che il mercato si autogestisca e che la crescita economica debba essere costante e continua. A ciò sono seguite le conseguenze sociali, sintetizzate dal sociologo Bauman in Vita liquida, Amore Liquido ed in altre sue opere. L’individualismo ha disintegrato la comunità e, sebbene in Italia l’unità e l’eguaglianza sociale siano date per scontate (principalmente perché parliamo italiano e tutti siamo uguali di fronte alla legge), i fatti politici d’attualità ci dimostrano il contrario. Ingiustizia e sfiducia ecco le cause che giustificano il mio malessere.

E le conquiste sociali del Sessantotto, per terminare con la legge per l’aborto del 1978, davvero hanno cambiato il mondo, modificando anche il nostro modo di pensare? Io direi solo in parte. Un effetto positivo è evidente soprattutto dal punto di vista delle donne. Mia nonna mi ha raccontato, ad esempio, che quando ha divorziato da suo marito, negli anni Ottanta, la cognata le ha detto che si vergognava di esserle parente. Adesso ognuno può farlo senza subire il giudizio altrui e negli anni Novanta è divenuto quasi di moda, con effetti che si reputavano benefici sui bambini sostenendo che, così, crescevano «più velocemente». L’aspetto negativo è che, con la legalizzazione del libero arbitrio, si sono perse anche quelle regole non scritte del vivere comune come la responsabilità verso l’altro, la solidarietà e i valori, parole che, adesso, si fa fatica a definire.
Insomma, quanto c’è ancora nei trentenni italiani di oggi dei retaggi culturali del Dopoguerra? A mio parere c’è ancora molto e questo ha portato la nostra generazione ad un completo disorientamento sia nei confronti della carriera lavorativa, sia in quella relazionale (mi riferisco in particolar modo all’uomo che cerca nella donna amata sua madre, sbattendosi contro l’immagine della nuova Lei del ventunesimo secolo: indipendente e imprevedibile). Ci convinciamo di voler vedere il mondo come ci è stato dipinto ma in realtà questo mondo ancora non esiste: quello dell’assenza delle classi sociali, del merito e del sogno americano a casa nostra, «se vuoi puoi». Invece non posso, non posso fare progetti coniugali perché non ho un lavoro stabile, non posso crearmi una famiglia quando vorrei perché «prima è meglio pensare al proprio futuro»; ma è estremamente difficile e, proprio perché siamo tutti uguali, la mia laurea adesso non vale niente e l’unica cosa in cui posso sperare è farmi voler bene e trovarmi quei buoni contatti che un giorno, forse, mi proporranno un’occupazione lavorativa –a tempo determinato. Ho messo da parte l’ambizione di poter comprare un giorno una casa perché so che, anche se decidessi di voler passare tutta la vita nello stesso posto, la mobilità e la flessibilità richieste mi porterebbero altrove.

In conclusione, ciò che vorrei fosse riconosciuto ad una gran parte della mia generazione di dispersi è il fatto di accontentarsi e di colmare le lacune precedentemente citate, conciliando la liquidità dell’esistenza con l’idea di ciò che ci hanno insegnato essere i valori sociali, e rassegnandosi di fronte al fatto che la Dolce vita sia veramente storia passata.




































