Un’intervista al Prof. Luca Serianni, docente di Storia della Lingua italiana all’Università “la Sapienza” di Roma, autore del libro “L’ora d’italiano. Scuola e materie umanistiche”, Editori Laterza, 2010. Alla luce di una lunga esperienza e di una grande sensibilità didattica, Luca Serianni, tra i “saggi” incaricati della supervisione dei nuovi programmi entrati in vigore nel settembre 2010, parla della lingua italiana, a scuola ma non solo, con riferimenti al latino e ai dialetti regionali.
– In qualità di consulente del Ministero della Pubblica istruzione per la Riforma Gelmini, ha dovuto lavorare alla messa a punto dei programmi, nello specifico per le materie umanistiche, italiano, latino e greco. Quali sono stati i cambiamenti più importanti apportati ai programmi?
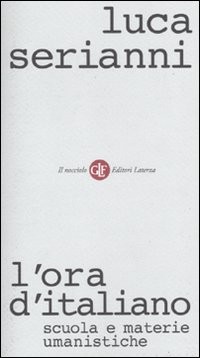 A parte il greco, che è rimasto sostanzialmente immutato, per il latino si è dovuto fronteggiare il forte ridimensionamento orario nei licei scientifico e linguistico. L’orientamento è stato quello, almeno per questi due indirizzi, di depotenziare l’importanza della prova scritta, la tradizionale « versione », insieme col soggiacente apparato teorico, del resto non sempre adeguato per raggiungere un’accettabile padronanza della lingua di Roma. Accanto alla sintassi, che finora ha fatto la parte del leone nell’insegnamento del latino, hanno infatti importanza non minore il lessico e la semantica: soprattutto se si vogliono sottolineare i legami che il latino intrattiene non solo con le lingue romanze, ma anche con l’inglese, una lingua tipologicamente germanica che però è stata profondamente influenzata nel suo lessico dal latino, anche attraverso l’influsso francese. Quanto all’italiano, si è affermata la necessità di non ridurre l’insegnamento linguistico al solo biennio delle superiori, estendendolo anche al triennio, finora dedicato esclusivamente alla storiografia letteraria. Gli autori letterari mantengono beninteso la loro importanza, ma l’orientamento attuale è quello di puntare su alcuni scrittori riconosciuti come classici (a partire da Dante), rinunciando a ogni pretesa di completezza, inevitabilmente velleitaria. Meglio un numero ridotto di autori, da leggere con calma attraverso alcuni testi esemplari, che un disegno storico-letterario magari ampio, ma necessariamente superficiale perché sganciato dal concreto contatto − letterario, storico e linguistico − con i testi.
A parte il greco, che è rimasto sostanzialmente immutato, per il latino si è dovuto fronteggiare il forte ridimensionamento orario nei licei scientifico e linguistico. L’orientamento è stato quello, almeno per questi due indirizzi, di depotenziare l’importanza della prova scritta, la tradizionale « versione », insieme col soggiacente apparato teorico, del resto non sempre adeguato per raggiungere un’accettabile padronanza della lingua di Roma. Accanto alla sintassi, che finora ha fatto la parte del leone nell’insegnamento del latino, hanno infatti importanza non minore il lessico e la semantica: soprattutto se si vogliono sottolineare i legami che il latino intrattiene non solo con le lingue romanze, ma anche con l’inglese, una lingua tipologicamente germanica che però è stata profondamente influenzata nel suo lessico dal latino, anche attraverso l’influsso francese. Quanto all’italiano, si è affermata la necessità di non ridurre l’insegnamento linguistico al solo biennio delle superiori, estendendolo anche al triennio, finora dedicato esclusivamente alla storiografia letteraria. Gli autori letterari mantengono beninteso la loro importanza, ma l’orientamento attuale è quello di puntare su alcuni scrittori riconosciuti come classici (a partire da Dante), rinunciando a ogni pretesa di completezza, inevitabilmente velleitaria. Meglio un numero ridotto di autori, da leggere con calma attraverso alcuni testi esemplari, che un disegno storico-letterario magari ampio, ma necessariamente superficiale perché sganciato dal concreto contatto − letterario, storico e linguistico − con i testi.
– Quali ragioni, di tipo didattico e più genericamente socio-culturale, hanno reso indispensabili questi stessi cambiamenti?
Un aspetto della riforma sul quale esiste un diffuso consenso, trasversale alle varie forze politiche, è il rafforzamento delle materie scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia, informatica) e della lingua straniera. Molto più discussa la diminuzione del monte ore − peraltro sostenuta da molti pedagogisti, convinti che la prolungata presenza in aula dei ragazzi non sia di per sé garanzia di un migliore apprendimento − e soprattutto l’aumento del numero di studenti per classe. Difficile negare che la spinta decisiva provenga dalla necessità di economizzare le spese. Può dispiacere che la scure si sia abbattuta anche su un comparto così vitale per il futuro del Paese come l’istruzione; d’altra parte è opportuno fare di necessità virtù e approfittare di quest’occasione per svecchiare i programmi, rendendoli più funzionali alla formazione di un adolescente dei nostri tempi, senza snaturare l’impronta umanistica che i licei italiani (in particolare il classico e lo scientifico tradizionale, quello comprendente il latino) tuttora mantengono.
– Qual è il ruolo delle cosiddette « lingue morte » nella scuola di oggi, a Suo avviso?
La ragione fondamentale per continuare a studiare il latino (e il greco nel liceo classico) è di carattere storico-culturale. È importante prendere coscienza del significato della tradizione classica, che ha innervato la cultura europea fino alle soglie dell’età contemporanea; ancora nel primo Ottocento, ad esempio, nelle facoltà mediche scandinave e tedesche le lezioni venivano svolte in latino. Ma prendere davvero contatto con una civiltà non è possibile se non risalendo alla lettura diretta dei testi che quella civiltà ha espresso; certo − lo ribadisco − bisogna avere ben chiaro che a scuola ben più importante del compito scritto di traduzione è la lettura dei testi, anche muniti di note che appianino le asperità e guidino lo studente nella corretta costruzione del periodo. Il latino e il greco devono cessare di essere uno spauracchio di cui oltretutto sempre più studenti, specie nell’Italia centro-settentrionale, non avvertono più la necessità formativa. Bisogna puntare sempre di più sulla prospettiva storica (qual è il rapporto del latino con l’italiano e con le altre lingue romanze?) e allargare il ventaglio dei testi da leggere, senza ridursi a quelli, pur grandissimi, del solo periodo aureo.

– Ritiene vero che le competenze linguistiche gli studenti italiani siano, in linea generale, piuttosto carenti? Se si, quali possono esserne le ragioni? E quali potrebbero essere i rimedi più efficaci?
Recenti rilevazioni a campione, nazionali e internazionali, non hanno dato in effetti risultati confortanti. Le ragioni sono varie: l’insegnamento dell’italiano, come si accennava, ha assegnato più peso alla letteratura che non alla lingua; quest’ultimo è stato orientato più al riconoscimento delle strutture (« individua gli avverbi di modo, di tempo, di luogo… ») che non alla produzione di testi grammaticalmente corretti e pragmaticamente efficaci; il « tema », la tradizionale prova scritta in auge nelle nostre scuole, non è in moltissimi casi la prova più idonea per educare le competenze linguistiche (molto più utili sono, per esempio, il riassunto e gli esercizi di completamento di strutture grammaticali o lessicali, cioè il cosiddetto cloze ben noto alla glottodidattica). Occorre che in classe entri la lingua dei giornali che offrono, specie in alcuni settori (gli editoriali firmati da grandi giornalisti o da saggisti di fama) eccellenti esempi di una lingua limpida, efficace, ricca e articolata dal punto di vista lessicale.
– Gli stranieri che imparano la nostra lingua sono molto spesso affascinati dalla quantità e varietà dei dialetti del nostro paese. Ci può spiegare meglio cosa distingue una lingua propriamente detta da un dialetto?
Lingua e dialetto hanno la stessa dignità espressiva e comunicativa, e in Italia non mancano certo dialetti che hanno alle spalle una gloriosa tradizione letteraria (come il milanese di Carlo Porta o il romanesco di Giuseppe Gioachino Belli), talvolta assai vitale anche oggi. Le differenze sostanziali sono due:
1) il dialetto non ha sviluppato la capacità di esprimere l’intera gamma comunicativa, restando confinato all’uso orale o magari alla poesia (come ha detto un grande poeta dialettale recentemente scomparso, Raffaello Baldini, in dialetto si può parlare a Dio, ma non si può parlare di Dio);
2) il dialetto non ha l’omogeneità propria di una lingua che, sia pure con oscillazioni di pronuncia e talvolta anche di lessico, è condivisa da una comunità molto più ampia (così, il fiorentino medievale si è affermato nell’intero territorio italiano, diventando da dialetto lingua; mentre il veneziano, pur vitalissimo anche attualmente, non ha certo livellato i dialetti veneti di terraferma, che restano gelosamente autonomi dalla parlata del capoluogo regionale).
– Ci sono zone d’Italia in cui i dialetti sono più vivi e altre in cui sono praticamente scomparsi? Quali sono le ragioni fondamentali di queste differenze?
I dialetti sono molto vitali nell’Italia meridionale (in particolare: Campania, Calabria, Sicilia) e in Veneto; le regioni con massima percentuale di italofoni sono la Toscana − data la contiguità con l’italiano standard− il Lazio e la Liguria (in entrambi i casi grazie alla presenza di grandi realtà urbane che hanno conosciuto forti correnti migratorie da altri territori, col conseguente annacquamento dei dialetti originari); i dialetti sono relativamente deboli anche nelle grandi città di Lombardia e Piemonte, a partire da Milano e Torino, per ragioni analoghe. Storicamente, il dialetto si è mantenuto meglio in realtà che hanno conosciuto un insediamento tipicamente agricolo, che favoriva gruppi di parlanti concentrati in piccole comunità, spesso a debolissima alfabetizzazione; un idioma superregionale (la « lingua ») si è invece diffuso soprattutto in grandi realtà urbane, aperte ai traffici, con buon indice di scolarizzazione e con relativo benessere economico.
– Possiamo affermare che il ricorso al dialetto rispetto a quello della lingua standard abbia sovente una valenza emozionale (il dialetto sarebbe in questo caso uno strumento più idoneo a esprimere le sfumature dell’emozione della lingua standard, sentita come più neutra)?
Sì. È ben noto come i parlanti in grado di padroneggiare lingua e dialetto (nel 2006 si trovavano in questa condizione il 33% delle persone con più di 6 anni, parlando « in famiglia » o « con amici », e oltre il 18% di persone a contatto « con estranei ») ricorrano al dialetto per dare sfogo a sentimenti prorompenti (tipicamente rabbia, ma anche tenerezza nel rivolgersi a bambini piccoli, o magari all’animale di casa, cane o gatto).
– Considera possibile insegnare un dialetto?
No, sarebbe un’imposizione velleitaria e antistorica. Il dialetto deve restare il veicolo tipicamente orale proprio di una comunità ristretta, legato alla manifestazione dei sentimenti e all’espressione dei vincoli di appartenenza. Può naturalmente essere oggetto di studio scientifico, ma non deve entrare nelle aule scolastiche.
– Nella didattica, si fa spesso riferimento alla nozione lingua standard come al modello cui un buon parlante dovrebbe attenersi. L’italiano standard di oggi è diverso da quello, per esempio, di trent’anni fa?
Sicuramente si è allentata la presa del modello scritto, anche in conseguenza del maggiore allargamento della massa di popolazione scolarizzata. A parte la scuola, in cui la sanzione interviene tuttora nelle prove scritte (la produzione orale è guardata da sempre con grande tolleranza), il parlato domina largamente l’orizzonte linguistico attuale. Basta pensare alla televisione che da tempo porta dentro le nostre case spezzoni di italiano reale, preso dalla strada, senza il filtro proprio degli anni Sessanta quando il parlato televisivo era soprattutto quello degli annunciatori o degli attori di sceneggiati, attentamente modellato sulla pronuncia standard.
– Qual è stato, a Suo parere, il contributo del “berlusconismo” nell’evoluzione del linguaggio e della comunicazione?
Non parlerei di un contributo propriamente linguistico. Diverso il caso della comunicazione politica: questa è stata indubbiamente condizionata dallo stile di Berlusconi e dal suo insistito presentarsi come un campione dell’antipolitica (autoproclamatosi estraneo a quello che egli stesso amava chiamare il « teatrino della politica »). Si tratta di un abile marketing politico, che ha fortemente influenzato anche le forze di sinistra, spingendole a scendere, peraltro con limitate fortune elettorali, sul suo stesso terreno espressivo.
– Lei è socio dell’Accademia dei Lincei e dell’Accademia della Crusca. Qual è la funzione di queste prestigiose istituzioni oggi? Quali sono le nuove problematiche che devono affrontare?
È difficile rispondere in due parole. L’Accademia dei Lincei è la più prestigiosa accademia scientifica d’Italia e una delle più autorevoli del mondo. Fondata nel 1603, prevede oggi un selezionato numero di soci divisi in due classi − le scienze e le lettere − e svolge tra l’altro il compito di promuovere la ricerca scientifica e dare riconoscimenti alla cultura e alle arti anche attraverso premi e borse di studio. L’Accademia della Crusca nacque una ventina d’anni prima allo scopo di individuare la lingua eletta (identificata nel fiorentino trecentesco), realizzando nel 1612 un grande vocabolario storico, il primo mai tentato per una lingua europea; oggi svolge attività di ricerca superiore in ambito storico-linguistico e filologico, insieme a un apprezzato servizio di consulenza per le scuole e anche per singoli interessati.
Intervista a Luca Serianni, di Francesca Sensini








































